#baricco letteratura scrivere
Text
12esima: A. Baricco, Mr. Gwyn, Feltrinelli
Da Enrica Lieta riceviamo la recensione del romanzo di Baricco Mr. Gwyn.
Eccola.
Non trovando in biblioteca “Abel,” l’ultimo libro di Baricco, mi sono ‘accontentata’ di “Mr. Gwyn”, romanzo pubblicato dallo stesso autore nel 2011. E la lettura si è rivelata una piacevole sorpresa.
Il protagonista, Mr. Gwyn, è uno scrittore di un certo successo che vive a Londra, ma, ad un certo punto, comunica,…

View On WordPress
#Alessandro Baricco#baricco#feltrinelli#leggere#letteratura#lettori#lettrici#modella#mr gwyn#romanzi#scrittore#scrivere
0 notes
Quote
Lo decide chi vince, quando una guerra finisce.
“Senza sangue” di Alessandro Baricco
#vincere#guerra#battaglia#alessandro baricco#baricco#senza sangue#citazioni baricco#frasi baricco#libri baricco#amore#innamorarsi#amare#libro#letteratura#letteratura italiana#scrivere#scrittore#scrittrice
39 notes
·
View notes
Link
Quel libro è Bartleby lo scrivano di Herman Melville, un racconto che torno a sfogliare spesso; credevo semplicemente per affetto, ma ora penso che sia perché non l’avevo mai compreso davvero. Perché c’era qualcosa che mi attirava, ma che non riuscivo del tutto a decifrare. E quella cosa era una frase, la frase più iconica del testo, una battuta che pronuncia il protagonista e che riesce a condensare, soltanto in tre parole, la caratterizzazione di un personaggio, una filosofia di vitae una critica sociale: “Preferirei di no“.
Del resto, che non l’avessi capito può essere comprensibile, considerando che i letterati si sono parecchio spesi nel tentativo di analizzare il significato di questo enigmatico racconto, precursore della letteratura dell’assurdo, che vede un copista dall’aria strana e immobile declinare ogni richiesta rivolta dal suo datore di lavoro, un brillante avvocato di Wall Street, con una semplice e flautata dichiarazione: “Preferirei di no“.
La storia si apre con Bartleby che viene assunto in un ufficio per svolgere una mansione che, come dice Alessandro Baricco, è “il grado zero dell’emozione“. L’avvocato (che è anche la voce narrante) sostiene di essere rimasto fin da subito impressionato e incuriosito dal suo modo di essere flemmatico e imperturbabile, così diverso dagli altri suoi collaboratori, Turkey, Nippers e Ginger Nut, che invece si mostrano ambiziosi, insolenti e a tratti irritanti.
Ma l’atteggiamento di Bartleby non è solo una semplice nota caratteriale, bensì una scelta di azione, che si traduce in un rifiuto tenace e costante di fronte a qualsiasi imposizione esterna.
Mentre il narratore descrive l’incredulità e la rabbia di chi lo circonda, il licenziamento, lo sfratto e, in conclusione, la reclusione del protagonista in prigione, sembra che in ogni pagina stia chiedendo ai suoi lettori: cosa ci distingue dalla massa e cosa invece ci rende indipendenti e unici?
Quasi tutti sono stati d’accordo nel considerare il racconto in anticipo sui tempi (è stato pubblicato per la prima volta nel 1853 sulla rivista Putnam’s Magazine), essendo un testo che tratta questioni come l’insoddisfazione, la frustrazione e la depressione sul lavoro. Al tempo stesso molti lo vedono come un’opera dai tratti autobiografici, visto che quando uscì Bartleby Melville si stava riprendendo dal fallimento di Moby Dick (il libro sarebbe diventato un classico dopo quasi mezzo secolo dalla sua pubblicazione), romanzo che non sembrò convincere il pubblico come i suoi precedenti Taipie Omoo.
Secondo questa interpretazione, l’avvocato dovrebbe rappresentare il lettore comune, che desidera che Melville continui a “copiare” i suoi primi lavori, mentre l’autore risponde che “preferirebbe non farlo”, smettendo infine del tutto di scrivere.
Quel che è certo è che la figura di Bartleby risulta ipnotica e mistica, per la sua “signorile nonchalance cadaverica, nello stesso tempo risoluta e controllata”, ma soprattutto per la sua capacità di schierarsi contro l’autorità, di dire di no, che sembra una cosa semplice, ma invece semplice non lo è proprio per niente. E non lo è in nessuna circostanza quotidiana, magari proprio a lavoro, pensiamoci: quante volte ci sentiamo nella posizione di poter rifiutare con serenità? È o non è una possibilità reale quella di potersi sottrarre a una richiesta (non per negligenza, ma per motivi che noi stessi riteniamo validi)?
Almeno per me, sono rarissime, se non quasi inesistenti, le situazioni in cui mi sento libera di dire no. Dalle scelte più futili e apparentemente innocue, come un’uscita o un saluto rapido in tempo di Covid, a quelle più decisive e importanti, quelle che, in fondo, mi rendono la persona che sono. Non solo: Bartleby sa dire di no con un atteggiamento pacifico e distaccato, sa imporsi con autorevolezza senza ricorre alla prepotenza (è forse questa l’età adulta?).
Insomma, Bartleby come Gandhi, come Martin Luther King, come Leymah Gbowee. In alcune letture questo personaggio è stato accostato addirittura alla figura di Cristo, alla filosofia di disobbedienza nonviolenta thoreauviana, all’immagine dell’artista alienato e sfruttato (Bartleby è pagato per compiere un lavoro meccanico e ripetitivo: copiare), ai lavoratori vittime di un sistema oppressivo, al pensiero esistenzialista sull’assoluta mancanza di significato della vita.
Imperscrutabile e irrisolto, anche alla fine del racconto, Bartleby non svela niente di sé, non dà risposte né insegnamenti. Resta fedele a se stesso, non si piega, non asseconda chi lo vuole comandare. Come qualunque persona in grado di resistere o, meglio, di esercitare una leggera ma sostanziale resistenza. Una presa di posizione, un atto di volontà, di autodeterminazione. Un modo per occupare il proprio spazio e dire, di fronte all’insensatezza di tutto il resto, “io ci sono, esisto”.
0 notes
Link
28 mag 2020 20:20
''LAVORARE PER GLI AGNELLI NON VUOL DIRE VENDERE IL CULO'' - MICHELE SERRA NON LASCIA ''REPUBBLICA'' (PER ORA), ANCHE PERCHÉ NESSUNO GLI HA FATTO ALTRE OFFERTE. E RICORDA UN DATO: MAURO, CALABRESI E MOLINARI HANNO TUTTI DIRETTO ''LA STAMPA'' AGNELLOIDE PRIMA DI ARRIVARE AL QUOTIDIANO DI SCALFARI, E NESSUNO HA DATO LORO DEI ''VENDUTI'' - MA LA BOTTA DI SNOBISMO, INCURANTE DELLA CRISI GLOBALE, GLI SCAPPA IN CHIUSURA: ''TANTO POTREI CAMPARE AMPIAMENTE CON LETTERATURA, TEATRO E AGRICOLTURA''
-
Lettera a Michele Serra per la sua rubrica su ''il Venerdì - la Repubblica''
«Caro Michele, non ho mai perso una tua Amaca. Si contano le pochissime volte che ho dissentito da te, ma veniamo al sodo. Come nel film di Forman, Jack Nicholson dice al Grande capo: che ci facciamo noi qui, Grande capo? Ecco, che ci fai ancora lì, a Repubblica intendo? Che ci fate tu, Merlo, Augias, De Gregorio, Rampini e aggiungi chi vuoi? Sembrate bei quadri appesi in un’abitazione che non è stata pensata per voi. Quello non è più posto per voi. Siamo in tantissimi a pensarla così. Insieme a Lerner, Deaglio, da qualche altra parte, ricominciate, per favore. Vi seguiremo di sicuro».
Nicola Purgato
Caro Nicola, scelgo la tua lettera, per la brevità e la precisione polemica, in rappresentanza delle tantissime sul tema “che succede a Repubblica”. A quasi tutte sono riuscito a rispondere privatamente. Non l’avevo ancora fatto in questa rubrica perché il lasso di tempo (otto giorni) che trascorre tra la sua stesura e la sua pubblicazione è lunghissimo; temevo, insomma, che il succedersi dei fatti rendesse superate, una settimana dopo, le mie parole. Ora spero che le cose si siano un poco assestate. Scrivo questa nota venerdì 22 maggio sperandoche quando le leggerete, il 29 maggio, non sia accaduto niente di così clamoroso da renderle “vecchie”.
La prima cosa da dire è che ho totale rispetto per la scelta di Lerner e Deaglio. Sono entrambi grandi giornalisti e il primo è, per me, tra gli amici più stretti. La seconda cosa da dire è che pretendo identico rispetto – non un grammo di meno – per chi ha scelto di rimanere in un giornale che considera casa propria, punto di riferimento per un numero di lettori ancora importante nonostante la crisi dell’informazione a pagamento ne assottigli i ranghi mese dopo mese. Quelli che rimangono, dunque. Sto parlando non solo del Fondatore e di Ezio Mauro, direttori dei primi quarant’anni di Repubblica.
Ma di tutte le firme storiche (Augias, Aspesi, Valli per citare solo alcuni dei “senatori”) e di quelle raccolte strada facendo, Altan, Baricco, Rumiz, Merlo, Recalcati, Saviano, io stesso e molti altri. Non faccio vita di redazione e dunque non ho il polso del “corpo vivo” del giornale, delle assemblee, dei malumori, delle voci di corridoio. Ma ci siamo parlati molto, in queste settimane, specialmente dopo il licenziamento, traumatico nei tempi e nei modi, di Verdelli, e dopo l’addio di Lerner. Ha prevalso l’opzione “Repubblica siamo noi”, che prevede di continuare a fare il nostro lavoro come l’abbiamo sempre fatto, e dunque di confrontarci con Maurizio Molinari nello stesso identico modo con il quale ci siamo confrontati con i precedenti direttori.
Non considerandolo pregiudizialmente un “invasore”, o un corpo estraneo, ma il nostro primo interlocutore, come legittimamente è ogni direttore. Le discussioni quotidiane sulla fattura del giornale, sulla sua linea politica, sulle ambizioni (e sulle vanità) delle “grandi firme” sono il suo mestiere, la sua croce e la sua delizia. Spetterà a lui conquistare sul campo, oppure no, la fiducia dei giornalisti e dei lettori. Sa benissimo di trovarsi di fronte a una platea consolidata e agguerrita. Molti temi, soprattutto di politica internazionale, saranno occasione di acceso dibattito (una per tutte: le imminenti elezioni politiche americane, nelle quali il match populismo-democrazia vivrà una pagina decisiva).
Vorrei ricordare ai lettori, a questo proposito, che nelle più arroventate questioni politiche recenti (i referendum di Renzi,per esempio), Repubblica non ha avuto, e per fortuna, una “linea” univoca, da quotidiano di partito. È stata sede di un dibattito vero, acceso e ampio, con i commentatori divisi tanto quanto i lettori. Quanto all’editore. Ogni editore è ingombrante, e quello attuale, che è una multinazionale con radici italiane, ma trazione mondiale, lo è ancora di più.
I miei editori, per la cronaca, sono stati, in quasi mezzo secolo di giornalismo, il Partito comunista (il più ingombrante di tutti), il gruppo Espresso, la mitica “Cuore corporation” fatta in casa, la multinazionale televisiva Endemol e la multinazionale americana Condé Nast. Il solo editore che ho rifiutato a priori, per mia irriducibile ostilità, tra l’altro molto precedente la sua “discesa in campo”, è Berlusconi. Per il resto non mi sono fatto mancare niente, né mi sono sentito ingabbiato da alcuno, anche se spesso, come in ogni mestiere capita, ho vissuto conflitti, frizioni, incomprensioni, delusioni. Non vedo perché dovrei rifiutare a priori, come editore, un Agnelli.
Dalla direzione della Stampa, proprietà di famiglia ben prima dell’acquisto di Gedi (e ci scrivevano Bobbio, Galante Garrone, Barbara Spinelli, Carlo Petrini) provengono due direttori di Repubblica, Mauro e Calabresi. Molinari è il terzo. Lo stesso Lerner è stato vicedirettore della Stampa per qualche anno. Nessuno ha mai pensato che “lavorare per gli Agnelli” abbia significato, per loro così come per altri, vendere l’anima, o come direi al bar, il culo. Chiedo a voi lettori, con una certa decisione, mettendo sul piatto anche il mio quasi mezzo secolo di reputazione, di non pensarlo adesso. Giudicate il giornale da come sarà fatto.
Se non vi piace più, trovatene uno migliore, ne avete facoltà. Punto. Ogni editore è un padrone. Valeva anche per la famiglia De Benedetti, alla quale tutti noi di Repubblica riconosciamo, nella difesa dei propri interessi extra-editoriali, una sostanziale discrezione. Quanto al nuovo padrone, e al direttore da lui insediato,vi rimando alla collezione delle ultime due settimane di Repubblica per stabilire se sulla vicenda, nevralgica, governo-Fca, il giornale sia stato imbavagliato oppure abbia dato ampio spazio (vedi l’intervista a Orlando, le cronache politiche quotidiane, le risposte di Augias ai lettori) alle polemiche e alle critiche, compresa quella – sostanziale – sul “domicilio fiscale” di Fca in Olanda.
Da ultimo, una nota personale.
Non saprei su quale altro giornale scrivere per due ragioni fondamentali. La prima è che non ne conosco altri che mi siano ugualmente familiari, e idealmente vicini. La seconda è che nessuno mi ha chiamato per propormi alcunché, e questo mi fa sperare che, a quasi sessantasei anni, nel caso venisse meno il mio lavoro di giornalista potrò serenamente invecchiare dedicandomi alla letteratura, al teatro e all’agricoltura. Quanto mi basta, ampiamente, per campare, e soprattutto per essere felice.
Sul Venerdì del 29 maggio 2020
0 notes
Quote
Succede. Uno si fa dei sogni, roba sua, intima, e poi la vita non ci sta a giocarci insieme, e te li smonta, un attimo, una frase, e tutto si disfa. Succede. Mica per altro che vivere è un mestiere gramo. Tocca rassegnarsi. Non ha gratitudine, la vita, se capite cosa voglio dire.
Alessandro Baricco, “Oceano Mare”
#alessandro baricco#quote#oceano mare#mare#oceano#libro#romanzo#baricco#letteratura#poesia#sogni#vita#filosofia#scrittori#leggere#scrivere
0 notes
Text
Sergio Endrigo, il cantautore senza compromessi. Dialogo con Piergiorgio Viti, autore di un tributo dedicato al grande artista
Quando penso a Sergio Endrigo, il cantautore della saudade all’italiana, mi viene in mente una frase di Emil Cioran che parla del dispiacere di “essere vissuto da sempre con la nostalgia di coincidere con qualcosa, senza, a dire il vero, sapere che cosa”. La nostalgia delle canzoni di Endrigo non è ricordo, è come un desiderio di qualcosa che non abbiamo vissuto e non vivremo mai. Direbbe ancora Cioran: “È nostalgia del paradiso, senza avere conosciuto un solo attacco di vera fede”. Endrigo è stato perseguitato da una falsa immagine di sé: il pubblico lo considerava un cantante triste, e questo marchio doloroso gli ha negato il successo di massa, solo sfiorato per una manciata d’anni, quelli sanremesi. Ma il rapporto con la Rai, che organizzava il Festival ed era l’unico canale percorribile se si voleva avere successo, fu pieno di inciampi. Nel 1963, la commissione giudicatrice s’indignò per l’espressione “Vacche magre”, contenuta nel brano Viva Maddalena. Due anni dopo, la stessa commissione, presieduta dal maestro Razzi, bocciò la canzone Teresa, perché includeva il termine “mica”, ritenuto non idoneo alla lingua italiana (forse perché richiamava una certa rima?). Endrigo fu costretto a farne una versione RAI in cui il verso incriminato: “Teresa, non sono mica nato ieri” diventava “Teresa, la vita è solo un’avventura”. Nel 1970, durante il festival di Sanremo, la sua canzone L’Arca di Noè fu duramente attaccata dai cattolici, Padre Ugolino in testa, che sentenziò: “Non lascia nessuno spiraglio alla speranza”. Una curiosità: lo scorso dicembre sono stato a Milano e ho scoperto che il numero 34 di via Broletto non esiste. Il luogo dove il protagonista della celebre canzone di Endrigo spara alla sua amante (un forellino rosso sotto il cuore, rosso come un fiore…) è un luogo immaginario). Anche di quello potremmo avere nostalgia.
Per discutere di Endrigo ho contattato Piergiorgio Viti, autore dello spettacolo La voce dell’uomo – Un tributo a Sergio Endrigo, messo in scena con la regia di Vanni Semplici. Viti insegna italiano, storia e geografia in una scuola media di Porto Recanati. Scherzando, mi ha detto che si tratta di un hobby, perché il suo vero mestiere, quello che ha in testa tutto il giorno, è il poeta. Chiacchierando, il discorso è scivolato via su un altro tema: poesia e cantautori.
Nel 2015 hai pubblicato una raccolta poetica il cui titolo, Se le cose stanno così, è un omaggio a Sergio Endrigo, un cantautore che ha musicato testi di poeti, tra i quali vanno citati Rafael Alberti, José Martí, Lawrence Ferlinghetti, Vinicius De Moraes, Giuseppe Ungaretti. Nel 2020 hai scritto lo spettacolo La voce dell’uomo – Un tributo a Sergio Endrigo, messo in scena con la regia di Vanni Semplici. Cosa ti lega al cantautore di Pola? Gusti, tematiche, vicende umane?
Endrigo è di una versatilità eccelsa: saprebbe rendere canzone anche una ricetta sul pollo al curry. Passa con disinvoltura da un genere all’altro, da un tema all’altro con nonchalance, rimanendo Endrigo. È uno dei motivi per cui lo ammiro, il fatto di rimanere sé stesso sempre, come probabilmente fu in vita come uomo; un tipo, insomma, da zero compromessi e sicuramente anche per questo accantonato, relegato alla damnatio memoriae. Penso mi leghino a Endrigo due aspetti fondamentali: il voler lavorare, artigianalmente direi, sulla parola (in questo percorso, per fortuna, non sono da solo, penso a molti bravi poeti che, spesso lontano dal mainstream, dall’‘industria poetica’, lavorano anch’essi in modo artigianale, quasi da orefici, sul testo); poi, mi lega a Sergio una dose q.b. di nostalgia (dolore per il ritorno, secondo l’etimologia). Provo spesso nostalgia e mi sono chiesto tante volte di che. Probabilmente, sono nostalgico di qualcosa che ho perduto o non ho mai avuto. Non chiedermi che cosa, non lo so: penso abbia a che fare con l’archè, con l’età dell’oro, con i miei antenati, qualcosa di irrecuperabile eppure radice.
Quanti episodi di collaborazione tra poeti e cantanti conosci? Io, pochissimi. Pier Paolo Pasolini scrisse per Modugno i versi di Che cosa sono le nuvole. Endrigo e Luis Bacalov musicarono venti testi di Gianni Rodari, molti dei quali fanno parte di un album di successo intitolato Ci vuole un fiore. Dal sodalizio tra il poeta Roberto Roversi e Lucio Dalla nacquero tre dischi: Il giorno aveva cinque teste (1973), Anidride solforosa (1975) e Automobili (1976). Per il resto, poeti e scrittori non hanno mostrato alcun interesse ad accostarsi al mondo cantautorale. Per colpa di invidie mal celate, ritrosie, elitarismi, o cosa?
Jim Morrison partì proprio dalle sue poesie per comporre quelli che sarebbero diventati i successi dei Doors. Ungaretti tradusse alcune poesie di Vinícius de Moraes in italiano. Un cantautore italiano che ha sempre lavorato, un po’ un unicum, a stretto contatto con la poesia è Marco Parente, che infatti, ho letto da qualche parte, perché ne avevo perso le tracce, uscirà a breve con una performance dedicata a Dino Campana. Mi vengono in mente questi esempi di collaborazione, probabilmente ce ne saranno altri, non tantissimi a dire il vero; questo nonostante anticamente la poesia, prima di essere messa in forma scritta, venisse cantata (dagli aedi). Perché ora siamo arrivati a questo punto? Più che invidie, ritrosie, elitarismi, semplicemente penso che oggi tutto sia sottoposto alle dure regole del mercato discografico: potresti scrivere, tu poeta, il testo della canzone più bella del mondo, ma se poi ha un’intro troppo lunga o non rispetta i canoni rigidi del pop, le radio non te la passano, quindi? Ha senso una collaborazione se il poeta deve fare ciò che un paroliere o un cantautore è in grado benissimo di fare da solo?
Fabrizio De André è presente nelle antologie scolastiche, eppure ha scritto quasi sempre in collaborazione con altri (Bubola, De Gregori, Fossati) e molte canzoni sono traduzioni di brani di Georges Brassens e cantautori francesi. Persino il suo verso più famoso, Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior, riecheggia un antico detto buddista. Intendiamoci: a me piace, ma dopo la sua morte ha subito un processo di mitologizzazione che rende difficoltoso, se non impossibile, uno studio filologico dei testi.
Purtroppo, e lo dico da insegnante, nelle antologie scolastiche spesso si fanno scelte discutibili. Ad esempio, a parte rare e luminose eccezioni, viene del tutto ignorata la poesia dialettale, che invece è centrale nella nostra letteratura. Potrebbe esistere, oggi, un buon manuale senza un Baldini, un Loi, un Franzin, che hanno scritto pagine meravigliose utilizzando il dialetto? Non solo: nelle antologie scolastiche viene ignorata per esempio la poesia femminile (penso alla Rosselli, alla Oppezzo, ma non solo), e del tutto eclissati i poeti più significativi che hanno operato fuori dall’Italia, come se fuori dalla penisola non si scrivesse. Quindi, cosa dovrebbe fare un buon insegnante? Andare oltre le antologie. Su De André, che dirti, mi è sempre piaciuto, ma gli preferisco l’originale (scherzo), cioè Brassens. E poi, mi sta bene la sua mitologizzazione (anche se, come te, fatico a comprenderla), però a questo punto mitizziamo anche Lauzi, Bindi, Tenco, Graziani, Ciampi, Endrigo. E per par condicio, infiliamoci pure loro nelle antologie scolastiche, magari in un percorso ‘interdisciplinare’, tuttavia sempre di difficile attuazione nella scuola italiana, dove ancora esistono, parola orrenda, le ‘materie’.
Mario Luzi non ha avuto il Nobel, Bob Dylan sì. Mi ricordo che Baricco disse: “È un grandissimo cantautore ma, per quanto mi sforzi, non capisco che cosa c’entri con la letteratura”. Non riesco a dargli torto e penso che bisognerebbe istituire delle nuove categorie di premi, ad esempio per i testi delle canzoni o per quelli teatrali (analoga polemica si scatenò con l’assegnazione del Nobel a Dario Fo). Perché se il Nobel per la letteratura diventa un calderone della parola scritta, allora anche un pubblicitario potrebbe conquistarlo.
Non ho mai considerato il Nobel come cartina di tornasole di quello che succede in letteratura. Raymond Carver, uno dei miei scrittori preferiti, non l’ha mai vinto, per esempio. Così come non lo hanno mai vinto Borges, Calvino, Tolstoj, Joyce, la Yourcenar, ecc. Cosa voglio dire? Che il Premio Nobel è un premio come un altro, assegnato da persone che amano la letteratura come me e te. La letteratura non è matematica: il gusto personale è, appunto, qualcosa di confutabile, a differenza dei risultati di una divisione o di una sottrazione. Nicola Crocetti, famoso editore e traduttore, raccontò, ospite a Recanati, molti aneddoti sul Nobel, e per l’Italia, mi ricordo, disse che il referente dell’Accademia svedese era, fino a pochi anni fa, un semplice professore di italiano che insegnava all’estero.
Per Vecchioni, “I poeti hanno visto la guerra / con gli occhi degli altri / che tanto per vivere han perso la pelle. / Così scrivon piangendo cipolle / su barbe profetiche intinte nel vino / che pure gli serve” (I poeti, 1975). Per Bertoli, “Il poeta è un uomo stanco che si sveglia a mezzogiorno / che si affaccia dal balcone e si guarda appena intorno / insicuro e sempre incerto si trascina alla sua tana / caffelatte con le uova che la mamma gli prepara” (I poeti, 1981). Infine, per De Gregori, “Alcuni sono ipocriti e gelosi come gatti / scrivono versi apocrifi, faticosi e sciatti. / Sognano di vittorie e premi letterari / pugnalano alle spalle gli amici più cari” (Poeti per l’estate, 1985). Quanti stereotipi, e quanto disprezzo per una cultura alta con cui non si mangia!
Molti degli stereotipi sul poeta risalgono al Romanticismo: chiuso solo nella stanza, è lì che compone versi, isolato da tutto e da tutti. Penso siano idee fuorvianti, da rigettare o quantomeno da aggiornare! Il poeta, in quanto testimone della società in cui vive, deve, appunto, vivere, non isolarsi in una torre d’avorio, a meno che non stia scrivendo. Quindi, il poeta moderno, nella mia visione, dovrebbe essere esperto, o quantomeno curioso, di tanti argomenti (non si può scrivere nulla su ciò che non si conosce!) perché, soprattutto, non può permettersi il lusso di essere monocorde (e parlare solo di natura, per esempio); dovrebbe viaggiare molto, perché stimolato dal confronto con luoghi, persone, abitudini diverse; dovrebbe informarsi su quanto accade nel mondo, affinché la complessità del mondo diventi la complessità del suo pensiero e del suo linguaggio; soprattutto dovrebbe leggere, leggere parecchio, non solo poesia, ovviamente.
Francesco Consiglio
*Piergiorgio Viti vive in Italia, a Porto Recanati, dove è professore di lettere. Nel 2011 ha pubblicato la prima raccolta poetica, Accorgimenti, mentre nel 2015, per Italic, esce Se le cose stanno così. Ha scritto per il teatro: La fiabola di Virginio e Virgilio con Tosca protagonista, e I sogni di Ray con Carlo Di Maio. È andato in scena come autore e voce recitante ne La voce dell’uomo, un tributo al cantautore Sergio Endrigo. Ha tradotto I Preludi di Alphonse de Lamartine, letti da Ugo Pagliai e Paola Gassmann per il festival ‘Armonie della Sera’. Nel 2020 ha partecipato, unico italiano, al progetto internazionale ‘Infusions poétiques’ dell’artista Cécile A. Holdban, con altri 170 poeti di tutto il mondo. Il progetto prevedeva che ogni poeta, durante il lockdown causato dalla pandemia COVID-19, scegliesse un proprio verso pieno di fiducia e di speranza per il futuro; il verso è stato illustrato dall’artista su dei sacchetti da tè assemblati in un unico, grande tappeto, dalle gigantesche dimensioni. Il progetto è stato presentato nello spazio Andrée Chedid, a Issy-les-Moulineaux.
L'articolo Sergio Endrigo, il cantautore senza compromessi. Dialogo con Piergiorgio Viti, autore di un tributo dedicato al grande artista proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/3j3yw9x
0 notes
Text
Il blues del ragazzo bianco
Il blues del ragazzo bianco è il primo romanzo scritto da Paul Beatty nel 1996. Paul Beatty era nella mia lista di autori da scoprire da un po’, ma ho letto questo libro èerchè scelto da una delle persone con cui stavo facendo un club del libro.
Prima di comprarlo, avevo letto un po’ di cosa trattava ed ero enormemente interessata, negli utlimi due anni mi sono appassionata alla letteratura africana o afro-americana.
Chimamanda Ngozi Adichi è una delle mie scrittrici preferite e mi aspettavo che i romanzi di Paul Beatty fossero un po’ lo stesso genere, un modo di raccontare una realtà attraverso la vita di tutti i giorni, attraverso gli occhi di persone che certe realtà le vivono davvero, con i loro momenti belli e brutti.
Il blues del ragazzo bianco, narra la storia attraverso gli occhi del primogenito, di una famiglia che passa dai quartieri bene bianchi, al ghetto. Il background sembra promettente e lo stile di scrittura Paul Beatty è molto interessante, artistico, mi ricorda un po’ lo stile di Baricco, per intendersi.
Dal libro ho tratto infatti molte citazioni, se questo libro fosse un luogo, diremmo che è molto “instagrammabile”, ed è esattamente questa l’impressione che mi ha dato. Lo scrittore sa giocare con le parole, sa farti ridere, ma non sa farti riflettere. Ho trovato il contenuto del libro di poco spessore, e ogni pagina mi sembrava una autocelebrazione del saper scrivere, del saper raccontare, senza saper bene di cosa volesse parlare.
Sinceramente ho avuto difficoltà a finire il libro e non lo consiglierei come lettura.
0 notes
Photo

MAESTRO UTRECHT di Davide Longo NNEditore (2016)
Recensione di Claudio Montini da digitociochepenso.blogspot.com
Sin dai tempi dei classici greci, era in cui per convenzione eurocentrica si colloca la nascita della cultura cosidetta occidentale, il sogno di ogni insegnante è sempre stato quello di compilare il manuale definitivo, nelle intenzioni del compilatore anche perfetto, ad uso e consumo dei propri discepoli e di tutti coloro che sarebbero succeduti ad attingere a tal fonte del sapere. Fortunatamente, molti si sono limitati a concedere, a pochi eletti, appunti e schemi procedurali con cui preparavano di volta in volta le lezioni: in fondo ad ogni artista, del resto, si cela un solerte e permaloso artigiano geloso della propria sapienza conquistata in anni di gavetta e di prove ripetute. Altri si sono gettati stoicamente nell'impresa di mostrare al mondo come si fa a far fortuna quasi dovessero dettare le dosi per un pranzo di nozze regali: e guai a sgarrare, pena l'oblio e la dannazione eterna; alcuni, infine, hanno scelto una via ardua e impervia e fragile quanto un ponte di corda e assicelle di legno sospeso su un orrido (o burrone, se preferite), tappezzato di muschi e ribollente di schiuma di torrente impaziente di farsi fiume e correre al mare: costruire una storia o una serie di racconti che si intrecciano e si intersecano aventi come perno un personaggio ignoto e il suo investigatore, cacciatore e inquirente di una preda inconsapevole, per infarcirla di tutte quelle cose da trasmettere ai propri discepoli scommettendo sulla sensibilità critica e analitica del proprio uditorio, ovvero illudendosi che dall'esempio o dall'aneddoto tutti sappiano trarre la legge o la regola universale per il successo o, almeno, una pacifica soddisfazione. Purtroppo, è quel che accade a Davide Longo in MAESTRO UTRECHT (NN Editore, 2016) che confeziona una favola moderna alla Italo Calvino, quello dello stralunato Marcovaldo e del Castello dei destini incrociati, in cui è forte la anche la presenza dei tormenti di Cesare Pavese, con gli influssi della luna e i riverberi dei falò, così come le luci e le ombre di Carlo Cassola e Carlo Fruttero in cui anche la realtà è un'ipotesi poichè ognuno di noi, dello stesso fatto, ricorda e riferisce cose diverse destinate ad essere trascinate via dalla risacca instancabile, beffarda e implacabile del mare nel quale Hemingway andava a pescare e vedeva un vecchio sconosciuto e cocciuto cercare di farsi restituire un poco di fortuna o di riscatto rubato dai flutti e dai pescecani. Troppo bello per essere vero: infatti, si vira verso la trama di una puntata di CHI L'HA VISTO e il neorealismo per arrivare alla fine, già nota e scontata, la morte senza colpevoli e senza moventi di Maestro Utrecht che si è trasformato più volte, nell'aspetto e negli atteggiamenti, lasciando il lettore sempre più disorientato come se la storia fosse divenuta un labirinto di specchi da cui si esce, appunto, fermandosi di fronte al dato di fatto del rapporto di polizia sul decesso e sul funerale cui presenziano due poeti e una poesia per il defunto, unici testimoni del commiato di uno sconosciuto da questa valle di lacrime. MAESTRO UTRECHT è un pretesto per Davide Longo, già romanziere e autore di testi teatrali e radiofonici oltre che insegnante di scrittura alla Scuola Holden (fondata da Alessandro Baricco), per mettere in rassegna tutto quello che uno scrittore non, ripeto, non deve fare per provare a scrivere con un certo successo e soddisfazione propria e di chi lo andrà a leggere: un buon avvio giocato sul registro della favola surreale che, però, poi si perde per trasformarsi in indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e decisamente fuori dagli schemi; un pizzico di introspezione psicologica che non deve mai mancare, secondo i canoni della letteratura moderna; dialoghi serrati e scorrevoli, quando servono a disegnare ambienti e situazioni, staccando magistralmente (ci mancherebbe) dal soliloquio del narratore; l'esposizione dei proprio metodo di lavoro e uno spiraglio sulla vita privata dell'autore come a scusarsi del fascino morboso per l'esistenza altrui; una bella citazione riportata senza rivelare la fonte, riguardo al rapporto tra l'essere umano e l'amore (quel passo mi è sembrato di averlo già letto altrove, ma non ricordo dove...), la quale rende magnifico e altamente lirico il finale di un capitolo che comincia a mostrare la fatica di uscire dal labirinto delle ipotesi con le poche prove e testimonianze racimolate, mentre la vita reale prosegue e bussa alla nostra porta con le sue esigenze. A questo punto, il lettore si aspetta il colpo di scena, il lampo di genio, l'idea non ponderata che, grazie alla fantasia sfrenata di cui lo scrittore dovrebbe essere proverbialmente dotato, colma i vuoti e unisce i segmenti e mette in ordine i dati raccolti dal cronista di vita altrui suggellando con grazia e garbo sovraumano la fiaba moderna da cui, nelle prime pagine, è stato piacevolmente attratto e affascinato: ma in MAESTRO UTRECHT il miracolo tipico del romanzo, questa volta, non si compie, come il sangue di San Gennaro che non si liquefa ma a Napoli la vita continua ugualmente. Se ai napoletani resta comunque intatta la fede nel loro santo patrono e la speranza che la prossima sia la volta buona, a me resta il piacere di essermi imbattuto in un bellissimo italiano, inteso come lingua della narrazione, con tutti gli elementi della frase e del discorso esatti e concordanti tra loro, mai ridondanti e mai ripetitivi e mai banali, supportati da una attenta e intelligente punteggiatura che da vita a una prosa avvolgente, affascinante e lieve tanto da scorrere per gli occhi nella mente (talvolta anche nell'anima) come acqua fresca e dolce e pura e viva per chi ha attraversato il deserto di Atacama in cerca delle sue rose. Forse Davide Longo in MAESTRO UTRECHT (NN Editore, 2016) le ha trovate o forse si è arreso al rotolare del cerchio della vita [...] perchè tutto scomparirà, amici miei [...]come una nave che poco a poco si allontana dalla costa (pag.156). Io, invece, le sto ancora cercando perchè non mi accontento di un bel giro di parole ma cerco, in uno scritto, quel che tutte le campane andranno a sfidare, che gli inni sacri a glorificare, che va gridando forte nei portoni che sta nella natura e nella bellezza, quel che non ha giudizio nè mai ce l'avrà, quel che non ha paura nè mai ce l'avrà, quel che non ha misura... (Ivano Fossati)
© 2017 Testo di Claudio Montini © 2017 Foto di Orazio Nullo
0 notes
Quote
All’inizio ci sono le storie.
Le vediamo, le sentiamo. Ci accadono intorno. Finché non sentiamo il bisogno di scriverle, di fermarle perché non se ne vadano.
Alessandro Baricco
0 notes
Quote
Sembrava racontasse la vita di un'altra.
“Senza sangue” di Alessandro Baricco
#raccontare#racconto#storia#vita#senza sangue#alessandro baricco#baricco#citazioni baricco#frasi baricco#libri baricco#vivere#amore#innamorarsi#amare#libro#letteratura#letteratura italiana#scrivere#scrittore#scrittrice
24 notes
·
View notes
Text
Senza sangue di Baricco
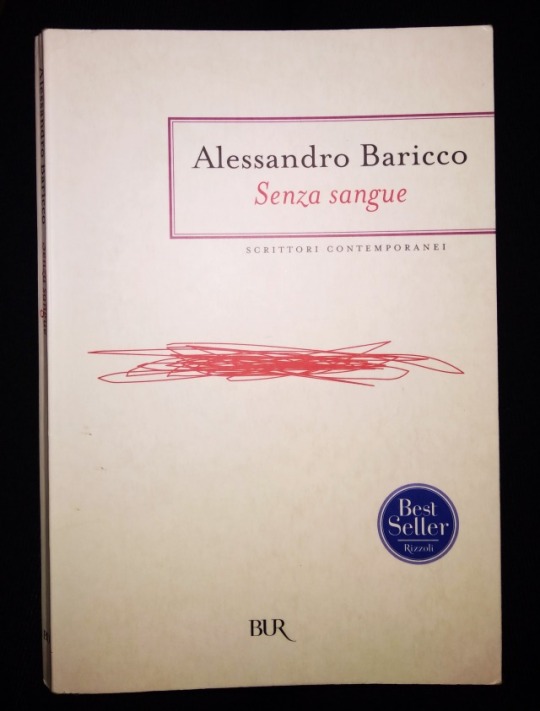
Semplicemente.. una vicenda particolare raccontata in maniera semplice per spiegare un’esperienza comune a tutti: il ritorno alla paura, a ciò che ci ha spaventati durante la nostra infanzia, qualcosa che nemmeno ci ricordiamo ma per cui proviamo una grande attrazione. Un ritorno senza sangue.
Il libro è abbastanza corto, 100 pagine all’incirca, luogo e tempo imprecisati, nessuna introspezione psicologica dei personaggi: li conosciamo soltanto attraverso le loro vicende che vengono raccontate in modo oggettivo, come se fossero dei semplici fatti di cronaca, e sono quelle loro azioni che ci fanno capire il loro carattere, le loro paure, i loro pensieri.
Due capitoli.
Nel primo troviamo Manuel Roca, suo figlio e sua figlia Nina, la protagonista della storia. Vivono in una fattoria. Una vecchia Mercedes passa vicino alla fattoria. Arrivano quattro uomini. Sparano e uccidono Manuel Roca e suo figlio, mentre Nina è nascosta in una botola. Uno dei quattro uomini, Tito, trova la bambina rannicchiata sul fianco, con le mani nascoste tra le cosce. La lascia lì. Escono dalla fattoria. Il capo della banda dà fuoco alla fattoria. Nina si salva.
Nel secondo capitolo troviamo come protagonisti una vecchia signora, Nina e un vecchio che vende biglietti per la lotteria in un chiostro, Tito. I due personaggi si rincontrano, parlano del passato, Nina non se ne ricorda, sa solo quello che le hanno raccontato. Eppure si ricorda di Tito, quel giovane ragazzo che l’aveva trovata nella botola. Vanno in una stanza d’albergo, fanno l’amore.
Passano la notte insieme. Nina si tira le ginocchia verso il petto, stessa posizione che aveva quando stava nascosta sotto la botola. La posizione di una vecchia bambina. Dalla finestra si vede l’insegna rossa dell’albergo, che assomiglia ai bagliori di una casa in fiamme, che ricorda l’incendio da cui Nina si è salvata per miracolo. Ma lei non si ricorda niente, glielo hanno solo raccontato. Si ricorda solo di Tito.
Per concludere, ecco una delle frasi che meglio spiega il succo della storia: “Allora pensò che per quanto la vita sia incomprensibile, probabilmente noi la attraversiamo con l'unico desiderio di ritornare all'inferno che ci ha generati, e di abitarvi al fianco di chi, una volta, da quell'inferno, ci ha salvato. Provò a chiedersi da dove venisse quell'assurda fedeltà all'orrore, ma scoprì di non avere risposte. Capiva solo che nulla è più forte dell'istinto di tornare dove ci hanno spezzato, e a replicare quell'istante per anni. Solo pensando che chi ci ha salvati una volta lo possa poi fare per sempre. In un lungo inferno identico a quello da cui veniamo. Ma d'improvviso clemente. E senza sangue.”
Una lettura da fare!!
- nora @onlylove-here
#recensione#libro#letteratura#leggere#scrivere#scrittore#scrittrice#lettura#libridaleggere#libridaamare#senza sangue#alessandro baricco#baricco#citazioni baricco#frasi baricco#libri baricco#paura#amare#amore#orrore#istinto#terrore#passione
18 notes
·
View notes
Text
Nel Salone del Libro on line c’è tutto, tranne i libri, ormai inessenziali. Beh, io torno a leggere Landolfi, mi insegna che “l’impossibile è poi sempre possibile”
Il Salone (salotto, salumificio) Internazionale del Libro di Torino, non si ferma (una delle conseguenze più nefaste della pandemia è l’abbrutimento ulteriore della nostra vituperata lingua). Anzi, torna a palesarsi in una forma ancora più inquietante e angosciosa. Là dove il libro perde la sua essenza, importanza e funzione. Là dove è tutto griffato, dove non c’è nulla, dove non ci sono, i libri. L’emergenza sanitaria e tutto quel che ne è conseguito, non ha portato una virgola, una parentesi, un apostrofo di saggezza o riflessione, anzi, ha partorito e continua a partorire mostri. Venendo finalmente al punto, il mostro del Salone (appunto) si palesa in streaming. Sui social. Tra gli hashtag. Con gioia e giubilo dei presenti, degli invitati, degli organizzanti. E di questo giubilo non è facile cogliere da fior fiore. Ma tocca farsi del male. Nicola Lagioia, il cosiddetto direttore artistico: “Nel dolore la consapevolezza, nell’amore la conoscenza. Qualche giorno fa, in una delle ore più buie, confuse e dolorose per il nostro paese e per il mondo intero, il gruppo di lavoro del Salone Internazionale del Libro di Torino ha fatto un sogno: riunire alcune delle migliori menti del pianeta per ragionare insieme su ciò che sta accadendo”. Sorvolando sulla retorica da discount dell’ovvio. Per ‘migliori menti’ si intendono Lilli Gruber, Roberto Saviano, Alessandro Baricco, Paolo Giordano e no, non riesco a proseguire. Ma passiamo a Dario Franceschini: “l’iniziativa degli organizzatori di coinvolgere, in una anticipazione, alcune delle voci più interessanti del panorama culturale, rappresenta una preziosa occasione di riflessione e condivisione”. Condivisione cui significato è oramai peggiore di qualsiasi virus e, sulle voci più interessanti, toccherebbe sorvolare se non si fossero testè succitate. Per poi arrivare (e qui mi fermo) alle vere e proprie minacce, per voce del Presidente della Regione Piemonte: “Un giorno non molto lontano dei libri racconteranno quello che stiamo vivendo”. Come se la letteratura e la poesia fossero mero e banale ostaggio, omaggio o reportage della noiosa realtà circostante e non discese negli e dagli inferi dell’animo umano e dai mondi e di mondi inesistenti. Come se non ci fossero ancora migliaia di libri da leggere (e credo nessuno dei quali presente ai Saloni che furono e che saranno) senza la necessità che ne venga scritto anche solo un altro.
*
Ma mentre il Salone (in quanto entità spaventevole e spaventosa) dichiara “non si legge solo sui libri” (vergato in patetico maiuscolo), io ne prendo tra le mani uno, nelle cui meravigliose pagine dovrebbero perdersi tutti. Per capire cosa significa scrivere, il significato dello scrivere. Il libro è Rien va, il secondo dei tre volumi che tessono il diario (che andrebbe mandato a memoria) di Tommaso Landolfi, assieme a La biere du pecheur e Des mois (tutti editi da Adelphi, che ha rimesso in vita l’immortale scrittore di Pico). E queste parole, che lette e rilette, sarebbero sufficienti a spazzar via tutta la (succitata) ambizione e presunzione: “Quando l’idea sia venuta, e a suo tempo mi si sia articolata nel capo, a me sembra di aver fatto sin troppo e che il mio lavoro sia finito e che sia indispensabile un po’ di riposo; il resto è faticosa, odiata, inutile, amministrativa e subìta necessità esteriore, come il recarsi in un sordido ufficio governativo per sbrigarvi una pratica. Il pensiero che la mia idea possa o debba essere comunicata ad altri non mi sfiora neppure, in un primo momento, non già per dispregio degli altri, sibbene perché nessuno potrà mai convincermi della loro esistenza, e sarebbe difficile disprezzare ciò che non esiste; e anche perché, ammettendo in via del tutto ipotetica la loro esistenza, non riuscirei, in buona fede, per la modestia e insipienza insieme, a concepire che qualcuno avesse bisogno della mia idea. In un secondo momento, si capisce, insorgono necessità volgari pesanti benché illusorie, che possono indurmi a darle forma sensibile, cioè a tutti manifesta; il che non si può fare in qualche modo mediato, quando non per via di successivi tradimenti. Al tutto si aggiunge una specie di spregio, spregio del mio lavoro e spregio del mio lavoro quale necessità impostami, che può talvolta menarmi a buttar via di proposito il meglio come non conveniente o troppo superiore ai datori di lavoro”. I lettori non esistono ed è uno spreco buttar via le parole troppo superiori per i datori di lavoro (leggasi editori). Ma voglio andare avanti.
*
Landolfi è una miniera, un tesoro, un mondo. Landolfi che quando oramai ha raggiunto un disinteresse rispetto all’esito dei suoi libri prossimo all’indifferenza (siamo nel 1960), impone che dalla raccolta Se non la realtà (allora edito da Vallecchi) i suoi lavori vengano pubblicati in un’edizione tutta bianca, senza risvolti, senza quarta di copertina con vergata tale ineguagliabile postilla: “L’autore, stanco di sentirsi attribuire dai critici (o almeno dai più grossolani tra essi, e in ogni caso da chi poco lo conosce) la paternità o l’ispirazione degli scritti per consuetudine stampati in questa sede (i quali lo trovano bene spesso dissenziente), ha pregato l’editore di sostituirli d’ora in avanti colla seguente dicitura: RISVOLTO BIANCO PER DESIDERIO DELL’AUTORE”. Oggi in calce abbiamo gli indirizzi dei social. Il vanto d’esser stati partoriti da qualche scuola di scrittura. E il bisogno spasmodico di apparire ed esserci ovunque e dovunque. Pensiamo ancora una volta con orrore ai libri che verranno (come non bastassero le pagine vacue, vuote, inutili scritte in questi ultimi due mesi dagli stessi che banchettano al Salone virtuale, virtuoso, virulento). E poi ritorniamo e concludiamo con Landolfi che, tra i tanti racconti di inaudita beltà, era capace di inaugurare una delle sue raccolte (in questo caso Racconti impossibili), con una storiella surreale e spassosa composta con parole presenti in qualsiasi dizionario italiano ma sconosciute ai critici prezzolati e tronfi d’allora (i cui figli ancora più prezzolati e tronfi imperversano ora). Ne saggiamo l’incipit: “La mia moglie era agli scappini, il garzone scaprugginava, la fante preparava la bozzima … Sono un murcido, veh, son perfino un po’ gordo, ma una tal calma, mal rotta da quello zombare o dai radi cuiussi del giardiniere col terzomo, mi faceva quel giorno l’effetto di un malagma o di un dropace! Meglio uscire, pensai invertudiandomi, farò magari due passi fino alla fodina. In verità siamo ormai disavvezzi agli spettacoli naturali, ed è perciò da ultimo che siam tutti così magoghi e ci va via il mitidio. Val proprio la pena d’esser uomini di mobole, se poi, non che andarsi a guardare i suoi magolati, non si va neppure a spasso!… Basta. Uscii dunque, e m’imbattei in uno dei miei contadini, che volle accompagnarmi per un tratto. Ma un vero pigo! In oggi di quegli arfasatti e di quelle ciammengole o manimorce, ve lo so dir io, non se ne trova più a giro; né servon drusce per farli parlare, ma purtroppo hanno perso anche la loro bella e pura lingua di una volta. Recava due lagene”. Il racconto è La passeggiata, e su tale racconto lo stesso scrittore, successivamente, stila la meravigliosa conferenza personalfilologicodrammatica con implicazioni dove dimostra, dinnanzi a un ridicolo e grottesco tribunale, che La passeggiata contiene, appunto, parole tutte presenti nel dizionario italiano. E che i cosiddetti critici che avevano chiosato e ridicolizzato il suo racconto attribuendogli una lingua inventata, non si fossero in realtà nemmeno posti il dubbio che tali parole potessero trovarsi in qualsivoglia dizionario. “Molto semplicemente che l’impossibile è poi sempre possibile: se, difatto, coloro o costoro avessero avuto il benché minimo dubbio relativamente a una sola delle vessate parole, se di conseguenza si fossero avveduti che codesta parola era regolarmente registrata in qualsivoglia dizionario scolastico, essi le avrebbero cercate tutte e in tutte avrebbero riconosciuto in significato inequivocabile, né si sarebbero per avventura coperti di vergogna con bolse sentenze. Ma c’è di più e di peggio. Ammettiamo che al critico non sia richiesto un particolare fiuto filologico… Amici, guardiamoci in faccia: alle brutte un fiuto letterario, questo personaggio che si autoproclama interprete dell’opera altrui, un fiuto letterario dovrà averlo?”. Fiuto letterario. Quello che manca, che non esiste, che non si percepisce nel Salone Letterario, in chi vi partecipa, in chi vi sguazza, in chi vi sfoggia le griffe e le marchette. Si fiuta solo l’odore di muffa. La vera letteratura è altrove. I libri sono altrove. E invocare quelli che verranno, vuol dire non saper nemmeno dove si trovi, quell’altrove. Quell’altrove che Landolfi ha tramutato in poesia.
Cosimo Mongelli
L'articolo Nel Salone del Libro on line c’è tutto, tranne i libri, ormai inessenziali. Beh, io torno a leggere Landolfi, mi insegna che “l’impossibile è poi sempre possibile” proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/3dR9Yya
0 notes
Text
“Ho sempre sognato di essere uno scrittore minore”. Giulio Mozzi dialoga con Francesco Consiglio su: editoria, scrittura, oracoli, un romanzo che scrive da vent’anni
Il governo ha chiuso le scuole per l’emergenza Coronavirus, e così, ferme le lezioni al liceo e al conservatorio, mia figlia ha la possibilità di andare a letto tardi e svegliarsi tardi. Il blocco delle lezioni, vissuto dalle famiglie come una tragedia (ho capito che la scuola non serve a insegnare ma a parcheggiare i figli), ha avuto su di me un effetto effetto anti-age – che meraviglia! – riportandomi ai tempi in cui, insieme a lei, mi sciroppavo ore di cartoon. Ieri sera, io e la studentessa in congedo abbiamo visto un film su Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr. nel ruolo dell’investigatore e Jude Law nella parte del dottor Watson. Da vero uomo del mio tempo, con un occhio alla tv e l’altro sullo smartphone, curiosavo su vibrisse, il blog di Giulio Mozzi. E proprio mentre Sherlock Holmes diceva: “I piccoli dettagli sono di gran lunga i più importanti”, io leggevo: Giulio mozzi è nato il 17 giugno 1960. Con la minuscola.
Possibile che lui, un curatore editoriale con la maiuscola, non si sia accorto dell’errore? No, impossibile. Il mio quinto senso e mezzo mi dice che l’ha fatto apposta, come Gozzano che nella Via del rifugio scrive così di sé:
“Ma dunque esisto! O Strano!
vive tra il Tutto e il Niente
questa cosa vivente
detta guidogozzano!”
Facendo diventare il Poeta un io minuscolo, con tanti saluti a D’Annunzio e alla sacralità della letteratura. Ecco, mi è sembrato che anche Giulio Mozzi volesse fare altrettanto, prendersi gioco di sé stesso e della sua condizione di scrittore. E Dio sa, in un mondo di automaiuscolandi, quanto c’è bisogno d’ironia e di gioco.
Qui sotto, l’intervista. Bella o brutta non lo so, ma è tanta roba.
Hai pubblicato raccolte di racconti, un paio di libri in versi, manuali di scrittura, ma se chiedo in giro chi è Giulio Mozzi, probabilmente mi sentirò rispondere: “Un insegnante di scrittura”. Molti diranno: “Un ottimo insegnante di scrittura e il più bravo scout letterario che abbiamo in Italia”, ma è proprio questo che volevi quando hai cominciato a scrivere? In una pagina a te dedicata sul sito di una libreria online hai scritto: “Non ho mai desiderato essere uno scrittore; e non lo desidero neanche adesso”. Ma qualche riga sotto dici anche: “Raccontare delle storie è una cosa importante per me”. Insomma, mi fai friggere il cervello.
Sono due desideri diversi. Desiderare di “essere uno scrittore” significa, secondo il senso meno nobile dell’espressione, desiderare di acquisire un certo status; secondo il senso più nobile, significa decidere di dedicare la propria vita primariamente alla scrittura. Io questa scelta non l’ho fatta. Dopo i miei primi tre libri di racconti, Questo è il giardino del 1993, La felicità terrena del 1996 e Il male naturale del 1998, ho avuto la sensazione di aver finito il mio lavoro. Ho continuato a scrivere in parte per inerzia – vedi un libro come Fantasmi e fughe, del 1999, quasi inutile – e in parte per cercare novi modi, un nuovo senso della scrittura: con Il culto dei morti nell’Italia contemporanea, del 2000, dove tentavo la composizione in versi, e Fiction, del 2001, dove mi interrogavo su che cosa diavolo sia, in effetti, la finzione. Poi mi sono fermato. Da lì in poi ho fatto libri occasionali, pamphlet, quella strana cosa che è Sono l’ultimo a scendere e altre storie credibili, del 2009 – un libro tutto diverso dai precedenti: e conta gli anni di distanza – e poi con Favole del morire, del 2015, ho finito di raccogliere tutti i pezzi sparsi. Ci sarebbe il romanzo al quale sto lavorando, ininterrottamente e con tantissime esitazioni, dal 1998; al momento – poiché ha cambiato tanti titoli – si chiama Le ripetizioni. Ma, in realtà, negli ultimi vent’anni non ho fatto altro che lavorare nell’editoria e insegnare. In questo momento, tra me e la scrittura c’è come una parete; devo trovare il modo di abbatterla.
Quando avevo vent’anni e abitavo in Sicilia, a due passi dall’Olympeion della splendida Akragas, avevo più possibilità di sentirmi vicino a Zeus che a qualunque abitante del Parnaso delle lettere patrie. Se avessi voluto parlarti, potevo scrivere a uno dei tuoi editori e supplicarli di darmi il tuo indirizzo, o telefonare a tutti i Giulio Mozzi presenti sull’elenco telefonico. Oggi basta un clic per bussare alla porta della tua casa digitale, al tuo blog o al profilo Facebook. Mi chiedo se questa esposizione mediatica, che è comunque una scelta, ti abbia portato dei vantaggi (che io riesco a immaginare in contatti con i lettori e promozione delle tue attività) o se invece ti senti vittima dell’invadenza dei tanti questuanti letterari in cerca di un padrino che li faccia pubblicare.
Sul risvolto del mio primo libro, nel 1993, lì dove di solito si mette la biografia dell’autore, c’era scritto: “Giulio Mozzi è nato nel 1960. Abita a Padova in via Michele Sanmicheli 5/bis” (oggi non abito più lì). Se avessi voluto parlarmi, sarebbe bastato cercare sull’elenco del telefono o passare all’ufficio postale per scoprire il codice di avviamento. La mia scelta di “esposizione”, come tu la chiami – e mi sembra una parola ben trovata – risale a diversi anni prima che l’internet diventasse popolare, a sette anni prima che decidessi di dar vita in rete al mio “bollettino di letture e scritture” vibrisse. Grazie a quella scelta ho avuto la fortuna di essere il primo lettore di alcuni autori che ebbi poi il privilegio di accompagnare alla pubblicazione; e quindi la fortuna di scoprire un lavoro, particolarissimo, per il quale evidentemente avevo qualche talento. E poi: diventai amico di Laura Pugno – ancora prima: nel 1988 – perché da un’indicazione di luogo, dopo aver letto il suo primissimo libro di poesie – poi da lei abiurato – riuscii a risalire al suo telefono. Allo stesso modo, dopo aver letto un suo libricino pubblicato da un editore davvero minuscolo, riuscii a incrociare Vitaliano Trevisan. Ricordo ancora l’emozione di quando un giovanotto mi mandò un racconto brevissimo, due o tre pagine, accompagnandolo con una domanda: “Io studio da avvocato, ma la mia futura moglie dice che forse farei meglio a dedicarmi alla letteratura” (cito a memoria): era Diego De Silva. E dovrei lamentarmi perché ogni tanto incrocio qualche rompiscatole? Se ne trovano di più al supermercato.
Quando un critico parla di “libro necessario”, mi vengono in mente quegli incontri di boxe frettolosamente definiti “match del secolo”. Quanti ne abbiamo visti nel secolo scorso? Almeno una decina. Ora, a parte che bisognerebbe chiedersi se la letteratura sia veramente necessaria e provocatoriamente affermare che sono esistiti più popoli senza letteratura scritta di quanti non ce ne siano stati senza religione, penso che bisognerebbe essere più parchi nel parlare di necessità. Un religioso conventuale, il gesuita Carlo Sanseverino, scrisse in un suo libro sugli antichi filosofi pagani: “Non è libro necessario al genere umano. No: senza questo mio libro si può cenare, e dormire lietamente, ed essere un buon cristiano”. Ecco, un pizzico di umiltà non guasterebbe.
Fu Giangiacomo Feltrinelli, credo, a coniare l’espressione “libri necessari”. E intendeva, credo, libri politicamente necessari – con un’idea di politica che era quella onnicomprensiva di quei tempi. Peraltro, di capolavori ne spuntano giusto un paio al secolo. Poi, certo, ci sono dei libri che magari sono importanti per una generazione – per la generazione mia per esempio, è stata importante l’opera di Pier Vittorio Tondelli: ma l’affetto non può impedirci di vederne, oggi, i limiti. Quanto a me, il mio sogno segreto è sempre stato quello di essere uno scrittore minore.
La storia della letteratura è piena di scrittori assolutamente folli, autodistruttivi nei confronti di sé stessi e degli altri, ostili al contatto umano, randagi della vita. Te lo immagini un redivivo Dino Campana, che sua madre chiamava “l’anticristo”, mentre discute le modifiche di un contratto di edizione? E Virginia Woolf, vittima di crisi depressive e profondi sbalzi d’umore, avrebbe retto allo spostamento di una virgola o al taglio di una frase imposta dal suo editor? Giacomo Leopardi, così cupo e indecifrabile, avrebbe passato più tempo sulle “sudate carte” o nello studio di uno psicoanalista, con il ricco genitore che gli pagava le sedute? Non è un tempo per folli, evidentemente. Eppure Allan Poe ha scritto: “Mi hanno chiamato folle; ma non è ancora chiaro se la follia sia o meno il grado più elevato dell’intelletto”.
La storia della letteratura è piena anche di scrittori assolutamente normali, tranquilli, buoni borghesi, addirittura affaristi o filantropi. E sospetto che siano in larga maggioranza. (Quanto alle domande: i periodi ipotetici dell’irrealtà non mi interessano).
Oggi è possibile stampare da soli il proprio libro e metterlo in vendita sul web senza il supporto di un editore. L’autopubblicazione è sempre esistita, d’accordo, ma la novità consiste nell’opportunità data al lettore di acquistare con lo stesso semplice clic l’ultimo romanzo di Baricco o il manuale di ricette di Nonna Pina che un nipote smanettone è riuscito a stamparle con Kindle Direct Publishing. Parrebbe una grande libertà, un ribaltamento dei ruoli di forza tra editore, distributore e autore, eppure il self publishing continua a essere considerato il rifugio dei mediocri.
L’autopubblicazione continua a essere considerata il rifugio dei mediocri perché, oggi, è effettivamente il rifugio dei mediocri. Non dubito che possano esserci buoni libri tra gli autopubblicati; ma la massa, per quel che vedo, è roba che non vale nulla, gli editori fanno benissimo a non pubblicarla: ne pubblicano già troppa, anche loro, di roba che non vale nulla. E a chi vuole liberarsi di loro ricordo che gli editori (a) mandano i libri nelle librerie, cosa che con l’autopubblicazione è difficilissimo fare; (b) fanno un sacco di lavoro di comunicazione; (c) fanno, anche se non sempre, un lavoro di “collocazione” dell’autore nel panorama editoriale e nel mondo culturale; (d) contribuiscono, con la loro identità – o quel che ne resta – all’identità dell’autore e del libro; eccetera. Senza contare che un autore, per dire, potrebbe essere affezionato, per motivi suoi, a un certo catalogo, o a una certa grafica, o a un certo modo di produrre e promuovere i libri, e così via. Rappresentarsi gli editori come pure e semplici sanguisughe è da disinformati. Poi, certo: non sono tutte rose e fiori. Non c’è nulla, nella vita, che sia rose e fiori.
Mi chiedo però cosa impedisca a uno scrittore mediamente noto (ma di quelli che non prendono lauti anticipi) di autopubblicare e percepire una royalty che arriva al 70% sul prezzo di copertina.
Naturalmente, tutto dipende da che cosa cerca un autore. Se uno cerca soldi, si comporterà in un modo. Se cerca successo, si comporterà in un altro. Se cerca di entrare nei circoli più esclusivi di una certa società letteraria, si comporterà in un altro ancora. Se cerca l’abbraccio caldo dei lettori, si comporterà ancora diversamente. A me, per esempio, per stare al piano materiale, dei soldi che posso guadagnare direttamente con i libri importa poco. M’importa invece che i miei libri pubblicati mi qualifichino come professionista: dello scouting, dell’editing, dell’insegnamento. Perché di queste tre cose effettivamente vivo. So perfettamente che i miei libri vendono poco, e mi pare anche logico che sia così. Non mi passa neanche per l’anticamera del cervello di fare un’opera in un certo modo anziché in un altro per vendere di più. Anche un libro come l’Oracolo manuale per scrittrici e scrittori (a cui sta per seguire un Oracolo manuale per poete e poeti, fatto a quattro mani con Laura Pugno), che può sembrare concepito unicamente per un ragionamento di mercato (e in effetti sta vendendo benino), per me è stato importante soprattutto perché mi ha permesso di riflettere sul mio lavoro di insegnante. Qualcuno – ora non ricordo chi – l’ha definito più o meno come “una dichiarazione di poetica travestita da manuale di scrittura”. E mi sta bene.
Francesco Consiglio
*Giulio Mozzi è nato il 17 giugno 1960. Abita a Padova. Si è diplomato presso il Liceo-Ginnasio ‘Tito Livio’. Ha svolto il servizio civile alternativo al servizio militare presso la Casa del fanciullo di Padova. Dal 1982 al 1989 ha lavorato nell’ufficio stampa della Confartigianato del Veneto. Dal 1989 al 1996 ha lavorato come fattorino-magazziniere presso la Libreria internazionale Cortina di Padova. Dal 1996 al 2001 ha campato essenzialmente di corsi e laboratori di scrittura e narrazione. Dal 1997 al 1999 ha collaborato con la casa editrice Theoria. Dal 2001 ai primi mesi del 2009 è stato consulente per la narrativa italiana di Sironi Editore. Nel 2006 ha dato vita, con un gruppo di generosi amici, alla casa editrice in rete vibrisselibri, ora di fatto cessata. Dal 2008 al 2014 è stato consulente di Einaudi Stile Libero. Dal 2009 al 2013 ha collaborato con l’Istituto per la sperimentazione didattica ed educativa (Iprase) della provincia di Trento. Attualmente è consulente di Marsilio Editori per la narrativa italiana. Nel 2010 ha iniziato una collaborazione amichevole con Laurana Editore, dalla quale è nata nel 2011 la Bottega di narrazione. Ha scritto per il teatro, soprattutto per la compagnia di teatro per bambini (ma non solo) Fantaghirò; e per il teatro musicale, in collaborazione con Vociferazioni.
L'articolo “Ho sempre sognato di essere uno scrittore minore”. Giulio Mozzi dialoga con Francesco Consiglio su: editoria, scrittura, oracoli, un romanzo che scrive da vent’anni proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/2TMUi6w
0 notes
Text
#SPECIALE: Come gli scrittori vedono Michel Houellebecq. Il caso di Yasmina Reza. “La vita con gli occhi di un uomo oscuro e qualunque, risolutamente pessimista”
Nell’immenso e profondissimo abisso di Cahier (La Nave di Teseo, 2019), l’ultimo libro uscito su Houellebecq – in verità, uno dei pochissimi disponibili in lingua italiana –, davvero non mancano le sorprese per gli appassionati. In mezzo alla ricostruzione della vita privata e artistica, spiccano i contributi di alcuni suoi colleghi che ci aiutano a rispondere alla domanda: “Come vedono Michel Houellebecq gli altri scrittori?”. Naturalmente, parliamo di altri grandi. Se si trattasse di italiani – i soliti asserviti al pensiero unico –, potete stare certi che le opinioni corrisponderebbero a un coro disarticolato di schiamazzi e invettive. È memorabile in tal senso la recensione di Baricco, a pochi giorni dall’uscita di Sottomissione, che bocciò il testo senza appello. Ma Baricco è Baricco, e di lui non ce ne frega onestamente un cazzo. Molto più interessante è conoscere l’opinione di Yasmina Reza – una sorta di versione femminile di Houellebecq, ma prevalentemente orientata verso la scrittura teatrale.
La Reza è una drammaturga – in primis – e romanziera francese. È nota al grande pubblico soprattutto per una sua opera, Il dio del massacro, che ha ispirato il grande Roman Polanski in Carnage. Ciò che colpisce di lei è l’affinità con il narratore di Le particelle elementari. Entrambi focalizzano la loro attenzione sul mondo borghese in decadenza, funestato da nevrosi, votato all’apparenza, sempre sull’orlo del collasso o della crisi di nervi. Come riconosce la stessa: “è vero che ci sono senza dubbio echi e similitudini tra di noi”.
La vicinanza e ammirazione per Houellebecq emerge molto chiaramente in un’intervista rilasciata ad Agathe Novak-Lechevalier e incentrata proprio sul suo collega francese. La scrittrice inizia raccontando come è entrata in contatto con la sua opera allorché, da autrice già conclamata, si ritrovò a far parte della giuria del Premio France Télévision. Dei trenta libri preselezionati non gliene piacque quasi nessuno. Uno dei pochi a convincerla fu Estensione del dominio della lotta, il primo romanzo di Houellebecq. Anzi, in verità fu amore a prima vista: “Ho letto una pagina e alla fine mi sono detta: o è nullo e casca presto, o resta così ed è eccezionale”. Naturalmente si rese conto immediatamente che l’eccezionalità c’era e non scemava. Da quel momento, cominciò a leggere tutto ciò che riusciva a reperire dell’ancora poco noto scrittore. Allora il francese aveva già pubblicato alcuni volumi di poesia, un testo su Lovecraft e Restare vivi, un prontuario di sopravvivenza per giovani poeti. Ed è proprio in quest’ultimo che trova la motivazione della grandezza di Houellebecq, a suo avviso: “Una visione onesta e ingenua del mondo è già un capolavoro. Rispetto a questa esigenza, l’originalità conta poco. Non preoccupatevene. A ogni modo, un’originalità si sprigionerà per forza dalla somma dei vostri difetti. Per quanto vi riguarda, dite semplicemente la verità, né più né meno”. Purtroppo, gli altri giurati non furono del suo stesso avviso e non diedero la vittoria a Houellebecq, limitandosi a farlo arrivare in finale. “Tutti riconoscevano la forza del libro”, però “tendevano a dire che non era uno scrittore, più precisamente pensavano che sarebbe stato l’uomo di un solo libro […] Si considerava che Estensione fosse un’autobiografia, la confessione folgorante di un depresso”. Giustamente lei è rimasta con “la sensazione di un malinteso sull’avvenire”. A chi legge, invece, è probabile che venga qualche dubbio sulla qualità delle giurie letterarie .
Certamente la Reza è a un altro livello. Non le sfugge quel “suono molto personale su una materia banale […] la modernità del punto di vista”, “l’audacia” che sta nell’“invito a osservare la vita con gli occhi, non di un antieroe – ce ne sono molti – ma di un uomo oscuro e qualunque, né bello né brutto […] risolutamente pessimista”. La colpisce anche la figura di Tisserand, altra presenza importante del romanzo, probabilmente il primo incel della letteratura.
Ulteriore aspetto che le salta all’occhio è la vocazione sociologica del testo houellebecquiano che “sfugge dalla materia viva per trasformarla in trattato” – in ciò lei è decisamente distante dall’autore. In sintesi, “in Estensione si sente solo un’immensa libertà, come se non avesse avuto niente da perdere, come se non avesse nutrito alcuna speranza particolare sull’avvenire del suo libro”. Insomma, poco ma sicuro, Houellebecq non ha scritto, come la maggior parte dei nostri autori, per lusingare la platea e spiattellare puttanate politicamente corrette, seguendo la volontà del mercato – per fortuna, nel suo caso ha funzionato.
Non le importa nemmeno che le posizioni di questo siano assimilabili a quelle più reazionarie (“E perché no? Ma la cosa non ha poi tanto interesse: c’è ben altro”). A suo avviso un autore non deve per forza razionalizzare, diversamente dall’intellettuale, e può permettersi di maneggiare “costantemente istanze oscure”. In due parole, può esimersi dall’esprimere buoni sentimenti chiunque scriva utilizzando la forma romanzo – potrà sembrare una banalità dirlo, ma di questi tempi certe banalità hanno una portata rivoluzionaria. Anche perché se è pur vero che, a causa della sua “stanchezza della libertà”, Houellebecq risulta un uomo “antiliberale”, è altresì vero che questa è “la carne della sua opera, è il suo sangue” e ciò “non ha niente di ideologico”. In sostanza, non lo fa per darsi un tono, o per svolgere il ruolo di intellettuale organico del Front National: lui la pensa realmente così e non potrebbe scrivere altrimenti.
Dulcis in fundo, la grande drammaturga francese sghignazza amabilmente alla domanda se si sia sentita turbata dalle parole che Houellebecq spende sulle donne: “Mi ricordo delle sue descrizioni della donna che invecchia e la cui vagina pende come l’escrescenza sotto il becco di una gallina; ho riso, pensando ‘Bastardo!’ Ma è la sua libertà di scrittore: non deve trattare con i guanti”. Ecco, la Reza è la classica donna a cui non bisogna dire “e fattela una risata”. Ci riesce da sola. Il fatto è che lei è una vera scrittrice e una donna intelligente. Quelle che criticano l’autore di Serotonina sono semplicemente delle femministe. Non si può pretendere tanto da loro.
Matteo Fais
L'articolo #SPECIALE: Come gli scrittori vedono Michel Houellebecq. Il caso di Yasmina Reza. “La vita con gli occhi di un uomo oscuro e qualunque, risolutamente pessimista” proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/36AfIc0
0 notes
Text
Monica Rossi, l’editor che fa vendere milioni di copie ai suoi autori, disintegra le vacue velleità degli scrittori presunti e vi spiega come funziona l’industria editoriale
Leggo quasi per caso i post di Monica Rossi, pseudonimo. Ne deduco in fretta quel che vuole che si sappia di sé: ha a che fare con una CE importante, di professione editor, o direttore di collana, o direttore editoriale. Sfarzosa villa circondata dal verde, interni di gusto, vetrate allo studio, esterni forse pacchiani, con scalinate da architettura modernista e prato all’inglese. Deve essere di ottima famiglia. Per ottima intendo ricchissima. Ha studiato al Berchet. Ma questa è una mia intuizione senza fondamento. È un uomo di straordinaria intelligenza. Ha un tumore.
Scrive con schiettezza verità sull’industria editoriale, smaschera le personalità fragili degli autori, mette alla berlina il narcisismo che rappresenta la principale fonte di reddito del settore economico in cui lavora. Leggi Monica Rossi e capisci che il mondo del libro si fonda su quell’unico fattore di produzione: l’ego smisurato degli scrittori. È uno dei modi che il sistema capitalistico si è dato per trarre profitto dall’apparire. La vicinanza dei temi “libri” e “cancro” illumina, seppur con lentezza, ciò che rileva, per lui: la morte. Leggo i sui post e vedo la morte al lavoro.
Ho la sensazione che chiunque intraprendesse l’avventura di leggere Monica Rossi andrebbe incontro inesorabilmente a un unico destino: innamorarsene. Perché avere a che fare con la morte rende tutto autentico. L’autenticità ha questo potere di attrazione: costringe chi la incontra ad affidarsi, a sprofondarci dentro, a non volere uscirne mai.
Chi si nasconde dietro la maschera di Monica Rossi? “Se ti definisci scrittore vuol dire che, in concreto, quello è il tuo lavoro. Con i proventi dei tuoi libri ci paghi l’affitto, le bollette, la spesa, la macchina, le vacanze, i vestiti, la scuola per i figli? Allora si, sei uno scrittore. Se invece con i proventi dei tuoi libri ci paghi giusto una cena, una cassapanca, una borsetta, una vacanza o un motorino allora vuol dire che sei uno che fa tutt’altro e poi scrive”
Ho avuto il dubbio, leggendo i tuoi post, che tu in realtà fossi Aldo Busi, dopo un’opera molto attenta di travestimenti. Come rispondi a quest’accusa?
Beh, che non sarebbe un’accusa. E poi che sono assai più giovane, assai più bello e assai più etero. E lui sa scrivere, io no. Detto questo, permettimi di chiarire alcune cose. Io non sono un editor, non sono un direttore di collana e men che meno un direttore editoriale. Il mio lavoro è stato (è, sarà?) un altro. Tanti anni fa, casualmente e grazie ad amici comuni, mi è capitato fra le mani il testo di un autore sconosciuto. Ho capito che sarebbe potuto diventare un successo a patto di eliminare alcune parti e di approfondirne altre. Gli ho dato dei suggerimenti pratici su quali corde toccare e su quali tacere.
Quindi sei un editor…
Una sorta di. In sintesi – non essendo coinvolto – gli ho fatto vedere le cose dalla giusta prospettiva. Io capisco (o credo di capire) cosa potrebbe interessare alla gente e nello specifico cosa vorrebbe leggere e in che modo lo vorrebbe leggere. Ha venduto milioni di copie, mi ha riconosciuto una percentuale, la simbiosi è continuata e la voce si è sparsa. Da li si sono susseguite molte altre collaborazioni.
Milioni? Dici davvero, milioni? Chi è, la Rowling? Dan Brown? Gli autori che vendono milioni di copie e pur di italiani credo, se esistono, che siano al massimo un paio. Camilleri, pace all’anima sua, e con una sfilza di libri, forse Elena Ferrante, con una saga.
E ma che pignolo! Milioni era un’iperbole. Comunque si tratta di un numero di copie significativo, sommando il totale. Volo, Giordano, Faletti, Tamaro, Saviano, Carofiglio, Ammaniti, Piperno, Baricco, Carrisi… Potrei continuare. Tu sei a casa ora? Sei in ufficio? Se ti giri e vai verso la libreria di sicuro ci troverai almeno due testi frutto di alcuni miei ragionamenti o pensieri. Riscritti in bella copia da questo o quell’autore, s’intende. In ultimo, la mia famiglia era ricchissima. Di colpo, molti anni fa, ci siamo trovati in una condizione ben peggiore della povertà. Ovvero la miseria con i debiti. Poi però mi è capitato un testo tra le mani di un autore sconosciuto.
Come sopravvivere tra umani lenti di ragionamento e dall’orizzonte ristretto? Quali strategie adotti?
Mentendo, cammuffando, indossando maschere. Ma una volta. Ora inducendo la controparte a mentire, cammuffarsi e ad indossare maschere. È un gioco: se mi accorgo che le persone con cui devo avere a che fare sono ottuse, incompetenti o poco intelligenti è l’unico modo per combattere la rottura di palle di doverci avere a che fare. Se sono brillanti, preparate e intelligenti allora zero giochini: verità assoluta senza se e senza ma.
Hai la tendenza a non fidarti di chi elimina il sesso dalla propria riflessione. Ho l’impressione poi che la tua curiosità per abitudini, atteggiamenti, gusti e scelte sessuali sia un modo per affrontare le tue proprie. Esiste un legame tra le tue fantasie sessuali e la violenza?
Il sesso – fatto, immaginato o percepito – condiziona gran parte della nostra vita, dei nostri legami e del nostro inconscio. In quell’ambito non si può mentire. Dai gusti sessuali di una persona, dalle sue fantasie e da come fa l’amore si capisce tantissimo. Oserei dire tutto. Prima c’era Lombroso e poi si è passati al linguaggio del corpo. Ora sarebbe bastevole vedere la cronologia dei siti porno visitati, la frequenza e in particolare la categoria preferita. No, le mie fantasie (e pratiche) sessuali non contemplano la violenza, il dolore e la sottomissione fisica o mentale. La complicità, la gioia e il rispetto si. Questo non vuol dire che non possano essere comunque torbide e perverse. Anzi.
Dai, osa!
Intendi confessare le mie fantasie? Che poi sono diventate realtà? Ma manco morto.
Vorrei portarti a riflettere sulla differenza che c’è tra l’editoria come industria, settore economico che ha la sua dignità, e l’amore per i libri che accomuna certi lettori. Vorrei cioè farti parlare di letteratura. Intanto, è possibile o è un inganno? E quale rapporto esiste tra i due (editoria e letteratura)?
A oggi io non ho ancora capito che cosa sia la letteratura. O meglio, che cosa s’intenda per letteratura. So che esistono dei libri belli e dei libri brutti. So che un libro bello per me può essere un libro brutto per un altro. So che entrambi abbiamo ragione. So che è sbagliato pensare di avere più ragione. L’editoria è un’industria. E fra tutte è la meno dignitosa quando in modo codardo si nasconde dietro ad una delle parole più astratte ed equivocabili: cultura.
Ecco qui sta un punto chiave, proviamo ad articolare. La sensazione che ho io è che alcuni, da una parte della barricata, abbiano piena consapevolezza che l’editoria è un’industria, tutti gli altri (carne da cannone), no. Poi ci sono i lettori consumatori che credo facciano parte della seconda categoria.
Sostituisci ‘alcuni’ con ‘molti’ e hai articolato benissimo.
Se tu dovessi scrivere un libro come “Ritratti e Paesaggi” di Andrea Caterini, quali autori tratteresti? E in che modo?
Non potrei mai perché ne verrebbe fuori un mattone da 5.000 pagine. Però, visto che in quest’intervista si parla anche di morte allora parlerei di quelli che – ahimè, ahitutti – ci sono passati ma non ne possono scrivere. Quindi direi Calvino, Buzzati, Rodari, Cerami, Levi, Cassola e Vittorini. Che tratterei con amore. E poi Pasolini, Moravia, Eco e Pratolini. Che tratterei con sospetto.
Esiste un libro che ha sconvolto la tua vita, o ribaltato il modo di vedere le cose? Quale? In che modo ha agito su di te, quali le conseguenze?
A dodici anni, quando ho scoperto che mi piacevano le signorine ma non sapevo come conquistarle “Il manuale del Playboy” di Renzo Barbieri comprato con la mia paghetta settimanale mi ha insegnato un’attitudine. Che pare una cazzata, ma così è. E poi “The Underground City” di Harold ‘Doc’ Humes, padre del mio fraterno amico Malcolm Einaudi che mi ha insegnato a non essere prevenuto. La Bibbia, che considero il miglior trattato di psicologia mai scritto. Il Mein Kampf che considero il secondo miglior trattato di psicologia mai scritto. “Walden, ovvero La vita nei boschi” di Thoreau che mi ha aperto la mente. Quasi come il saggio “Nature” di Emerson ed in particolare il capitolo “Discipline”. In ultimo, anche se non è un libro – ma sono pur sempre parole scritte su carta e grazie al cielo corredate da immagini – tra i testi che mi hanno insegnato qualcosa non potrei non citare Le Ore.
Ecco, ti prego di perdonare la mia curiosità da comare, a proposito di Malcom, che rapporto c’è tra te e la famiglia Einaudi? E cosa pensi dell’avventura di Giulio?
Malcolm è una persona intelligente, competente e divertente. E poi ha quel senso dello humor così dannatamente inglese… Parlare con lui è un piacere. Sempre. Che rapporto c’è? C’è un buon rapporto, che altro bisogna sapere? Penso che Giulio sia stato un uomo con due palle così. Non scevro da errori.
Esiste un modo per parlare della morte, per raccontarla? O meglio, dato che mi pare che ovunque, anche nei tuoi contributi più sprezzanti e caustici, di quello stai parlando, qual è per te il modo migliore per parlare della morte?
Il miglior modo per parlare della morte è essere consapevoli che nessuno può parlarne. Buio totale? Chi può dirlo. Luce bianca e angeli biondi e sorridenti che ti prendono la manina? Chi può dirlo. Reincarnazione? Come sopra. Personalmente non ho nessuna paura dell’ignoto. Anzi, affrontarlo sarà un’avventura. La sofferenza fine a se stessa, quella può far paura. Ma è anche vero che può insegnare qualcosa e aiutare a guardarsi dentro e in profondità Intimamente credo che la vita non sia che un’esperienza minima dell’esistenza. Credo. Spero. Ma anche il buio totale non sarebbe così male. D’altronde quando suona la sveglia chi non vorrebbe continuare a dormire?
Forse hai frainteso. Non intendo per morte la vita dopo una soglia uguale per tutti. Intendo la limitatezza, la temporalità, l’essere fenomeni accidentali che dunque guardano il limite e non l’assoluto. Lo vedo in te perché nelle tue parole trovo sempre il pragmatismo che potremmo tradurre in: “niente retorica, guardiamo alle cose come stanno”.
Ah! Allora il miglior modo per raccontare la morte è vivere. Che è l’esatto contrario di sopravvivere.
Sostieni che la distribuzione è uno dei principali fattori di successo (di vendite) di un libro. Con il tuo solito stile ironico e pratico, raccontaci (nei particolari) un caso di successo, un esempio di ottima distribuzione e uno di perfetta distruzione.
Un caso di successo: prendi un uomo di circa quarant’anni, sconosciuto, aggiungici un padre scrittore ben inserito nel mondo editoriale, un amico d’università che fa il critico letterario, una casa editrice autorevole, un ufficio stampa che non lascia nulla al caso e adotta tecniche evolute, la creazione a tavolino di siti e blog che osannano un libro basato sui luoghi comuni, su una città, impostato sulla semplicità e sulla banalità con interi paragrafi copiati dai film più conosciuti. Ecco come otterrai 2,3 milioni di dollari all’esordio prima ancora che il tuo libro venga pubblicato. E molti altri dopo. Marketing ad alti livelli. Chapeau. Mi riferisco a “City on fire” di Hallberg pubblicato da Knopf. Ripetibile? Complicato. E infatti ha scritto solo quel libro, quattro anni fa.
Un caso d’insuccesso: prendi un uomo di circa quarant’anni, conosciutissimo, aggiungici che è ben inserito in qualsiasi ambiente, che ha amici che occupano i posti di potere più ambiti, una casa editrice irrilevante, un ufficio stampa che adotta tecniche che Herbalife già scartava negli anni ’90, inutili post ripetuti ossessivamente su Facebook e Twitter che osannano un libro impostato sul nulla, scritto male (neanche da lui) e senza alcun filo logico. Ecco come otterrai un anticipo che per l’editore sarà un bagno di sangue ed un numero di copie vendute del tutto irrisorie. Tipo 400. Mi riferisco a “Io sono Matteo Salvini” pubblicato da Altaforte.
Mi sembra però che tu qui parli di promozione. La distribuzione che ruolo gioca?
C’è poca da dire a riguardo: in Italia un editore è anche il principale distributore. E voilà.
L’industria editoriale sembra allevare cavalli nell’epoca dell’avvento dell’automobile. Come uscirne?
Perché uscirne? Ci sono cavalli che non chiedono altro, all’inizio…Poi ci sono i muli, all’inizio e a metà… E per finire gli asini, dall’inizio alla fine e oltre… Detto per inciso: ho tre asini adorabili. Arturo, Grock e Alfonso.
Stai dicendo che l’industria editoriale serve solo alla vanità degli scrittori?
Anche. Direi che essere pubblicati serve soprattutto ad illudersi di aver affermato il proprio io. ‘Sono stato pubblicato da Mondadori’ è il sogno di tutti gli scrittori. Non capiscono, anzi, peggio, lo capiscono ma non lo vogliono sapere, che essere pubblicato da Mondadori se poi Mondadori non punta su di te è peggio di essere pubblicati da Tiziocaio Edizioni. E poi c’è la competizione: un manoscritto su mille viene pubblicato. Ecco, tu non immagini sperare di essere quell’uno quanti soldi muove.
Alcuni pionieri stanno indagando strade nuove per fare editoria. Non ne cito alcuna, pensa tu agli esempi che ti sembrano più azzeccati. Cosa ne pensi?
Non ho pregiudizi se non verso chi prende per il culo quei poveretti che pensano che scrivere un libro possa cambiar loro la vita. Peggio chi continua a farlo illudendoli che prima o poi possa capitare. Tenendo così in sospeso le loro vite. E no, purtroppo non mi riferisco all’eap (editoria a pagamento), che è il male minore.
Ma allora, cerca di svelare l’enigma: lo scrittore è un mestiere? Ultimamente ha prodotto una certa cagnara la discussione sull’identità degli scrittori. Te la faccio breve con due esempi concreti e reali: un bravo economista che è anche ottimo giardiniere, dopo aver appreso le tecniche del giardinaggio ed essersi lungamente sperimentato, si considera ancora economista. Un bravo ingegnere che ha scritto un libro, pur continuando a campare con la progettazione industriale, si considera uno scrittore. A me questa cosa infastidisce. Mi sembra uno svuotare di dignità il lavoro inteso non solo come espressione di sé e del proprio talento, ma come impegno e responsabilità. Mi sembra un abdicare alla mentalità borghese o peggio élitaria da parte dei lavoratori, come se ci si vergognasse di essere operatori dei centri per l’impiego, manager d’impresa, addetti alla sicurezza, manutentori di giardini o postini.
Non sai quante discussioni a riguardo. Su questo punto sono intransigente. Se ti definisci scrittore vuol dire che, in concreto, quello è il tuo lavoro. Con i proventi dei tuoi libri ci paghi l’affitto, le bollette, la spesa, la macchina, le vacanze, i vestiti, la scuola per i figli? Allora si, sei uno scrittore. Se invece con i proventi dei tuoi libri ci paghi giusto una cena, una cassapanca, una borsetta, una vacanza o un motorino allora vuol dire che sei uno che fa tutt’altro e poi scrive. E allora no, non puoi definirti uno scrittore. Certo, puoi ‘sentirti’ uno scrittore. Ma è molto, molto diverso. Ancora, se con i proventi dei tuoi libri ci puoi comprare giusto un’automobile ma nel contempo insegni scrittura creativa, collabori con un quotidiano, hai un blog e fai tutto ciò che è inerente all’editoria e arrivi agevolmente a fine mese, beh mi spiace, non sei comunque uno scrittore. Oppure lo sei nella misura in cui se io mi riprendo col mio telefonino mentre faccio l’amore penso di essere Rocco Siffredi.
Un giudizio allora sulla Scuola Holden e sulla Bottega di narrazione.
In entrambe ci sono docenti che fanno questo lavoro con passione e trasparenza. Per contro alcuni, pochi a dire il vero, lo fanno esclusivamente per arrivare a fine mese. Direi che c’è di peggio. Ti piace scrivere? Ti piacciono i libri? Vuoi imparare le tecniche, non il talento? Vuoi condividere una passione comune ad altre persone? Frequentare le scuole di scrittura è una buona idea. Vuoi solo essere pubblicato? Vuoi solo scrivere un bestseller? Vuoi solo essere introdotto nell’ambiente? Frequentare le scuole di scrittura non è buona idea.
Pagare migliaia di euro solo per condividere una passione potrebbe sembrare un passatempo esclusivo e chic per hobbisti facoltosi, o figli di genitori facoltosi, con buona disponibilità della risorsa tempo. A meno che non si insinui l’illusione che possa diventare un mestiere, e allora il giudizio è ancora peggiore.
Non sta a me quantificare il prezzo di una passione, che è sana fino a quando non si trasforma in un’ossessione. E non si tratta solo di condividere una passione, perché qualcosa di concreto lo puoi imparare.
Facciamo finta che Linkiesta ti affidi una rubrica di stroncature. Nelle prossime millecinquecento battute hai lo spazio per una stroncatura fulminante.
Oh che bello. Lascio fare la critica ai libri a chi sa farla davvero. Tipo Cavalleri, Coscia, Brullo, Ottaviani. Vorrei invece criticare chi critica. Tipo quelle scrittrici che per ogni libro che hanno pubblicato hanno venduto un numero di copie così risibile da non essere bastevole a comprarci neppure un frigo. Eppure si pongono con tale saccente autorità. In verità, inevitabilmente, fanno la fine di chi per portare la pagnotta a casa non può che riciclarsi come insegnante di scrittura, blogger, critica letteraria, autrice che con tanta pomposità si definisce scrittrice, editor, ghost, correttrice di bozze, giornalista e chi più ne ha più ne metta ponendosi su un piedistallo costruito sulle conoscenze, sugli amici degli amici, sull’egocentrismo e soprattutto sulla percezione (percezione!) che da della propria competenza. Curioso: i loro libri non vendono nulla ma pretendono d’insegnare agli altri come si dovrebbe scrivere. Bella cazzata. E poi vorrei stroncare tutti quegli scrittori che utilizzano Facebook a sproposito. Di più, fossi un editore metterei nero su bianco la clausola per cui ogni autore non dovrebbe pubblicare più di un post al giorno. Hai un pensiero? Hai un’idea? Vuoi proprio dire qualcosa al mondo (virtuale)? Ecco, se proprio è più forte di te scrivi questo benedetto post alle 8 di mattina e leggi gli eventuali commenti durante il tè dalle 10:30 alle 11 o, meglio, durante quello delle 17. E il resto del tempo magari usalo per lavorare, progettare, inventare, vivere, scopare, o, ad esempio, scrivere. Se invece pensi che passare la giornata su Fb a scrivere tutto quello che ti viene in mente pensando così di farti conoscere, apprezzare e magari vendere anche i tuoi libri allora vuol dire che si, sei proprio quel cavallo di cui si parlava poco sopra. O asino. Vedi tu.
Volevo dirti che hai una piscina di pessimo gusto. E anche la scalinata è un tantino pacchiana. Il tuo rapporto con il kitsch? O anche, in chiusura, il kitsch fa vendere?
Prima del tumore ero indeciso se affittare la mia casa per i matrimoni o convertirla in un club privè di lusso: la vita nel suo momento di massima gioia e spensieratezza. In entrambi i casi il kitsch pagava. Ora la mia idea, che sta diventando realtà, è ricavare delle camere dotate di ogni comfort da offrire, insieme a molto altro, gratuitamente, a chi deve affrontare in completa solitudine la chemio, il post operazione, la morte: la vita nel suo momento di massima sofferenza e dolore. Come cambia la vita eh? Lo trovo meraviglioso. Uno scrittore (vero), nominato da me poco sopra, mi ha suggerito di riservare una camera agli scrittori che vorrebbero scrivere standosene in pace, in mezzo alla natura, in mezzo ad un bosco, con gli animali, con a disposizione una libreria infinita, in un posto stimolante. “Piuttosto la lebbra” è stata la mia risposta. Si, il kitsch ragionato fa vendere. La mia piscina, studiata, disegnata e materialmente fatta da me è stata fotografata, ammirata, descritta, copiata e portata ad esempio come espressione di buon gusto e raffinatezza. Tiè.
Simone Cerlini
L'articolo Monica Rossi, l’editor che fa vendere milioni di copie ai suoi autori, disintegra le vacue velleità degli scrittori presunti e vi spiega come funziona l’industria editoriale proviene da Pangea.
from pangea.news https://ift.tt/2NQHDxv
0 notes
Text
“Putin? Un personaggio tragico, un uomo solo”: dialogo con Aleksej Varlamov, scrittore e rettore del “Maksim Gor’kij” Literary Institute di Mosca
“Certo, vado a fare il bagno tutti i giorni, anche oggi”. Lo guardo, incredulo. Poche ore dopo, la pioggia, come singhiozzi d’angelo, sfalda la Riviera. Aleksej Varlamov è riconosciuto tra i grandi scrittori russi viventi: ha insegnato letteratura russa alla University of Iowa, in uno studio pubblicato dalla University of Toronto Press, quindici anni fa, Russian Literature 1995-2002, l’autore, N.N. Shneidman, lo definiva “tra i più prolifici scrittori della nuova generazione, quello che più e meglio di altri si riferisce alla tradizione del realismo russo”. I suoi libri sono tradotti in mezzo mondo, quest’anno Eurilink, la casa editrice legata alla Link Campus in Roma, ha pubblicato la sua biografia romanzata di Michail Bulgakov. “Il governo sovietico lo ha perseguitato, ma la sua vita non è priva di momenti felici e inattesi, come la messa in scena, nel 1926, de I giorni dei Turbin, che turbò i suoi detrattori”, mi dice, sorridendo, occhi azzurri, fronte ampia, barba letteraria, un talento assai russo nell’eludere e nell’alludere. Dalla finestra, eccolo, il mare. Incontro Varlamov a Misano Adriatico, sulla costa riminese, nelle aule della Fusp (Fondazione Unicampus San Pellegrino), luogo di riferimento per la traduzione e l’interpretariato. La Fusp ha creato un legame di scambio con il “Maksim Gor’kij” Literary Institute di Mosca, fondato, appunto, da Gor’kij, nel 1933, da cui sono passati Platonov, Mandel’stam, Pasternak. A dirigere il “Gor’kij”, oggi, c’è Varlamov, che passa anche per essere uno dei consiglieri culturali del presidente Vladimir Putin; in ogni caso è una delle figure di spicco nella letteratura russa, di oggi. “Mi chieda tutto di Russia, io le rispondo”, fa lui.
Lei ha riportato in auge la nobiltà del genere biografico. Ha scritto di Andrej Platonov e di Bulgakov, di Rasputin e di Aleksandr Grin. Ha scritto anche di Aleksej Tolstoj, il fatidico “Conte Rosso”: pioniere della fantascienza, torna in Russia dopo la Rivoluzione, perde il titolo nobiliare, è decorato con il Premio Stalin, litiga con il grande poeta Osip Mandel’stam, giurandogli la morte… è l’emblema dello scrittore ‘di regime’, non crede?
Di tutti i personaggi di cui ho scritto, devo dire che Aleksej Tolstoj, all’inizio, non mi piaceva per nulla. Mi pareva un uomo sgradevole ed ero molto lontano da lui riguardo alle convinzioni politiche. Scrivendo di lui, però, ho cambiato opinione: Aleksej mi ha vinto, in un certo senso. Ho analizzato in un capitolo il conflitto tra lui e Mandel’stam. Posso dire che il loro non era un dissidio politico né estetico e che la storia che sia stato lui a combinare l’arresto e la morte di Mandel’stam è frutto della fantasia di Anna Achmatova.
La cultura russa recente è penetrata a fondo in quella italiana – penso alla pubblicazione in Italia, in prima mondiale, del “Dottor Zivago”, e alle poesie dedicate a Venezia e a Roma da Iosif Brodskij, ad esempio. Quella italiana in che misura è conosciuta dai russi?
Umberto Eco e Alessandro Baricco sono molto conosciuti in Russia. Altri autori recenti non ne conosco. Più di tutto, però, è il cinema italiano a essere amato. Il cinema di Federico Fellini e di Pier Paolo Pasolini, il Neorealismo, sono dei cult.
Si può parlare a suo avviso, in questi anni, di ‘rinascimento’ culturale in Russia?
Affermarlo significherebbe ammettere che in precedenza abbiamo vissuto uno stato di declino, e non posso dire così. In Russia la vita culturale è molto interessante, è accesa, nei teatri, nelle mostre…
…e in campo letterario?
Non c’è alcuna censura, se è a questo che allude. L’ambito politico non tocca quello culturale, non c’è alcuna censura di tipo politico. Eventualmente, esiste una forma di censura ‘economica’. Intendo dire che lo Stato finanzia soltanto alcuni progetti, quelli che ha intenzione di sostenere.
Sì, ma lo scrittore che ruolo ha oggi in Russia?
Agli scrittori è permesso agire come vogliono. Possono scrivere quello che vogliono e possono pubblicare i loro libri, influenzando l’opinione civica. Se uno scrittore non è d’accordo con il governo attuale, però, non può andare nelle reti della televisione pubblica. Può scrivere quello che vuole, può pubblicare, ma non gli viene dato uno spazio più ampio, ecco.
Non è il migliore dei mondi possibili…
Non è il migliore, è vero; ma non è neanche il peggiore, se leggiamo la nostra storia.
Vorrei capire se lo scrittore è libero di agire come vuole perché in fondo a nessuno importa quello che ha da dire, oppure se questa libertà è reale.
Diciamo che la letteratura, oggi, non è pericolosa per lo Stato. Devo ammettere, insomma, che oggi non c’è un intellettuale scrittore del tipo di un Solzenicyn.
Vladimir Putin: a quale personaggio della letteratura russa lo avvicinerebbe?
Difficile da dire, Putin è un uomo complesso, molto complesso. Direi, probabilmente, Pečorin, il personaggio centrale di Un eroe del nostro tempo di Lermontov. Putin non è un personaggio ‘alla Puskin’: è una personalità sfaccettata, poliedrica. Mi pare una figura tragica, ecco.
Alla Fusp di Misano Adriatico, dialogando con Varlamov. L’intervista è stata possibile grazie all’impegno di Vladislava e di Mattia, giovani traduttori
Come mai ‘tragica’?
Beh, ha scelto di prendersi una grande responsabilità su diverse cose. Credo che sia molto difficile la sua vita, credo che sia un uomo molto solo. Anche la vita di Pečorin, in effetti, è difficile.
La sua analisi è profonda. Per noi, in Italia, la Russia, tra Cina e Stati Uniti, appare come uno Stato forte, quasi imperiale: voi come vi sentite?
Ci troviamo in una posizione di isolamento politico e penso che questo sia male per noi e per il resto del mondo. Questa situazione dipende da un nostro errore e da un errore dei paesi che ci hanno isolato. Ci sono molti problemi globali e non c’è alcun senso nella situazione di conflitto tra Russia ed Europa.
Chi è lo scrittore che considera maestro?
Jurij Kazakov [classico contemporaneo in Russia, tradotto da Einaudi nel 1960 e ripescato da Il Melangolo nel 1991, è ora latitante dalla scena editoriale italiana, ndr]. Lui è il mio maestro. Puskin, invece, inarrivabile come scrittore, �� un maestro di umanità, rappresenta l’intima identità della Russia.
Ora, cosa sta scrivendo?
Un romanzo. Tratta del conflitto tra Ucraina e Russia, un tema difficile, ma per me molto importante.
Tragga dalla storia della letteratura il libro che avrebbe voluto scrivere.
Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Mi sorprende come la storia di un piccolo villaggio colombiano inventato sia diventata globale e interessante per il resto del mondo.
Mi dica qual è il carattere fondamentale dello scrittore.
Sensibilità di cuore e di testa. Lo scrittore deve considerare sempre tutta la gamma di impressioni e possibilità che ha in sé la vita.
Il libro italiano che la ha formata.
Sarò banale: la Commedia. Ero un giovane studente al primo anno di università e c’era quel libro. Molti lo trovavano difficile. Io pensai fosse affascinante.
Ultima. Da rettore di un istituto universitario, consigli un libro a un giovane lettore con l’aspirazione di diventare scrittore, che sia russo o italiano.
I fratelli Karamazov, Dostoevskij. Un libro davvero universale.
Davide Brullo
L'articolo “Putin? Un personaggio tragico, un uomo solo”: dialogo con Aleksej Varlamov, scrittore e rettore del “Maksim Gor’kij” Literary Institute di Mosca proviene da Pangea.
from pangea.news http://bit.ly/308iySS
0 notes