Totally random notes on a travel towards eastern suns [☀/♪]
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Cose che movimentano l'autunno giapponese
Così come la "caccia alle foglie rosse" (紅葉狩り, momijigari) è il divertissement più atteso della stagione autunnale, uno dei film d'animazione più attesi di questo autunno 2022 era sicuramente Suzume no Tojimari (スズメの戸締り, Suzume's Door-Locking ), l'ultima pellicola di Shinkai Makoto, regista che negli ultimi anni si è fatto un nome in tutto il mondo con successi come Kimi no na wa (君の名は, Your name.) e Tenki no ko (天気の子, Weathering with you). Con Shinkai non è stato amore a prima vista, devo ammettere: l'ho conosciuto inizialmente tramite Byōsoku go senchimētoru (秒速5センチメートル, 5 cm al secondo), un lungometraggio che mi ha annoiato a morte e mi ha fatto anche incazzare perché avevo pure comprato il DVD di tasca mia, ascoltando il parere di chi me lo spacciava per il nuovo Miyazaki (parentesi: in quest'ultimo film Shinkai ha usato una canzone che era già stata utilizzata da Miyazaki in "Kiki's Delivery Service", sarà stato un omaggio ma dentro di me ho pensato "ma come ti permetti?" lol). L'elenco delle ragioni per cui avrei trovato più divertente guardare la vernice che si asciuga al sole sarebbe lungo, ma sostanzialmente: magari ero io a non essere già più nel target, ma che palle 'ste storie di sospirosi adolescenti che non riescono a confessarsi i propri sentimenti e si struggono per cercare di capire cosa pensi l'altro ma non si parlano e fanno i timidini che soffrono in silenzio perché non vogliono disturbare e non succede niente, solo i petali di ciliegio che cadono alla velocità di 5cm/sec (la stessa delle palle degli spettatori) sulle loro giovani esistenze già così infelici, ma poi un topos meno abusato dei fiori di ciliegio non c'era? Non dico che bisognasse per forza essere Sakaguchi Ango e trasformarli in un elemento orrorifico che fa da sfondo a una vicenda sanguinolenta come quella descritta in "Sotto la foresta dei ciliegi in fiore", però mo' neanche a fa' così. Altro punto di demerito: il contrasto tra i fondali iperrealistici superdettagliati e l'approssimativa stilizzazione con cui sono disegnate le figure umane mi faceva cringiare tantissimo, poi per carità, io ero anche in un momento intestinalmente poco felice durante la visione, ma penso di non poter dare a questo tutta la colpa lol

Succede però che qualche anno fa sono intrappolato per dodici ore su un volo intercontinentale e ho finito di guardare tutti i film che mi ispiravano, quand'ecco che nell'elenco vedo Kimi no na wa. In Giappone aveva avuto un successo strepitoso, al punto che la colonna sonora oltre ad aver raggiunto i primi posti tra le canzoni più cantate al karaoke era stata passata persino in tutti i convenience store della nazione, ma avendo bocciato Shinkai me ne ero naturalmente tenuto lontano. Non avendo letteralmente nient'altro da fare per ammazzare il tempo durante la traversata decido di dargli una seconda possibilità e 107 minuti dopo sono in una valle di lacrime. Intanto noto con piacere che lo stile dei disegni per quanto riguarda i personaggi è molto migliorato, ma a parte quello, l'aspetto che davvero mi colpisce è la presenza di diversi richiami allo scintoismo, per esempio il kuchikamizake (口噛���酒), bevanda alcolica prodotta durante le cerimonie scintoiste dalle sacerdotesse che masticavano il riso ammorbidito e ne innescavano la fermentazione grazie agli enzimi presenti nella saliva. La scelta di recuperare un elemento così particolare dello shintō (che, inutile dirlo, non conoscevo prima di questo film) rielaborandolo all'interno di un blockbuster mi intriga molto, forse per la stessa ragione per cui amo le reinterpretazioni del folklore del Tōhoku da parte di Miyazawa Kenji, e sebbene il suo film successivo, Tenki no ko, sia a mio parere più debole (lo riassumerei con una sola frase: Tōkyō diventa Venezia), il processo di creazione di un mito dietro l'espressione hareonna (晴れ女, donna che porta il sereno), non più una semplice ragazza sempre accompagnata dal sole ovunque vada ma una creatura semidivina in grado di arrestare la pioggia al prezzo però della propria vita che va via via accorciandosi, risulta altrettanto interessante. Ma è con Suzume no Tojimari che Shinkai si supera. Il film dovrebbe uscire in Italia a inizio 2023 quindi non ne parlerò troppo nel dettaglio per evitare spoiler, ma la vicenda si dipana dall'incontro tra Suzume, una studentessa di liceo, e Sōta, un misterioso ragazzo con il compito di chiudere le "porte del disastro" da cui fuoriesce una sorta di gigantesco blob chiamato "il lombrico" che se arriva a schiantarsi al suolo provoca terremoti e devastazione. L'opera di Sōta e dei "serratori di porte" come lui non è tuttavia sufficiente da sola a evitare sismi epocali: è necessario ricorrere anche a due "chiavi di volta" (要石, kanameishi) piantate nelle due estremità del lombrico.
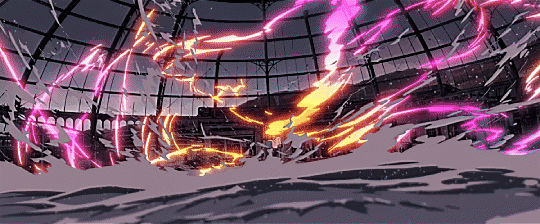
Anche se ci sono dei punti nella trama che non mi sono chiarissimi e avrei bisogno di una seconda visione per capire se fossero buchi di sceneggiatura o semplicemente cose che non ho collegato, la lista dei motivi per cui ho amato questo film batte quella delle ragioni per cui "5 cm al secondo" non mi era piaciuto: dalla presenza di un richiamo ai tragici eventi dell'11 marzo 2011, di cui mi ero marginalmente occupato durante la laurea magistrale, che credo sia importante vengano trattati da un blockbuster di successo nazionale e come è facile prevedere internazionale, agli elementi mutuati da antichi miti e leggende, e sono davvero molti. Qualche esempio: la formula magica che Sōta recita quando chiude una porta è ispirata ai norito (祝詞), solenni preghiere rituali indirizzate alle divinità scintoiste di cui fanno parte alcuni dei documenti scritti più antici pervenutici, e comincia infatti con una delle frasi d'apertura classiche di questi testi (かけまくもかしこき, "se mi è concesso pronunciarlo"); il lombrico che provoca i terremoti è una rielaborazione della credenza popolare secondo la quale a provocare i sismi sarebbe un enorme pesce gatto sotterraneo (prima del periodo Edo era un drago-serpente, come in altri miti asiatici, ma durante quest'epoca si consolida la versione secondo cui sarebbe invece il namazu 鯰, "pesce gatto" appunto); le "chiavi di volta" sono due pietre realmente esistenti, custodite in due santuari dove tengono ferma una la testa e l'altra la coda del namazu.

Nel 1855, Tōkyō viene colpita da un sisma di magnitudine 7 che passerà agli annali come Grande Terremoto Ansei. Pochi giorni dopo la tragedia, si sviluppa un fiorente mercato di stampe ukiyo-e raffiguranti il pesce gatto e denominate appunto "namazu-e" (鯰絵, immagini del pesce gatto), che avrebbero dovuto proteggere chi le acquistava dai terremoti. Quella qui sopra mostra anche la "chiave di volta" (要石, kanameishi) conficcata sulla testa del namazu per tenerlo fermo.
Dopo aver quindi scoperto che mi era sempre mancato un pezzo del mito del pesce gatto (che tra parentesi oggigiorno trovate raffigurato pure nei cartelli stradali a indicare la corsia di emergenza dove parcheggiarvi in caso di terremoto lol) non potevo far altro che correre ai ripari, e ho subito progettato una visita ai due santuari in questione, il Katori Jingū nella prefettura di Chiba e il Kashima Jingū in quella di Ibaraki, che si trovano a circa due ore da Tōkyō (in macchina anche un po' meno, opzione decisamente più economica anche nel caso di un'auto a noleggio rispetto al treno che ha dei costi spropositati). Questi due santuari gemelli, distanti all'incirca una quindicina di chilometri l'uno dall'altro, nonostante non se li calcoli nessuno forse proprio per la posizione periferica in cui si trovano sono in realtà nella top 3 dei santuari più importanti nella gerarchia scintoista. Sono gli unici, infatti, insieme al Santuario di Ise dedicato alla dea del sole Amaterasu, a essere denominati jingū 神宮 e non semplicemente jinja 神社, quindi sono santuari che hanno fatto l'upgrade.
Il santuario di Kashima è dedicato a Takemikazuchi-no-Ōkami, divinità citata anche del Kojiki (古事記, Un racconto di antichi eventi), uno dei testi più antichi tramandatici dove troviamo riportato il mito fondativo del Giappone stesso. In un lungo elenco di genealogie di divinità, leggiamo che la madre di tutti gli dei, Izanami, era morta dopo aver partorito il dio del fuoco che le aveva bruciato la vulva (il marchio Chilly purtroppo verrà fondato solo nel Novecento, fuori tempo massimo per dare sollievo alla dea), e il suo compagno Izanagi, disperato, aveva decapitato il figlio colpevole di avergli ucciso la compagna:
Il sangue spruzzò sopra le rocce intatte, prima dalla punta dell'arma e ne spuntarono i tre esseri che chiamiamo il sacro Ihasaku, il sacro Nesaku e il sacro Ihatsutsunowo, poi dalla lama e ne spuntarono i tre esseri che chiamiamo il sacro Mikahayahi, il sacro Hihayahi, e il sacro Mikazuchinowo il rude, che chiamiamo anche il sacro Takefutsu, o ancora il sacro Toyofutsu.
Oltre a descriverne così i natali, il Kojiki racconta anche di come questa divinità verrà incaricata da Amaterasu di negoziare con la divinità di Izumo affinché quest'ultima ceda il suo regno, "la terra immersa nelle pianure di giunchi", alla stirpe celeste di cui la dea del sole fa parte:
Il sacro Mikazuchi il rude, accompagnato dal sacro Amenotorifune, discese presso una spiaggia di Inasa nelle terre di Izumo, sguainò la spada di dieci spanne, l'elsa la ficcò sulla cresta delle onde, sulla punta della lama si sedette a gambe incrociate. E si rivolse al sacro grande signore Ohokuninushi: "Ecco - disse - cosa hanno ordinato di venirti a chiedere Amaterasu grande sovrana e sacra e il sacro Takagi: "La terra immersa nelle pianure di giunchi dove tu spadroneggi è destinata al regno della nostra stirpe". Che cosa hai in animo di fare?" "Non posso dirlo io - fu la risposta, - sarà mio figlio, il sacro Yahekotoshironushi, a decidere. È andato a pescare con gli uccelli ma non è ancora tornato dal promontorio di Miho". Il sacro Amenotorifune andò a prenderlo e gli si poté così chiedere di venire al dunque. "Quale tremendo onore! Cedo umilmente queste terre alla stirpe dei celesti" [...]
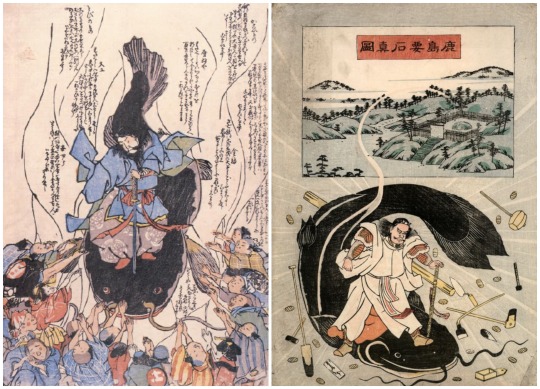
Patrono pure delle arti marziali nel tempo libero, questa divinità viene anche spesso rappresentata in cima al namazu con la spada conficcata sulla testa del mostro.

Takemikazuchi-no-Ōkami dimmi bene che casa mia non è neanche assicurata contro i terremoti, mi sei rimasto giusto tu.
Ovviamente, che ve lo dico a fare, come da tradizione l'edificio principale del complesso era in ristrutturazione, perché giustamente un santuario che si narra risalire al VII-VI secolo a.C. con tutto il tempo che hanno avuto lo dovevano risistemare proprio quando ci andavo io, ma io ero lì per le "chiavi di volta" e quindi il danno emotivo è stato contenuto, nel senso che sono riuscito a tornare fino alla macchina prima di scoppiare a piangere e ce l'ho fatta a non farmi vedere da nessuno.
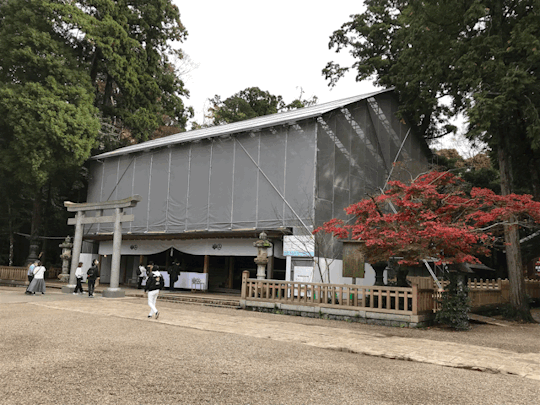
In assenza dell'edificio principale, favorirò una foto del rōmon (楼門, portale della torre), che comunque è considerato uno dei tre più grandi del Giappone ed è patrimonio culturale nazionale importante quindi buttalo via.
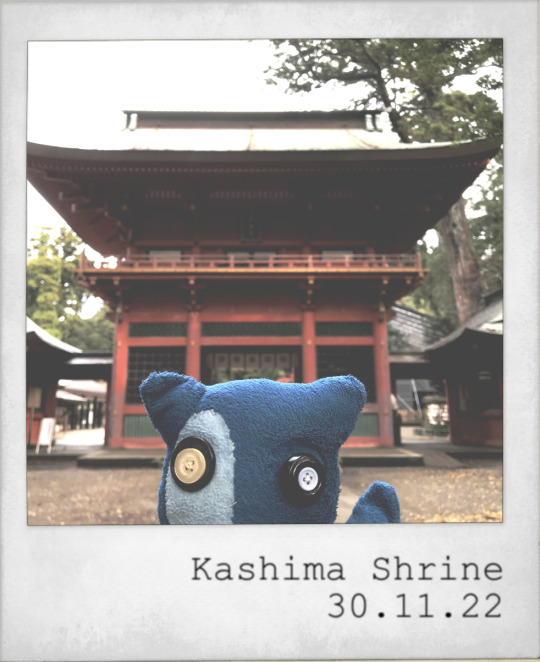
Grande ritorno del Nekomata sia perché ho finalmente trovato un sito con il filtro Polaroid dopo che quello che avevo usato per anni mi ha abbandonato, sia perché nel film di Shinkai le "chiavi di volta" si manifestano con le sembianze di gatti, un segno che non ho potuto ignorare lol

MA VENIAMO DUNQUE A QUESTA BENEDETTA KANAMEISHI, a questa pietra custodita nel cuore della foresta del santuario di Kashima e che dovrebbe tenere ferma la coda del pesce gatto, a questo... questo...

...grande, immenso... SASSO!
Nonostante la leggenda voglia che il daimyō (大名, signore feudale) Tokugawa Mitsukuni, anche noto come Mito Kōmon, avesse provato a scavare per sette giorni e sette notti nella terra cercando di dissotterrare la pietra senza però trovarne la fine, occorre dire che essendo pure concava non è che spicchi proprio tantissimo nella pur suggestiva cornice del boschetto in cui si trova.

La lochescion da Principessa Mononoke devo dire diesci, per quanto riguarda la scelta del vedo-non-vedo per la pietra all'interno del recinto non saprei, spero che almeno serva a tenere ben saldo il terreno.

大地震にびくともせぬや松の花 Impassibili restano al grande sisma i fiori di pino

Cose che mi ero dimenticato di sapere (lol): ogni divinità scintoista (神 kami) ha in sé due aspetti, un'anima violenta (荒御魂 aramitama), quella a cui tra l'altro si esprimono le proprie preghiere in quanto lato attivo del kami, e un'anima tranquilla (和御魂 nigimitama), stato di pacificazione a cui il kami arriva grazie alla venerazione dei fedeli. In foto, l'Okunomiya del Kashima Jingū, in cui è venerata l'aramitama di Takemikazuchi-no-Ōkami.
Fedele al suo nome di "santuario dell'isola dei cervi", animali che in Giappone sono considerati emissari e cavalcatura delle divinità, il bosco del santuario contiene anche un recinto dove si trova una trentina di cervi, così come pare anticamente fossero allevati anche all'interno del santuario di Kasuga a Nara, evidentemente prima che sfondassero le recinzioni e cominciassero ad aggirarsi liberi per la città lol Quest'ultimo santuario ha in effetti un forte legame con il Kashima Jingū: nell'anno della costruzione del Kasuga Taisha, fu inviato da Kashima un cervo bianco affinché trasportasse sulla groppa una parte del nume tutelare del santuario di Ibaraki e lo donasse al nuovo complesso scintoista. Tutto molto bello, tutto molto poetico, sennonché poi vai a vedere il recinto e ci sono due cervi maschi che si pisciano in bocca mentre un terzo guarda. Emissari delle divinità mi dicevano, sì?

Un giorno rinascerò cervo a primavera... mah speriamo di no dai.
Spostandosi di una quindicina di chilometri, appena oltrepassato il confine tra la prefettura di Ibaraki e quella di Chiba troviamo il santuario di Katori, dedicato a Futsunushi-no-Ōmikami. Se il patrono del Kashima Jingū viene citato nel Kojiki, quello del Katori Jingū è nominato nel Nihon-shoki (日本書紀, Annali del Giappone), opera di poco più tarda (720 invece che 712) scritta in cinese classico per presentare la storia del Giappone agli altri Paesi dell'Asia (quindi purtroppo non esiste ad oggi una traduzione in italiano che vi possa citare come ho fatto col Kojiki, vi dispiace eh? lo so, riesco a vedervi affranti da qui). Secondo il Nihon-shoki, ad aver negoziato con la divinità di Izumo affinché cedesse il suo regno ad Amaterasu furono i due dei Takemikazuchi-no-Ōkami e Futsunushi-no-Ōmikami, ma fu quest'ultimo a essere scelto dai celesti, mentre Takemikazuchi gli si accodò all'ultimo minuto per dimostrare di non essere da meno. Anche questo santuario sarebbe antichissimo, risalente addirittura al VII secolo a.C., e nel suo boschetto è custodita la "chiave di volta" convessa che tiene ferma la testa del namazu.
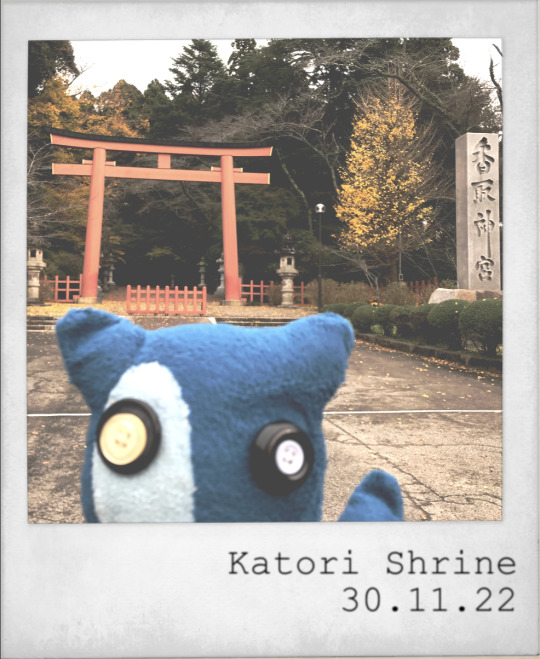
Devo dire che il fatto che questo santuario NON fosse in ristrutturazione me lo ha fatto apprezzare di più del Kashima Jingū, ma non ho problemi ad ammettere il mio bias lol

L'edificio principale (拝殿 haiden, sala delle preghiere) è laccato di nero, cosa relativamente rara per l'architettura scintoista e che dà all'edificio un aspetto estremamente elegante facendo risaltare ancora di più i dettagli in oro.

Colours of autumn @ Katori Shrine 🍂

Io che cerco di imitare la #ragazzaautunno - dov'è la mia bevanda al radicchio pedocio?

La "chiave di volta" convessa che tiene ferma la testa del namazu. Lei non era neanche in una lochescion da dieci, messa un po' a caso in mezzo alla foresta con la palizzata intorno, però sicuramente fa già più scena della sua gemella concava.

Katori Jingū: un santuario che vi verrà voglia di visitare ancora ⚓️
Ma adesso basta con tutta questa cultura e veniamo alla vera domanda: ma sto pesce gatto, si mangia? Lo avevo visto cucinare in una puntata di Masterchef (lol, i miei riferimenti, che vergogna) ma non sapevo se in Giappone fosse consuetudine dato che normalmente non lo si vede nei menù, quand'ecco che proprio all'uscita dal Kashima Jingū ci imbattiamo in un ristorante specializzato in pesce gatto. Il mio entusiasmo per questo pesce che non avevo mai mangiato prima era alle stelle e mi sono lasciato convincere dal full-course che prevedeva una versione cruda, una versione cotta e una fritta, e dopo averlo provato in tre salse diverse credo di poterlo dire: non sa proprio di niente lol. È un po' come il pesce palla, il temutissimo fugu che viene considerato una pietanza di lusso anche per il fatto che se cucinato da chef inesperti che non eliminano la ghiandola che produce il veleno rischiate pure di rimetterci le penne, senza però averne l'aura di fastosità lol.

Oh beh, speriamo almeno che mangiare il pesce che provoca i terremoti porti fortuna, o quantomeno che non porti rogna lol
8 notes
·
View notes
Text
Cose che non si piegano alla pioggia e al vento di Iwate
A volte ritornano. Un po’ come il vento, che prima o poi torna a soffiare. Mi fa sorridere pensare che l’ultimo post che avrei voluto scrivere tre anni fa e che poi non si è mai concretizzato fosse proprio il resoconto del mio viaggio a Hanamaki, città natale dello scrittore Miyazawa Kenji, e che ora a farmi riesumare il blog sia esattamente il desiderio di raccontarvi com’è stato tornarci.
È successo di tutto nel frattempo: ho cambiato due lavori, mi sono convinto a farmi un account su Instagram (late to the party), ho curato due pubblicazioni (della prima vi parlavo qui, mentre la seconda, un'antologia di racconti di Miyazawa Kenji appunto, è il motivo che mi ha spinto a intraprendere questo secondo viaggio) e contribuito alla traduzione di altri due volumi, ho rotto un iPhone perdendo tutte le foto di cinque anni di vita giapponese (tra cui proprio quelle del mio precedente viaggio a Hanamaki 🤬), ho traslocato, ma soprattutto: il programmino di fotoritocco online che usavo per creare le foto del Nekomata ha tolto la possibilità di aggiungere una cornice in stile Polaroid tarpando completamente la mia creatività lol. Io lui lo porto sempre con me nei miei giri, ben intenso, ma ho smesso di fargli le foto perché se non posso metterci l’effetto Polaroid che senso ha. Non è il sentimento di vergogna che con i trent’anni è maturato in me, giuro, è proprio la disperazione di un pigro davanti all’idea di dover trovare un altro sistema per ottenere lo stesso risultato, cosa che probabilmente con una veloce ricerca su Google non mi sarebbe impossibile, ma sono un Capricorno semplice e detesto i cambiamenti.

Capricorn spotted @Rinpoosha, il caffè gestito dagli eredi di Miyazawa Kenji ♑️✨ Fun fact: oltre a esporre svariati libri dello scrittore e opere a lui dedicate, vendeva addirittura la prima raccolta di racconti in italiano edita da Marsilio, che naturalmente avevo letto ma che non possedevo perché ai tempi mi era stata prestata, quindi sono finalmente riuscito ad accaparrarmela a un prezzo stracciato (la cifra riportata sulla copertina, usata per la conversione in yen, era ancora in lire lol). Siccome mi dispiaceva lasciarli orfani della seconda uscita (e avevo visto che avevano un tavolo con una gamba ballerina) gli ho lasciato giù anche una copia dell'antologia curata da me, se ci andate fatemi sapere se sta facendo il suo lavoro di stabilizzare il tavolino lol
A proposito di cambiamenti: mi sono perso il momento esatto in cui è successo, ma a un certo punto qualche settimana fa l’assordante frinire delle cicale giapponesi ha lasciato il posto al tranquillizzante canto dei grilli, segno che ormai l’estate è agli sgoccioli. Ascoltarlo mi mette addosso un po’ di malinconia mentre nei pressi della stazione di Tokyo (cosa ci fanno dei grilli qui? lol) cerco il parcheggio da cui partirà l’autobus notturno che per qualche oscura ragione penso ancora di avere l’età e il fisico per prendere. Arrivo a Iwate all’alba del giorno dopo, 17 settembre, e smonto a Kitakami, grossa stazione a dieci minuti di treno da Hanamaki, non grossa abbastanza perché abbiano introdotto l’innovativa tecnologia delle carte prepagate in sostituzione dei biglietti cartacei. La notizia mi viene data da un bigliettaio che mi avverte che “ancora non si può usare la carta prepagata”, io non so perché immagino che la frase prosegua con “perché è ancora presto”, gli chiedo da che ora si potrà scatenandone l’ira funesta: “No non si può usare e basta, comprati il biglietto”. Va bene obbedisco ma datti una calmata e modera i toni chessò tu sorella? Evidentemente il seguito della frase era “nonostante sia il 2022”.
Ritrovo Hanamaki quasi identica a come l'avevo salutata tre anni fa, quasi lo sapesse anche lei che i cambiamenti non mi mettono troppo a mio agio. Il nome di questo centro nella prefettura di Iwate, letteralmente 'rotolo/spirale di fiori' (花巻), probabilmente deriva da un altro carattere che si legge maki (牧) ma ha il significato di 'pascolo', e potrebbe addirittura celare un'origine ainu (パナ pana sta infatti a indicare il terreno pianeggiante a valle di un fiume). Sull'etimologia non me la sento di mettere la mano sul fuoco, ma quello che posso assicurarvi è che il 99% delle attrazioni di questa città verte intorno alla figura dello scrittore Miyazawa Kenji (1896-1933), a cui ha dato i natali. Personaggio unico all'interno della letteratura giapponese, fu autore di fiabe e poesie, ma anche agronomo, fervente praticante buddhista, appassionato di musica, mineralogia, ukiyoe ed esperanto. Nelle sue opere riuscì a far convivere il sapere scientifico e gli spunti religiosi, il folklore della sua terra e gli elementi autobiografici in una sintesi estremamente originale, anche se il riconoscimento del suo enorme valore letterario giunse solamente postumo. In vita, infatti, fu ignorato quando non apertamente dileggiato, un po' per il fatto che la maggior parte della sua produzione consistesse di fiabe e un po' per la sua marginalità geografica, ed è impressionante passeggiare per le strade di Hanamaki quasi novant'anni dopo la sua morte e vedere il suo nome, la sua silhouette e i personaggi dei suoi racconti nei nomi dei negozi, dei ristoranti, sulle panchine, nelle insegne.

Normalmente tornare in un luogo che ho già visitato non mi entusiasma troppo, considerato che c'è ancora molto del Giappone che non ho ancora visto, ma avevo un debito di riconoscenza nei confronti di Hanamaki: ai tempi della mia prima visita, infatti, avevo appena cominciato a lavorare sulla traduzione di uno dei miei racconti preferiti di Miyazawa Kenji, "Matasaburō del vento" (風の又三郎 Kaze no Matasaburō), una proposta per la prima volta partita timidamente da me e che Marsilio Editori ha avuto la generosità di accogliere, e immergermi nel mondo dello scrittore mi aveva dato una grande motivazione a proseguire nel progetto. Continuando a studiare la figura di Kenji e imparando sempre di più su di lui e sulle sue opere, era sorto in me il desiderio di tornare a Hanamaki per vedere se avrei maggiormente apprezzato la città, e devo dire che avere un bagaglio di informazioni più ampio ha giocato il suo ruolo perché mi ero effettivamente lasciato sfuggire delle cose durante il mio primo viaggio. Per esempio, mi ero completamente perso la stele messa a indicare il luogo dove sorgeva la stamperia che produsse la prima raccolta di poesie autopubblicate di Kenji, "La primavera e gli Asura" (春と修羅 Haru to Shura), oggi un negozio di dolci.

花(巻)より団子 🌸<🍡
Un'altra attrazione di cui non ero a conoscenza ai tempi della mia prima visita è la locomotiva SL Ginga, un treno a vapore ispirato a quello su cui viaggiano i protagonisti di una delle opere più famose di Kenji, "Una notte sul treno della Via Lattea" (銀河鉄道の夜 Ginga tetsudō no yoru). In servizio dal 1940 al 1972, è stata rimessa in funzione nel 2014 per coprire la tratta Hanamaki ⇔ Kamaishi e dall'aprile di quest'anno si poteva scegliere una data tra le due/tre disponibili ogni settimana per prenotare il proprio posto a sedere. Gli interni del treno sono molto curati e anche le stazioni in cui si ferma sono state ribattezzate con un secondo nome in esperanto, chiaro riferimento alla lingua studiata da Kenji, ma nonostante l'entusiasmo scaturito dall'essere a bordo di un omaggio letterario così ben congegnato, devo dire che le colonne di denso fumo nero che si levano dal camino della locomotiva che va effettivamente a carbone lo fanno sembrare più che altro un crimine ambientale, non proprio in linea con l'ecologismo sostenuto da Kenji. Ma d'altronde siamo nel paese dove i biscotti vengono incartati uno a uno nella plastica per evitare il fastidioso inconveniente che si rammolliscano con l'umidità, capisco che sia una battaglia persa in partenza lol

「どこまでも続いてくGINGA GO 銀河で会いましょう」
"Continua all'infinito GINGA GO Incontriamoci nella Via Lattea"

Il rainbow-washing colpisce anche la stazione di Hanamaki, il cui nome in esperanto è Cielarko (arcobaleno).


La GIF qui sopra era a colori prima che lo SL Ginga la affumicasse.

Il secondo nome della stazione di Shin-Hanamaki invece è "Stelaro" ("Costellazione"), un po' esperanto ma anche un po' deep Veneto.
Non so se valga come attenuante ma il mio contributo alla distruzione dell'ecosistema si à limitato a una stazione, giusto il tempo di arrivare a Shin-Hanamaki dove avrei preso un treno per Morioka, capoluogo della prefettura di Iwate. Due i miei obiettivi in quella zona: la fattoria Koiwai e la sede della casa editrice Kōgensha.

La fattoria Koiwai (小岩井農場 Koiwai nōjō), fondata nel 1891, è una delle più grandi aziende agricole private del Giappone e tuttora vende il suo latte a quasi tutti i supermercati del Paese. Il nome deriva dalla combinazione del primo carattere cinese del cognome di ognuno dei tre fondatori (Ono Gishin 小野義眞, Iwasaki Yanosuke 岩崎彌之助 e Inoue Masaru 井上勝). I suoi silos, costruiti tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento con le tecniche più innovative dell'epoca mutuate dall'Europa, sono le strutture in mattoni più antiche del Giappone e sono state nominate Proprietà culturale nazionale tangibile. Miyazawa Kenji ne fu talmente colpito che oltre a citarla nelle sue opere - un esempio per tutti: "La foresta dei lupi e la foresta dei colini di bambù, la foresta dei ladri" (狼森と笊 森、盗森 Oinomori to Zarumori, Nusutomori), le dedicò anche un lungo poema.

Iwate era talmente piena di libellule (mating season I guess..?) che nel momento in cui stavo immortalando il libro con la fattoria Koiwai sullo sfondo una di loro ci si è posata sopra, regalandomi uno scatto davvero kenjiano. Fun fact: uno degli antichi nomi del Giappone è Akitsushima, "l'isola delle libellule", perché si racconta che il primo imperatore del Paese, il mitologico Jinmu Tennō, si arrampicò su un'altura e paragonò la forma del suo regno a due libellule in amore.
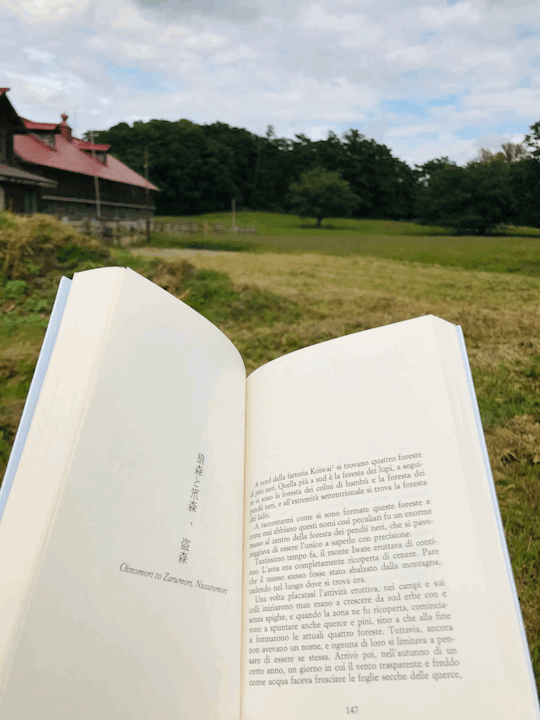
"A nord della fattoria Koiwai si trovano quattro foreste di pini neri. Quella più a sud è la foresta dei lupi, a seguire vi sono la foresta dei colini di bambù e la foresta dei pendii neri, e all'estremità settentrionale si trova la foresta dei ladri" (Miyazawa Kenji, "La foresta dei lupi e la foresta dei colini di bambù, la foresta dei ladri"). Con il mio proverbiale senso dell'orientamento non saprei dirvi se la direzione fosse effettivamente Sud ma Google Maps mi ha assicurato che quella all'orizzonte è proprio la foresta dei lupi 🐺
L'area complessiva ricoperta dalla fattoria è attraversata da una strada che divide la parte storica con le strutture antiche e le stalle da una più grande e nuova dove si trovano un piccolo museo, delle aree giochi per le famiglie e vari chioschetti e ristorantini. Devo dire che se visitare la parte più antica è stato molto emozionante dal momento che si riusciva anche a intravedere la famosa foresta dei lupi del racconto di Kenji, la parte nuova, nonostante (o forse proprio a causa di) quella sua atmosfera idilliaca e bucolica con i bambini che giocano nella natura e le mucche di plastica sparse qua e là a mo(o)' di mascotte, con la sua entrata sovrastata da un triangolo mi ha dato delle fortissime Midsommar vibes lol

Can't unsee 👀

Prima di lasciare Morioka per rientrare a Hanamaki, ho fatto una capatina alla sede della casa editrice Kōgensha, che nel 1924 pubblicò l'unica raccolta di fiabe edite finché Kenji era in vita, "Un ristorante pieno di richieste" (注文の多い料理店 Chūmon no ōi ryōriten). L'azienda attualmente si occupa di tutt'altro (vende articoli di artigianato), ma ospita un piccolo museo che contiene tra gli altri cimeli anche la prima edizione dell'antologia e degli appunti autografi (fra cui anche uno schema temporale degli eventi da sviluppare per la prima stesura di "Matasaburō del vento"). Nonostante l'attività sia molto cambiata da come doveva apparire negli anni Venti, devo dire che ha comunque tenuto a rendere onore al suo legame con lo scrittore con un enorme palazzone di fianco alla sede storica con il profilo di Kenji dimensione "L'attacco dei giganti" per nulla appariscente.

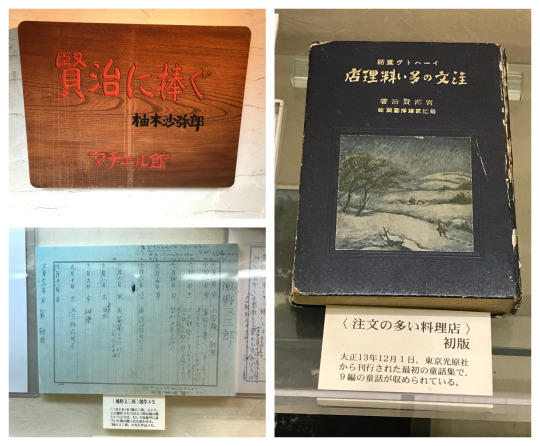
A Hanamaki il trittico di attrazioni dedicate a Kenji, i Prue-Piper-e-Phoebe dello scrittore sono il Miyazawa Kenji Museum, il Miyazawa Kenji Ihatov Center e il Miyazawa Kenji Dōwa Mura (Fairytale Village). Il primo è un vero e proprio memoriale che fornisce ai visitatori un quadro molto sfaccettato della figura di Kenji, dividendo il percorso in cinque aree tematiche che ne esplorano alcuni aspetti cardine (scienza, arte, cosmo, religione e agricoltura). Se da un lato la presenza di così tante informazioni in uno spazio relativamente contenuto permette di cogliere la poliedricità dello scrittore, devo dire che la quantità di spunti potrebbe forse confondere i neofiti, ma la struttura vale sicuramente una visita non fosse altro che per la scalinata in legno che vi conduce, in cui ad ogni gradino è associata una sillaba della celeberrima poesia di Kenji "Non fragile alla pioggia..." (雨ニモマケズ Ame ni mo makezu), e il ristorante dall'eloquente nome di Wildcat House, mutuato appunto dal racconto "Un ristorante pieno di richieste".
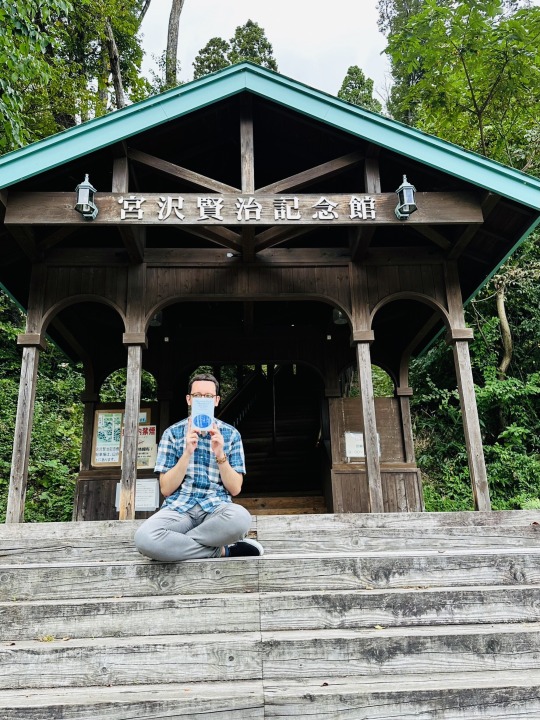
Potevo mai andare al memoriale di Kenji senza portarmi dietro il libro? In verità sì, avrei potuto, e ci saremmo evitati questo fallimentare tentativo di realizzare uno scatto promozionale lol

Importunando la fauna locale 🐱

Dimmi che sei italiano senza dirmi che sei italiano. Ora che ci penso tra l'altro ironico che un vicentino vada fino a Iwate in Giappone per mangiare al ristorante del gatto selvatico.
Il Miyazawa Kenji Ihatov Center, invece, è un piccolo spazio espositivo provvisto di un caffè, una ricca libreria e una saletta cinematografica dove vengono proiettati in loop degli anime tratti dalle opere di Kenji, e ospita spesso mostre legate allo scrittore (questa volta ce n'era una della calligrafa Sawamura Sumiko che aveva trascritto alcuni famosi passaggi dei racconti più noti).

L'inconfondibile profilo di Miyazawa Kenji all'entrata dell'Ihatov Center; brani tratti dal racconto "Il bosco del Parco di Kenjū" esposti nel boschetto adiacente alla struttura; disclaimer della calligrafa che avverte che il testo è stato accorciato e "qui e là contiene errori, chiedo scusa a Kenji e a tutti voi" (lol?).
L'attrazione più giocosa è decisamente il Dōwa Mura (Fairytale Village), pensato principalmente per un pubblico di bambini che possano immergersi nel mondo dello scrittore visitando le sale colorate e decorate da oggetti che rimandano ai suoi racconti. Da fine luglio a inizio ottobre, tuttavia, nel vasto giardino della struttura vengono allestite delle luminarie molto suggestive ispirate al racconto "Le ghiande e il gatto selvatico" (どんぐりと山猫 Donguri to yamaneko) e riuscire a beccarle durante questa seconda visita è stato un vero e proprio colpo di fortuna.

Trenino ispirato a quello su cui viaggiano i protagonisti di "Una notte sul treno della Via Lattea". Questo almeno non va a carbone lol

"Il fenomeno chiamato "io" | consiste in un'illuminazione blu, | ipotetica lampada di corrente alternata organica | (la combinazione di tutti gli spiriti trasparenti). | Insieme ai paesaggi e a tutto il resto, | precipitosamente si accende e si spegne, | e di sicuro continuerà a brillare: | è un'illuminazione blu, lampada di corrente alternata del karma | (la luce resta, la sua lampada si perde)." (Miyazawa Kenji, "La primavera e gli Asura: Prologo")

Ed è subito The Sims, così, tutto de botto.
Ultime due menzioni speciali: la "costa inglese" (イギリス海岸 Igirisu kaigan), nome con cui lo scrittore ribattezzò una zona lungo il fiume Kitakami che scorre attraverso la città di Hanamaki per la presenza di formazioni di argillite (ora non più visibili) che gli ricordavano quelle riscontrabili negli strapiombi inglesi; e la statua di Matasaburō del vento, realizzata dallo scultore Nakamura Shin'ya, troneggiante al centro di uno spiazzo destinato ai campeggiatori perso nel bel mezzo del nulla in cima a un pendio a un'ora di macchina da Hanamaki. Oltre al terreno per piantare le tende la struttura offriva delle pittoresche casette di legno dov'era possibile fermarsi non solo mezza giornata come ho fatto per questioni di tempo ma anche a dormire (purtroppo erano prenotate e non è stato possibile), e credo che effettivamente passare una notte nella foresta avrebbe potuto essere molto riposante per disintossicarsi dal logorio della vita moderna senza però rinunciare all'igiene personale tipo lol, anche perché non c'era veramente NIENTE a parte la statua di Matasaburō (che desideravo moltissimo vedere dopo aver persino pensato di proporla come copertina del volume, salvo poi innamorarmi delle opere di Higashiyama Kaii, che con il suo "Hakuba no Mori" non solo sintetizzava in una sola tela gli alberi e il cavallo che sono elementi spesso ripresi nelle copertine giapponesi di Matasaburō del vento, ma li ammantava anche di un'atmosfera fiabesca molto adatta al mondo di Kenji e usava uno dei suoi colori più rappresentativi, il blu).

Grandissimo rimpianto di questo secondo viaggio: non essere riuscito a ritrovare il punto in cui i fiumi Kitakami (in foto) e Toyosawa confluiscono, che a quanto pare Kenji prese come modello per i due episodi ambientati al fiume all'interno di "Matasaburō del vento". Durante il mio primo viaggio ricordo che avevo falciato un canneto con la bicicletta per riuscire a fargli una foto (persa per sempre con la dipartita del precedente iPhone), ma stavolta a piedi non sono stato in grado di individuare il passaggio che permetteva di arrivarci e alla fine ho deciso di non rischiare l'osso del collo tra l'erba alta, altro incidente profeticamente presente nel racconto e forse non a caso lol
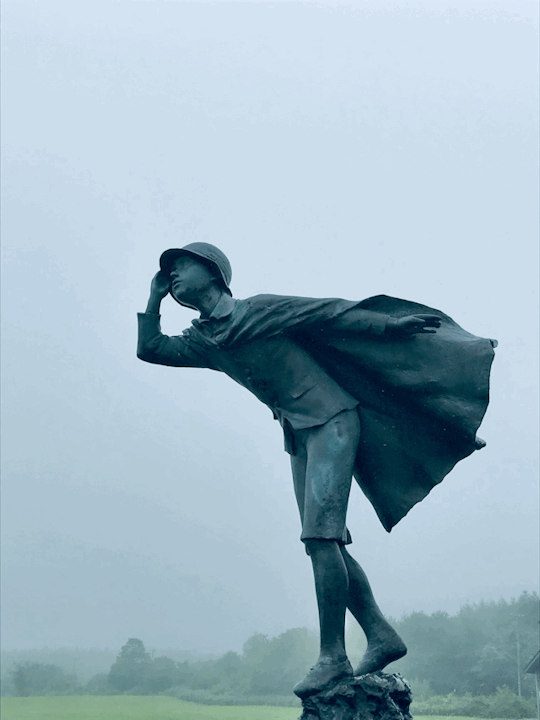
"Accadde tutto proprio come negli antichi racconti. Davanti agli occhi di Kasuke, Matasaburō guardava il cielo in silenzio, le gambe distese. Sopra alla sua solita giacca grigio topo aveva indossato chissà quando un mantello di vetro. Inoltre, ai piedi calzava delle scarpe lucenti, in vetro anch’esse. Sulle sue spalle calava l’ombra bluastra del castagno, mentre la sua, dello stesso colore, cadeva a sua volta sull’erba. Il vento, intanto, soffiava sempre più furiosamente. Matasaburō non rideva né proferiva parola. Si limitava a fissare la volta celeste in silenzio con le sottili labbra ermeticamente serrate. D’improvviso, spiccò il volo con un balzo verso il cielo. La cappa di vetro brillò di una luce abbagliante." (Miyazawa Kenji, "Matasaburō del vento")
Rivedere i luoghi dove Miyazawa Kenji è nato, è vissuto, ha camminato tra la natura della sua Iwate (o Ihatov, come la ribattezzò lui trasfigurandola in un mondo immaginario dove tutto era possibile) e ha scritto molti dei suoi racconti dopo aver passato quasi tre anni a tradurlo e ad approfondire e studiare la sua vita e le sue opere è stata davvero un'esperienza preziosa, che nonostante rischiasse di non riservarmi lo stesso senso di sorpresa della prima visita, in realtà mi ha regalato molto di più, sia perché ho comunque aggiunto delle tappe che mi erano sfuggite nel primo viaggio ma anche perché una maggiore consapevolezza ha cambiato il mio sguardo. Era il lontano 2013 quando, durante il mio primo periodo di studi in Giappone a Ōsaka, lessi per la primissima volta l'intrigante incipit di "Matasaburō del vento", rimanendone così incuriosito da rendere il racconto l'oggetto del report finale del corso di letteratura che seguii l'anno successivo mentre studiavo a Kyōto, e mai mi sarei immaginato all'epoca che nel 2019 Marsilio avrebbe accettato la mia proposta di tradurlo in italiano insieme ad altri otto racconti che, dopo una lunga gestazione, finalmente hanno visto la luce nel luglio 2022, e che spero cavalcheranno il vento raggiungendo quanti più lettori italiani possibile per trasportarli nel mondo incantato di questo scrittore unico nel suo genere. Sono racconti solo apparentemente di facile lettura, in cui realtà diametralmente opposte come la scienza e la religione trovano un connubio perfetto, in cui l'elemento biografico e il folclore giapponese si amalgamano in maniera armoniosa, e in cui le passioni che animarono Miyazawa Kenji danno vita a un universo narrativo perturbante nel quale solo le fiabe con i loro archetipi possono trascinarci.

Proprio quando pensavo che Hanamaki mi avesse donato tutto quello che poteva in questo viaggio, appena salito sul treno del ritorno fuori dal finestrino si è materializzato un arcobaleno, che già di per sé sarebbe bastato a rallegrarmi, ma che si è tinto di un significato ancora maggiore considerando quanto Kenji aveva scritto nella prefazione di "Un ristorante pieno di richieste": "Ho ricevuto tutti i miei racconti dall’arcobaleno o dalla luce della luna, in un bosco, in un prato o sulle rotaie della ferrovia". Grazie Hanamaki, non potevi regalarmi finale migliore 🌈
Vi lascio di seguito i riferimenti del libro, qualche recensione che ho trovato online e per chi fosse interessato anche una playlist dove ho raccolto alcuni brani che per un motivo o per l'altro hanno un legame con il mondo di Miyazawa Kenji e che ho ascoltato spesso mentre lavoravo al volume, anche perché Kenji stesso amava che la musica (senz'altro non questa ma shhh) accompagnasse la lettura dei suoi racconti. Sperando che possiate raggiungere anche voi Ihatov, se non fisicamente ora che da ottobre il Giappone riapre le frontiere (alla buon'ora!) almeno con la fantasia 🌬
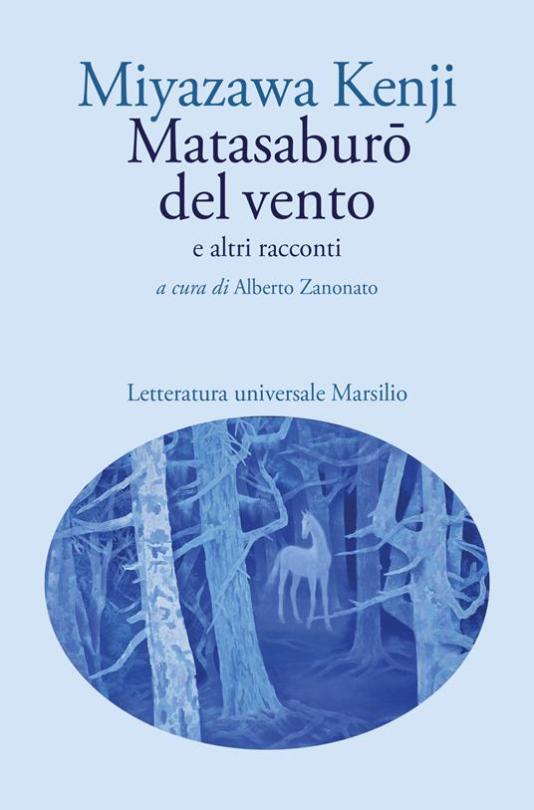
Matasaburō del vento e altri racconti - Marsilio Editori
Recensioni: Doppiozero - Miyazawa: solo i bambini sanno il segreto del vento Libroguerriero - "Matasaburo del vento" di Miyazawa Kenji (Marsilio) ilGiornale.it - Le favole buddhiste di Miyazawa Kenji fra Pascoli, Bergson e il cristianesimo Parliamone-books - Matasaburō del vento: buddhismo, tradizione, natura nei racconti di Miyazawa Kenji Videorecensione: Marianna Zanetta
Playlist: Matasaburō del Vento
2 notes
·
View notes
Text
Cose che devo a Edogawa Ranpo
Nel suo romanzo “La strana storia dell’Isla Bonita Isola Panorama”, che mi sono indebitamente preso la libertà di tradurre per Marsilio editore (mi giustificherò ulteriormente nella parte finale di questo post lol), Edogawa Ranpo, uno degli esponenti più importanti del mystery novecentesco in Giappone, racconta della costruzione da parte di uno studente squattrinato arricchitosi grazie a un subdolo furto di identità di un utopico paradiso su uno sperduto isolotto chiamato Okinoshima (沖ノ島, ‘l’isola al largo’).
È stato proprio grazie a questo romanzo che mi si sono aperti degli scenari che non avrei mai altrimenti immaginato: Okinoshima è infatti il nome di una delle isole più sacre per lo scintoismo (per quanto se ne contino circa un’altra quindicina in giro per il Giappone dato che non è un toponimo così ricercato lol). Divenuta patrimonio UNESCO nel 2017, vietata alle donne perché troppo impure (anche se si ritiene che il banno sia una sclerotizzazione di un precedente scrupolo che i marinai avevano riguardo all’esporle a un viaggio inutilmente pericoloso) e comunque aperta soltanto a un numero limitatissimo di uomini che devono purificarsi con delle abluzioni in mare prima di metterci piede, abitata solo dal sacerdote che ne officia i riti, Okinoshima custodisce l’Okinotsugū, il santuario più romito tra quelli dedicati alle sorelle Munakata.
Questa triade di divinità secondo il Kojiki, il testo che riporta il mito fondativo del Giappone, sarebbe nata dai pezzi della spada del dio Susanoo triturati dalla sorella, la dea del Sole Amaterasu, che li avrebbe risciacquati con l’acqua di un sacro pozzo e risputati sotto forma di vapore da cui sarebbero appunto state generate Tagorihime-no-Kami, dea della nebbia marina, Takitsuhime-no-Kami, dea della marea violenta, e Ichikishimahime-no-Kami, dea legata ai culti scintoisti e che sembra avere un ruolo di rilievo nella triade. Insomma la genealogia di queste tre dee dai nomi scoraggianti si trova nel Kojiki ma sembra uscita direttamente da uno spettacolo di Aldo Giovanni e Giacomo:

Le tre divinità sono venerate in un complesso di santuari denominato Munakata-taisha (宗像大社, ‘grande santuario di Munakata), che comprende tre sedi principali: lo Hetsugū, dedicato alla minore delle sorelle, Ichikishimahime-no-Kami, si trova nell’entroterra del Kyūshū, l’isola più a sud delle quattro principali che compongono l’arcipelago nipponico, nella città di Munakata; il Nakatsugū, dedicato alla sorella di mezzo, Takitsuhime-no-Kami, è invece sull’isola di Ōshima, a una decina di chilometri dalla costa; infine la sorella maggiore, Tagorihime-no-Kami, è venerata come accennato prima nell’Okitsugū, sull’isola di Okinoshima appunto, a una cinquantina di chilometri al largo nel mare di Genkai.
Questo tratto di mare collega il Kyūshū alla penisola coreana, e si ritiene che le tre sorelle Munakata proteggano i naviganti che solcano le sue acque spesso mosse. Sarà un caso ma posso confermare che in effetti ogni volta che in aereo attraverso lo spazio dal Giappone alla Corea puntualmente andiamo incontro a turbolenze, quindi sono abbastanza avvezzo a dire un fioretto alle tre divinità affinché non ci facciano colare a picco lol
Trovando il culto delle sorelle Munakata estremamente affascinante anche per l’immediato collegamento mentale che si è creato nella mia testa con le tre sorelle Halliwell (lo so, ho un problema, ma sono nato negli anni Novanta, capitemi) e non essendo ancora mai stato nel Kyūshū, ho deciso che il weekend lungo all’inizio di ottobre sarebbe stata l’occasione ideale per un viaggio spirituale alla scoperta della loro leggenda.


「Il potere del trio coincide col mio.」
Munakata di per sé non è una ridente cittadina che abbia senso visitare appositamente, ma fortunatamente non dista molto dal capoluogo del Kyūshū, Fukuoka, città assolutamente vivace e metropolitana dove ho fatto base in un ostello che A MIA INSAPUTA ma con mia grande gioia era della stessa catena di quello dove avevo soggiornato con piena soddisfazione ad Okayama (C.S. come dimenticare! ❤︎). Unica cosa che non mi ha convinto sono stati gli asciugamani che non erano segnalati a pagamento sulla loro pagina web e invece lo erano, ma fortunatamente la Guida Galattica per Autostoppisti mi ha insegnato a girare sempre con il mio asciugamano e quindi non ho dovuto prenderlo in prestito. Vedi che essere un individuo problematico che riempie le valigie oltre il necessario paga a volte!

Il viaggio alla volta di Fukuoka si apre all’aeroporto di Haneda con un gate cambiato a caso con un annuncio talmente silenzioso che mi stupisco di essermene accorto e di non essere salito sull’aereo per Osaka, e con 15 minuti di ritardo che comunque sono meglio della prospettiva di un volo cancellato, visto che quel weekend in Kyūshū doveva esserci un tifone e ho passato la settimana precedente a refreshare la pagina del meteo ogni due minuti per controllare che non mi saltasse la vacanza. Una volta imbarcati alla mia destra è seduto il genius loci del Kyūshū, un uomo d’affari con buone intenzioni ma un po’ irruento, proprio come mi immagino la gente di quest’isola che ha fama di essere un po’ vecchio stampo, che quando mi vede aprire un libro mi inizia a prendere a gomitate per indicarmi il pulsante che aziona la luce per facilitare la lettura e decide che la devo tenere accesa anche se non ho dimostrato alcun interesse, e che quando scendiamo mi tira giù la valigia dalla cappelliera buttandomela addosso, grazie ma guarda che non ti avevo chiesto niente quindi tieni giù le mani dalla mia roba? Avessi toccato io il bagaglio di un giapponese senza il suo esplicito consenso mi avrebbero estradato (quando aiuterò una signora sul volo di ritorno infatti mi premurerò di chiederle prima, e lei continuerà a ringraziarmi e a girarsi verso di me inchinandosi per tutto il tragitto fino all’uscita dell’aeroporto lol).
Fukuoka è tagliata a metà da un fiume, il Naka-gawa, che anticamente divideva due centri ben distinti: Fukuoka sulla riva ovest e Hakata sulla riva est. Nel 1889 le due città divennero un’unica entità amministrativa sotto il nome di Fukuoka, dando il via all’anarchia delle nomenclature perché si parla dell’aeroporto di Fukuoka (a soli 5 minuti di distanza dalla stazione principale, mica come gli aeroporti di Tokyo e Osaka che sono tutti affanculo, ho apprezzato tantissimo) ma della stazione dei treni di Hakata (che ovviamente mi ha fregato perché quando ho cominciato a informarmi per il viaggio cercavo la stazione di Fukuoka e non la trovavo e non capivo perché lol), del dialetto di Hakata, delle Hakata-bijin (博多美人, “belle donne di Hakata”) o dello Hakata-ramen. Piccola parentesi: vi ho già parlato di quanto mi prudano le mani ogni volta che parlando di viaggi con qualche giapponese mi sento consigliare una sfilza di cibi locali ma appena cito qualche attrazione culturale sulla faccia del mio interlocutore si proietta uno schermo bianco con la pagina di errore 404: non trovato, e anche in questo caso mi era stato assolutamente intimato di assaggiare il ramen di Fukuoka che pare essere l’unico motivo per cui visitare la città a sentire i nostri amici con gli occhi a mandorla. Ebbene voglio fare coming out riguardo a una cosa per la quale spero tutti gli amanti della cucina giapponese non se la prenderanno a male: A ME FA SCHIFO IL RAMEN, è pesantissimo, non lo digerisco, detesto il puzzo di cotenna di maiale ribollita che si sente a un chilometro di distanza dalle ramen-ya e 9/10 bisogna mettersi in fila per entrare in ste bettole. Mi sono fatto violenza e ci sono andato lo stesso a provare lo Hakata-ramen, altrimenti nessun giapponese avrebbe mai creduto che fossi davvero stato a Fukuoka, col risultato che non ho dormito tutta la notte proprio quando il giorno dopo dovevo svegliarmi alle 6 - poco male, fatto after.

Non so se sia stato il trauma 🐯🐴 della prima settimana a Kyoto nel 2013, quando praticamente non abbiamo mangiato altro, ma ad ogni buon conto l’ultima volta documentata in cui ho mangiato del ramen era il febbraio 2015, a Sapporo, quindi direi che dopo questa per altri tre anni abbiamo dato.
Se proprio di cibo vogliamo/dobbiamo parlare, a questo punto consiglio piuttosto gli yatai 屋台, caratteristiche carovane ambulanti piazzate ai cigli della strada dove è possibile fermarsi a mangiare probabilmente in condizioni igieniche precarie ma a prezzi decisamente ragionevoli. La cosa che più mi è piaciuta degli yatai è che un po’ come mi capitava nelle izakaya quando studiavo a Kyōto LA GENTE ATTACCA BOTTONE, cosa che mi è capitata molto di rado a Tokyo, dove mi pare che la tendenza sia un po’ quella di farsi gli affari propri. È stato proprio qui che mi si è presentata una rivelazione travestita da una coppia della prefettura di Ōita che ha cominciato a parlarmi del figlio in Europa e poi, una volta che ho raccontato loro il motivo del mio viaggio e ho accennato al mio cruccio circa il fatto che il 90% dei giapponesi non solo non si incula ste robe (pure io finché ero in Italia non ho mai sentito particolarmente il desiderio di andare in giro a chiese, quindi capisco che a uno possa non ispirare), ma non ne ha neppure proprio mai sentito parlare, mi ha saggiamente spiegato che la maggior parte della gente comincia a interessarsi a questo genere di viaggi solo più avanti con l’età. Quindi insomma praticamente mi hanno detto che faccio delle cose da vecchio lol, però vabbè, vorrà dire che farò sbarcare i pullman di Vacanziani in Giappone aprendo nuove rotte turistiche.

Nonostante prima di partire non avessi delle grandi aspettative su Fukuoka (o forse proprio per quello? lol), la città mi è piaciuta TAN-TIS-SI-MO. A parte le zone coperte dalle tre linee metropolitane (la blu, l’arancio e la verde, guarda e impara Sendai, cosa ne metti una verde acqua e una azzurrina che con quei colori si confondono) ci si affida molto agli autobus che OMG prendono anche le strade sopraelevate e le autostrade WHAAAAAAT IS THIS DA FUTURE?? È proprio su uno di questi che, dopo aver girato come un cretino per mezz’ora per il piazzale degli autobus di fronte alla stazione di Hakata cercando il piazzale F, per poi scoprire che il mio autobus partiva invece dal Terminal 1F, che ovviamente è un edificio completamente diverso, finalmente raggiungo la torre di Fukuoka, una discutibile struttura illuminata a tema Halloween dato il periodo, che però si trova proprio vicino al mare, con tanto di spiaggia urbana annessa lungo la quale è piacevolissimo anche solo passeggiare sentendo il rumore delle onde nell’oscurità (da quanto dicono i due tizi alla reception del mio ostello, in teoria si può fare il bagno ma nei fatti non lo fa quasi nessuno, come tutte le cose che in Giappone non è detto che si possano fare solo perché non sono proibite lol).

Non so per quale strano motivo ma questa zona per qualche istante mi riporta con la mente a Shanghai, che pure non c’entra proprio nulla dato che Pudong è decisamente diversa da questo panorama da finis terræ. Saranno gli hotel kitschissimi costruiti lungo la costa, non so lol

Arthur Dent: “Andiamocene via!”
Trillian: “Volentieri. Hai un posto in mente?”
Ford Perfect: “Io conoscerei un ristorante al termine dell'universo...”
Nei pressi della torre si trova anche una strada dedicata a Sazae-san, protagonista di un celebre manga giapponese entrato nel Guinness dei primati come serie a fumetti più longeva di sempre, ambientata proprio nel Kyūshū.

Non conosco quasi nulla di queste strisce se non che ne fu tratta una serie animata che andava in onda la domenica nel tardo pomeriggio, quindi prima dell’inizio di una nuova settimana lavorativa, motivo per cui è nata l’espressione Sazae-san-shōkōgun (サザエさん症候群, ‘sindrome di Sazae-san’), che corrisponde a quello che il mio amato Douglas Adams esprime benissimo nel suo “La vita, l’universo e tutto quanto” descrivendo il dramma di Wowbagger l’Eterno Prolungato, una creatura immortale:
“Chiudendo gli occhi in un’espressione di tedio e stanchezza, Wowbagger pensò che avrebbe potuto anche farcela a gestirsi la sua immortalità, se non fosse stato per le domeniche pomeriggio. All’inizio era stato divertente, se l’era spassata moltissimo, aveva vissuto pericolosamente, corso rischi, guadagnato un mucchio di soldi con investimenti a lungo termine e alto rendimento, e in genere goduto del fatto di vivere infinitamente più a lungo di tutti gli altri comuni mortali. Alla fine però si era accorto di non poter proprio reggere le domeniche pomeriggio e quel terribile senso di svogliatezza che comincia a instaurarsi verso le quindici, quando ci si rende conto di avere fatto tutti i bagni e le docce che era possibile fare, di avere fissato con aria vacua tutti gli articoli di giornale che era possibile fissare (evitando accuratamente di leggere tutti i loro contenuti), di non potere impedire alle lancette dell’orologio di avvicinarsi inesorabilmente alle sedici, a quel momento fatidico che segna l’inizio della lunga, tetra ora del tè dell’anima.”
A un tiro di schioppo dall’ostello in cui soggiornavo si trova invece il Sumiyoshi-jinja, santuario dedicato alle divinità protettrici dei naviganti e della poesia. Sebbene ne esistano molti altri con lo stesso nome sparsi per il Giappone, si ritiene che quello di Fukuoka sia stato il primo ad essere fondato, ed è uno dei tre più importanti insieme al Sumiyoshi-taisha di Ōsaka e a quello di Shimonoseki.

Curiosamente, anche il Sumiyoshi-jinja ospita una triade di divinità legate alla navigazione, i cosiddetti ‘Sumiyoshi-sanjin’ (住吉三神, ‘tre dei di Sumiyoshi’). Nati dalle abluzioni con cui Izanagi, il progenitore di tutti gli dei scintoisti, si purificò dopo essere tornato dall’oltretomba (dalle quali nacque anche Amaterasu, quindi direi che le due triadi hanno un rapporto di cuginanza? lol), questi tre dei hanno dei nomi che fanno sfigurare le tre sorelle Munakata: Sokotsutsu-no-O-no-Mikoto, divinità dei fondali nata dalle abluzioni nell’acqua profonda; Nakatsutsu-no-O-no-Mikoto, dio del mare interno e figlio delle abluzioni condotte tra gli abissi e la superficie; e Uwatsutsu-no-O-no-Mikoto, divinità della superficie marina, frutto delle abluzioni sul pelo dell’acqua. A legarli alla navigazione non è solo la loro origine marina ma anche il fatto che sarebbero la deificazione delle tre stelle che compongono la cintura di Orione, costellazione usata dai naviganti per orientarsi.
All’interno del santuario si erge una bizzarra statua dedicata al dio del sumō, sport nazionale del Giappone sviluppatosi in origine nel VI secolo in stretta correlazione con i riti scintoisti. A colpirmi è stato il pannello esplicativo che in giapponese riportava una spiegazione abbastanza neutra, mentre in inglese puntava su termini come ‘antichità’ e ‘tradizione’ per tagliare corto, cosa che mi ha fatto tornare in mente un articolo di Stephen Vlastos sulle ‘tradizioni inventate’ letto ai tempi dell’università in cui si raccontava di come oggigiorno la performance nel rango più alto del sumo, detto yokozuna, abbia poco a che vedere con l’istituzione arcaica, poiché nuove regole sono state aggiunte e buona parte del rituale è nuova, anche se mascherata di elementi tradizionali (il tetto in stile scintoista sospeso sul ring, il costume degli sfidanti). Nonostante quindi in meno di un secolo gli aspetti sostanziali dello yokozuna siano stati trasformati, la cerimonia di entrata nel ring fornisce agli spettatori uno spettacolo sensoriale convincente circa la continuità con un antico passato, a dispetto del suo scarso lascito culturale.

Le linee delle mani formano sui palmi protesi il carattere 力 (chikara, ‘forza’).
Piccola digressione non necessaria: la strada lungo cui si trova il Sumiyoshi-jinja puzzava da morire a causa degli alberi di ginkgo, e mi ha riportato immediatamente con la mente alla stradina che conduce alla chiesa di Altavilla, flagellata in autunno dallo stesso olezzo. Tra l’altro, il ginkgo è uno dei più begli esempi di fraintendimenti interlinguistici, perché il suo nome deriva dalla trascrizione scorretta da parte del botanico tedesco Engelbert Kaempfer di ‘ginkyō’, lettura a sua volta errata dei caratteri che ne compongono il nome, 銀杏, che in effetti potrebbero leggersi ‘ginkyō’ o ‘ginkō’ se solo il giapponese avesse un senso, ma dal momento che non ce l’ha in verità si leggono invece ‘ichō’. Ah, inutile dire che se anche si leggessero davvero ‘ginkō’ la ‘g’ sarebbe dura e non dolce come invece è pronunciata in italiano. Per dirla con una citazione dal film islandese ‘Englar Alheimsins’, “c'è così tanto, nella nostra cultura, che è basato su malintesi...”.
Altra chicca di Fukuoka è sicuramente lo Ōhori-kōen, un parco bellissimo che deve il suo nome di ‘grande fossato’ (大濠, ōhori) al fatto che l’ampio bacino d’acqua al suo interno una volta faceva parte del sistema difensivo del vicino castello di Fukuoka, oggi perlopiù in rovina.

Costruito tra il 1926 e il 1929, lo Ōhori-kōen, con il suo camminamento che attraversa le acque del laghetto al suo interno, è modellato sull’esempio cinese del Lago dell’Ovest - spiegato il motivo per cui mi ricordava tantissimo Hangzhou! Passeggiarci in quell’ora d’oro che precede il tramonto con la colonna sonora di Jade Bird che canta “Lottery” dalle casse dello Starbucks in riva alle sue sponde rimarrà probabilmente uno dei miei ricordi più preziosi di questo viaggio.

Una cosa che mi ha colpito mentre sull’aereo osservavo i nomi delle città del Kyūshū comparire a intermittenza sulla mappetta proiettata sugli schermi è stata la quantità di toponimi che utilizzano i caratteri cinesi per il loro valore fonetico e non semantico. Vero che nei toponimi ‘Fukuoka’ o ‘Nagasaki’ sono utilizzati per il loro significato rispettivamente di ‘collina della ricchezza’ (福岡) e ‘lungo promontorio’ (長崎), ma ce ne sono tantissimi altri in cui se ne considera semplicemente la lettura senza troppo badare al significato (Kurume 久留米, Usa 宇佐, Saga 佐賀, Omuta 大牟田, Sasebo 佐世保, Aso 阿蘇, Tsukumi 津久見, Akune 阿久根 e molti molti altri). Questo testimonia l’antichità degli insediamenti umani nella zona, dato che i caratteri cinesi furono introdotti nel VI secolo dalla Cina tramite la Corea, a cui il Kyūshū è geograficamente molto vicino, e inizialmente utilizzati quasi alla stregua di sillabe semplicemente per il loro suono, prima che alla coeva corte di Kyōto venisse in mente di cominciare a fare i simpaticoni e inventarsi letture alla cazzo tipo Yamato 大和 che non ha il minimo senso, e ovviamente molto prima che la capitale fosse spostata a Tokyo nel XVII secolo, quando ormai coi caratteri ci si inventavano le peggio cose (tipo ‘Atago’ 愛宕, ‘Toneri’ 舎人 o ‘Shinonome’ 東雲... WTF?!).
Un toponimo in particolare però ha catturato la mia attenzione mentre visitavo Fukuoka: Gion 祇園, quartiere che porta lo stesso nome di una zona di Kyōto. Secondo una teoria, fu usato lo stesso nome perché il santuario principale di questa zona e probabilmente il più importante per Fukuoka, il Kushida-jinja, ospita Susanoo, a cui è dedicato anche lo Yasaka-jinja di Kyōto che si trova appunto nel quartiere di Gion.

Se durante la prima metà di luglio Kyōto festeggia il Gion Matsuri, festival in cui palanchini detti omikoshi お神輿 e carri addobbatissimi detti yamaboko 山鉾 sfilano per la città invocando la protezione divina sulla città, nello stesso periodo Fukuoka è animata dallo Hakata Gion Yamakasa Matsuri, in cui giganteschi omikoshi vengono portati da sette gruppi di uomini che si sfidano in una corsa attraverso la città, in un rituale dalla funzione a sua volta apotropaica e, suppongo, anche artropatica.

Poco distante, si trova anche un tempio che si dice essere stato fondato da Kūkai in persona nel IX secolo, il Tōchōji.

Questo tempio ospita la più grande scultura in legno di Buddha del Giappone, a cui tecnicamente non era permesso fare foto ma OPS, ai donto spiiku Japaniz.

Immagino che la velocità con cui la batteria del telefono ha cominciato a scaricarsi subito dopo sia stato il giusto castigo di Buddha. 🔋
Sotto la statua si snoda un corridoio che inizialmente mostra dei dipinti dei vari inferni buddhisti e poi conduce a un tunnel completamente buio dove si viene invitati a fare lo stesso giochetto presente nello Zenkōji di Nagano, e cioè a cercare di toccare la Chiave del Paradiso, una chiave di metallo appesa a una parete che se toccata garantirebbe la salvezza e l'accesso alla Terra Pura. Forte della mia precedente esperienza, questo giro ce l’ho fatta al primo colpo, mica come l’altra volta che mi è toccato rifare la galleria due volte 🙈

Poco distante dal quartiere di Gion si apre una zona che è la sua totale antitesi, e cioè Canal City, un mega centro commerciale su millemila piani, veri e propri gironi dove le anime dei poveri dannati che hanno commesso l’errore di entrarvi vagano disperati alla ricerca di negozi che non troveranno mai perché non ci si riesce ad orientare tra tutti gli esercizi commerciali di cui è imbottita la struttura.

In verità vi dico, per essere un tempio dedicato al consumismo (sarà per quello che è vicino a Gion? lol) non è neppure sgradevole con le fontane e tutto quanto, tutto sommato non mette neanche quella tristezza che ogni tanto i centri commerciali infondono.

Il girone dei sodomiti, immagino?
Se Gion mi aveva ricordato Kyōto, ancora di più l’ha fatto il Dazaifu Tenmangū. Esistono diversi Tenmangū in giro per il Giappone, tutti dedicati a Sugawara no Michizane, raffinato politico e letterato del periodo Heian che, inviso alla famiglia Fujiwara impostasi alla corte di Kyōto, fu mandato a governare Dazaifu, nel Kyūshū, che ancora più di adesso era praticamente un sottilissimo modo di mandarlo affanculo in esilio, senza contare che, come nel caso di Saitama, già dal nome suona sufficientemente dasai (ダサい, ‘da sfigati’). Fu qui che morì nel 903, e in seguito alla sua morte Kyōto fu sferzata da una serie di calamità naturali che vennero interpretate come la vendetta dello spirito di Michizane, per placare il quale venne appunto edificato il Kitano Tenmangū a Kyōto, che ne venera la forma deificata, Tenjin, divinità celeste protettrice delle lettere. Sul luogo in cui venne sepolta la salma di Michizane, invece, sorse il Dazaifu Tenmangū.

Non ero sicuro che sarei riuscito ad andare anche a Dazaifu perché è a 30-40 minuti da Fukuoka, o meglio proprio dalla stazione di Tenjin, ironicamente (pare che vi sia un altro tempio dedicato a Tenjin, il Suikyō Tenmangū, che avrebbe dato il nome all’area, quella dove tra l’altro si trovavano gli yatai di cui vi ho parlato precedentemente). Sono però molto contento di esserci riuscito perché il Dazaifu Tenmangū vale decisamente una visita.
Il santuario è preceduto da un laghetto chiamato Shinji-ike 心字池 per il fatto che la sua forma dovrebbe ricordare l’ideogramma 心 (‘cuore’, ‘mente’). Lo si attraversa camminando su una sequenza di tre ponti: il primo e l’ultimo sono ad arco (in giapponese vengono chiamati taikobashi 太鼓橋 perché la loro forma ricorda il diametro di un tamburo taiko), quello centrale è invece piatto. Ci sono diverse simbologie celate dietro i tre ponti: il fatto che due di essi siano ricurvi e dunque più accidentati starebbe a significare quanto sia complicato per gli esseri umani accedere alla sfera del divino; inoltre, ognuno dei tre è collegato a una dimensione temporale. Il primo è il ponte del passato, e va attraversato senza voltarsi indietro; il secondo è quello del presente e va oltrepassato senza fermarsi; l’ultimo è quello del futuro, e occorre fare attenzione a non inciamparvi se si vuole che i propri desideri vengano esauditi. Si dice inoltre che non porti bene attraversare i tre ponti nell’ordine inverso, motivo per cui al ritorno bisognerebbe fare un giro più lungo per evitare il laghetto. Io ovviamente penso di aver inavvertitamente contravvenuto a tutti questi dettami lol

Vi sono altre tre forti analogie tra il Dazaifu Tenmangū e il Kitano Tenmangū: le statue bronzee del bue, animale che avrebbe trainato il palanchino che custodiva la salma di Sugawara no Michizane dal punto in cui morì sino alla sua tomba, presenti in entrambi i santuari; il fatto che anche al Dazaifu Tenmangū si tenga un mercatino delle pulci, in questo caso però a mesi alterni e ovviamente non quando ero lì io lol, dal curioso nome di omoshiroichi おもしろ市, ‘mercatino interessante’; infine, la presenza dei pruni, alberi molto amati da Michizane, e in particolare a Dazaifu del ‘pruno volante’ (tobiume 飛梅) che avrebbe lasciato Kyōto per seguirlo nel luogo del suo esilio e radicarsi proprio davanti all’edificio principale del santuario. Questa leggenda è così amata che uno degli articoli più venduti della zona è l’umegaemochi 梅ヶ枝餅, un dolcetto di riso ripieno di fagioli rossi con l’immagine di un fiore di pruno impressa sulla superficie.

Subito dietro all’edificio principale del santuario si trova il Museo Storico di Kankō, dove per pochi yen si accede a una sala sotterranea che ospita una serie di diorami (che non solo non è una bestemmia, ma può anche essere, sebbene non esattamente in questo contesto, un sinonimo di panorama, EDOGAWA RANPO SII FIERO DI ME) che illustrano le tappe salienti della vita di Sugawara no Michizane.

“Mi è capitato in passato di sentire la storia del francese che si dice abbia inventato il panorama, e sembra che almeno in principio il suo intento fosse quello di creare un nuovo mondo. Esattamente come gli scrittori sulla carta o gli attori sul palcoscenico cercano di dare vita a nuove realtà, senza dubbio anch’egli avrà voluto tentare di creare una sconfinata seconda dimensione all’interno di un piccolo stabile servendosi di quel suo particolare espediente scientico.” [Edogawa Ranpo, ‘La strana storia dell’Isola Panorama’]
Non molto lontano dal Dazaifu Tenmangū si trova anche il Museo Nazionale del Kyūshū. La coppia incontrata allo yatai mi aveva fortemente consigliato di visitarlo, ma non ne ho avuto il tempo, e poi diciamocelo, mo’ anche basta con tutta questa cultura.

Il museo è stato realizzato dall’architetto giapponese Kiyonori Kikutake, che a me non dice nulla ma magari a qualcuno di voi sì lol, e vi si accede tramite delle comode scale mobili che passano attraverso un tunnel illuminato dai colori dell’arcobaleno, molto LGBTQ+-friendly.


Lungo la via che conduce al Dazaifu Tenmangū si trova anche uno Starbucks molto particolare perché realizzato in collaborazione con l’architetto Kuma Kengo. Ero venuto a conoscenza dell’esistenza di questo edificio proprio quando a febbraio avevamo avuto l’onore di avere il famoso architetto come oratore a uno dei nostri eventi della Camera, ed effettivamente posso confermare che l’utilizzo del legno per creare una struttura caratteristica del suo stile sia molto d’impatto, però Kuma-san, lasciatelo dire: se non metti le prese della corrente per ricaricare il cellulare mi togli il 50% delle ragioni per entrare da Starbucks (l’altro 50% è, manco a dirlo, la connessione Wi-Fi).

MA ADESSO BASTA PERDERE TEMPO A PARLARE DI FUKUOKA E VENIAMO FINALMENTE AI TRE SANTUARI DI MUNAKATA, il vero motivo per cui ho intrapreso il viaggio che mi ha portato in Kyūshū.
Come vi accennavo all’inizio del post, la sorella minore è venerata nella città di Munakata, quella di mezzo sull’isola di Ōshima e quella maggiore sull’isola di Okinoshima, che però non è accessibile e può solo essere osservata dall’estremità settentrionale di Ōshima. I tre punti geografici da raggiungere dunque erano Munakata e le due estremità sud e nord di Õshima, e devo ammettere che i mezzi per arrivarci ci sono e funzionano, ma non sono esattamente comodissimi e incastrarli ha richiesto una rigorosa organizzazione che mi ha tenuto impegnato tutto il weekend precedente alla partenza lol.
Il piano era di partire presto da Fukuoka la mattina del 7 ottobre, arrivare alla stazione di Tōgo da cui si prende un autobus per raggiungere Kōnominato (神湊, ‘il porto degli dei’ WoWoWoWWW), dal cui imbarcadero si sale su un traghetto che conduce a Ōshima. Da lì, dopo aver visitato il Nakatsugū, abbastanza vicino al porto dell’isola, un autobus mi avrebbe portato all’altro capo dell’isola, dove si trova lo Okitsugū-yōhaijo (沖津宮遥拝所, ‘il luogo da cui scrutare da lontano l’Okitsugū’), una specie di santuario che funge praticamente da premio di consolazione per tutti quelli che non possono raggiungere Okinoshima, cioè di base tutti lol, visto che ci può mettere piede solo il sacerdote scintoista che officia le funzioni sull’isola e un numero limitatissimo di visitatori che non so esattamente cosa debbano fare per accedere a un simile privilegio. Finita la visita, sarei tornato indietro con il traghetto e avrei preso un altro autobus fino allo Hetsugū, per poi tornare a Tōgo e di lì di nuovo a Fukuoka.
Naturalmente, chiunque abbia stabilito gli orari dei traghetti e degli autobus lo ha fatto in modo che si incastrassero, però rispettare i tempi e tenere sempre d’occhio l’ora in modo da non sgarrare rispetto alla scaletta è stato abbastanza cardiopatico, dato che se mi fosse saltato anche un solo aggancio non sarei riuscito a fare tutto quello che mi ero prefisso. Curioso davvero, poi, che durante questa vacanza mi fossi portato dietro il romanzo “Tokyo Express” (controverso titolo con cui è stato ripubblicato “Ten to Sen”, letteralmente “Punti e linee”, già precedentemente tradotto con l’altrettanto discutibile “La morte è in orario”) di Matsumoto Seichō, il ‘Simenon giapponese’, che non solo non avevo mai letto ma che non sapevo fosse del Kyūshū, dove infatti buona parte del libro è ambientato. Dico ‘curioso’ perché non lo sapevo ma la trama di questo giallo è tutta giocata sull’incastro precisissimo degli orari dei treni, dei traghetti e degli aerei, in perfetta sintonia con il programmino della vacanza che avevo stilato lol (comunque, titolo ignorante a parte, ve lo consiglio tantissimo, è molto avvincente e mi ha letteralmente tenuto incollato alle pagine sino alla fine, era da un po’ che non finivo di leggere un libro così in fretta).
Così, la mattina del 7 ottobre, alle 7:46 del mattino alla stazione di Hakata salgo su un treno diretto verso Tōgo, accompagnato dal suddetto “Tokyo Express” e dalla mia droga più recente, risultato della mia malattia che mi spinge a comprare qualsiasi prodotto in edizione limitata i convenience store propinino a noi povere vittime del marketing stagionale, in questo caso il caramel pumpkin latte, da vera Scream Queen.

Tōgo mi dà subito l’impressione di essere un luogo che non ha altro senso se non quello di essere una stazione di cambio e un punto di partenza per il pellegrinaggio verso Munakata, tanto che un loop bus continua ad andare avanti e indietro per recuperare la gente alla fermata e portarla verso lo Hetsugū, che io però vedrò più tardi, di ritorno da Ōshima. In compenso il mio autobus, quello che dovrebbe condurre al porto, non si vede da nessuna parte e quando comincia ad essere in ritardo di tre minuti inizio a imparanoiarmi, tanto che monto con arroganza sul loop bus che palesemente fa un altro percorso e chiedo alla povera autista che a momenti mi spruzzava lo spray al peperoncino negli occhi se sto aspettando nel posto giusto, ottenendo delle (beh, doverose lol) scuse per l’attesa e la promessa che tra non molto arriverà anche il mio autobus. Quando finalmente, con cinque imperdonabili minuti di ritardo, finalmente compare, sono felice di lasciarmi Tōgo alle spalle dato che ho da poco notato che quella che pensavo essere una buca delle lettere insolitamente bianca invece che rossa è in realtà un contenitore dove inserire i libri che si vorrebbe mettere all’indice perché traviano le menti dei giovani.

Kyūshū, adesso sì che ti riconosco con questa vergine di ferro per libri che dà subito quel tocco di Medioevo e arretratezza.
Dopo la corsa in autobus e la traversata in traghetto, finalmente metto piede su Ōshima, e a pochi passi dall’imbarcadero, ecco che raggiungo il Nakatsugū, dove è venerata Piper Halliwell Takitsuhime-no-Kami, la sorella di mezzo che ha il potere di fermare il tempo controlla la marea violenta.

Il corpo principale del santuario (dove quel giorno era in servizio un sacerdote scintoista che quando ha saputo che ero italiano ci ha tenuto a farmi sapere che era stato in Italia in viaggio di nozze causandomi un attimo di sgomento perché mi ero dimenticato che nello scintoismo non c’è l’obbligo di celibato ecclesiastico) si trova in cima a una scalinata, che quel giorno veniva spazzata da una vecchina che ha photobombato alla grande uno dei miei rarissimi tentativi di selfie facendomi immediatamente desistere.

Sul lato sinistro rispetto al corpo principale del santuario si apre un boschetto dove si trova l’Ama-no-Manai, il pozzo dal quale Amaterasu avrebbe attinto l’acqua usata per risciacquare i pezzi della spada del fratello da cui sarebbero poi state generate le tre dee di Munakata.

Per raggiungerlo ho dovuto schivare tante di quelle ragnatele piene di ragni grossi come albicocche che ragno violino levate proprio, ma qualcuno mi spiega perché in questo paese gli insetti sono grandi il triplo che in Italia?

Ai lati del santuario, invece, se ne aprono due di più piccoli dedicati a Hikoboshi il mandriano e Orihime la tessitrice, personificazione delle stelle Altair e Vega che, secondo Bakemonogatari il folklore giapponese, erano alacri lavoratori fino a quando non si innamorano e iniziano a trascurare il loro dovere. Tenuti separati in modo da non disattendere ai propri compiti, possono finalmente incontrarsi una volta all’anno il 7 di luglio durante la notte di Tanabata. Una bella metafora di che priorità i giapponesi pensano abbiano le relazioni rispetto al lavoro.

Ammetto di aver girato un po’ prima di capire dov’era il santuario di Orihime, perché è infrattato nella boscaglia sulla sinistra appena varcato il torii del Nakatsugū, ed è preceduto da un fiumiciattolo che rappresenterebbe la Via Lattea, che divide le due stelle amanti, nelle cui acque teoricamente si troverebbero dei vetrini colorati che gli abitanti dell’isola ripuliscono e vendono spacciandole per residui di stelle (oookayyy..?). Di lì ci si arrampica tramite una catena piazzata alla bell’e meglio su una piccola salita in cima alla quale si trova il piccolo santuarietto.

Il santuario di Hikoboshi, posto specularmente rispetto a quello di Orihime in modo che i due amanti possano guardarsi (awwww), è preceduto da una zona sacra a Ebisu, uno dei sette dei della fortuna e protettore dei pescatori, la cui figura si confonde con quella di Hiruko, il ‘figlio mignatta’ della coppia cosmogonica Izanami e Izanagi, nato deforme perché nel rituale di accoppiamento fu la donna a parlare prima dell’uomo. Secondo alcune versioni del folklore giapponese, infatti, questa specie di sanguisuga, abbandonata in mare dai genitori, crebbe fino a diventare una divinità in piena regola con il nome di Ebisu.

Prendendo poi un autobus di cui ero l’unico passeggero - l’autista, obbligato per contratto a illustrare in un giapponese formalissimo tutti i luoghi in cui passavamo, si stava palesemente chiedendo chi glielo faceva fare, gliel’ho proprio letto negli occhi riflessi sullo specchietto retrovisore che non ci credeva che capissi quello che diceva... mi domando, ma se non ci fossi stato neppure io avrebbe comunque ripetuto tutta quella pappardella tra sé e sé? - arrivo al suggestivo Okitsugū-yōhaijo, arroccato sul pendio di una scogliera che digrada verso il mare.

È proprio da qui che, tendendo lo sguardo, nelle giornate serene è possibile avvistare la lontana Okinoshima. Purtroppo nonostante il tempo fosse abbastanza favorevole quel giorno c’era un po’ di foschia, ma se ne intuiva comunque la forma (ma 50 chilometri all’orizzonte sono così tanti? stupidamente pensavo che sarebbe apparsa UN FILINO PIÙ vicina).

“[...] una piccola isola del diametro di meno di due ri, che emerge dalle acque come un manjū verde rovesciato, separata da tutte le altre. Oramai è considerata praticamente un’isola deserta, e fatta eccezione per qualche pescatore della zona che di quando in quando vi approda spinto da un capriccio, non se ne cura quasi nessuno. Oltretutto, isolata dal mare burrascoso della punta di un promontorio, salvo in casi di estrema bonaccia è pericoloso per i piccoli pescherecci avvicinarvisi, e d’altra parte non è nemmeno un posto per il quale valga la pena correre dei rischi. La gente del luogo la chiama comunemente Okinoshima, ‘l’isola al largo’ [...]” [Edogawa Ranpo, ‘La strana storia dell’Isola Panorama’]
Su Okinoshima si troverebbe l’Okitsugū, dove è venerata Prue Halliwell Tagorihime-no-Kami, sorella maggiore telecinetica collegata alla nebbia marina, proprio quella che nascondeva l’isola alla vista lol. Tra l’altro quanto calza a pennello che l’isola più romita e inaccessibile sia quella dedicata alla sorella maggiore, dal momento che Prue Halliwell alla fine della terza stagione muore (ma devo mettere uno SPOILER ALERT per una serie TV andata in onda nel 2001 o possiamo considerare il pericolo archiviato?) e ci diventa quindi irraggiungibile?

Quanti traumi mi ha lasciato questa scena, QUANTI. Ci piango ancora la notte ogni tanto.
Come buona parte dell’esperienza religiosa giapponese (ma non solo a pensarci bene), l’aspetto più affascinante è proprio questo effetto ‘vedo/non vedo’ lol, cioè il fatto che l’isola sia effettivamente visibile, quindi se ne possa constatare l’esistenza, ma che sia inaccessibile. In questo senso di ‘inavvicinabilità’ c’è tutto lo spazio necessario alla fede, così come nel caso delle tre leggendarie insegne imperiali (lo specchio di Amaterasu, la spada di Susanō e il gioiello ricurvo), che si dice siano custodite rispettivamente nel santuario di Ise, in quello di Atsuta e nel Palazzo Imperiale (i primi due tranquillamente visitabili da chiunque), ma che non vengono mostrati al pubblico. Ritrovarmi su un promontorio di un’isoletta del Kyūshū a chilometri da qualsiasi luogo abbia mai potuto chiamare ‘casa’ a scrutare l’orizzonte per cercare di individuare Okinoshima è stato senz’altro il momento più mistico di questa sorta di ‘viaggio spirituale’, e quando l’ho finalmente avvistata mi sono sentito come catapultato nel romanzo di Edogawa Ranpo.
A dire la verità, l’isola che è servita da ispirazione per il racconto di Edogawa è l’Isola delle Perle di Mikimoto, nella prefettura di Mie (di cui vi parlerò più avanti in questo post chilometrico che giustamente nessuno leggerà lol), ma si può ragionevolmente supporre che Okinoshima abbia avuto la sua influenza non solo perché porta lo stesso nome, ma anche perché la descrizione nel romanzo sembra corrispondere molto più a quest’ultima che non all’Isola delle Perle di Mikimoto, che anzi è vicinissima alla costa e non ne è affatto separata da un mare burrascoso.
Terminata la mia esplorazione di Ōshima torno sui miei passi e, riapprodato sull’isola principale, giungo all’ultima tappa del mio pellegrinaggio: lo Hetsugū, dedicato a Phoebe Halliwell Ichikishimahime-no-Kami, la sorella con le premonizioni minore.

Lo Hetsugū, con la sua entrata trionfale e la sua foresta, mi ha ricordato il santuario di Ise, dove in effetti è venerata la madre delle tre sorelle, Amaterasu. Una cosa che mi lascia sempre divertito è come nella spiritualità nipponica non sia raro che, se per esempio un pellegrinaggio è spalmato su un percorso molto lungo, venga riprodotto in scala minore su un territorio più facilmente accessibile, in modo che i fedeli possano completarlo più agevolmente. Onestamente mi sembra una paraculata incredibile, una trovata di una pigrizia tale che mi stupisco che se la siano inventata i giapponesi e non gli italiani lol, e ho potuto osservarla messa in pratica proprio allo Hetsugū: poiché il Nakatsugū e ancora di più l’Okitsugū non sono comodissimi da raggiungere, nella foresta che circonda il santuario principale ne sono stati edificati due più piccoli che vengono chiamati Teinigū (第二宮, ‘il secondo santuario’) e Teisangū (第三宮, ‘il terzo santuario’), sostitutivi rispettivamente dell’Okitsugū e del Nakatsugū.

Diciamo che un po’ mi ha fatto incazzare vedere che tecnicamente farsi un giretto per lo Hetsugū e fermarsi davanti agli adiacenti due santuari è karmicamente equiparato alla sbatta che mi sono fatto io tra traghetti e autobus, ma d’altra parte il Teinigū e il Teisangū non sono neanche lontanamente paragonabili al Nakatsugū e all’Okitsugū(-yōhaijo) per suggestività e architettura, quindi nessunissimo rimpianto.

Immersa nella foresta dello Hetsugū si trova anche una collinetta che è considerata il luogo più sacro del santuario, il Takamiya-saijo, dove cresce un albero su cui scenderebbero le tre divinità durante le cerimonie rituali, in uno scenario da The Blair Witch Project.

“In October of 2018, an Italian tourist disappeared in the woods near Munakata, Kyūshū while taking pictures for his blog...” [semicit.]
E a proposito di alberi, ce n’era uno che cresceva nello spiazzo antestante l’entrata del santuario che produceva dei frutti trilobati mai visti che però mi sono sembrati molto appropriati per il luogo visto che mi ricordavano la triquetra, simbolo appunto del Potere del Trio lol


Uscendo, tra l’altro, mi sono accorto che il fiumiciattolo che delimitava il perimetro sacro pullulava di granchietti (蟹 kani), che per carità erano anche carini ma io ero venuto qui per i kami (神 ‘divinità’), quindi insomma, mi sa che ho preso un granchiOKAY la smetto lol.

Voi ridete (o forse no giustamente lol), ma io è ancora così che lo fraintendo il giapponese.
Per una fortunata coincidenza astrale, tre settimane dopo il mio viaggio spirituale ai santuari di Munakata, neanche il tempo che mi guarissero le vesciche per tutto quello che avevo camminato lol, un evento della Camera mi ha riportato in Kansai, e avendo a disposizione il weekend ne ho approfittato per visitare anche l’Isola delle Perle di Mikimoto di cui vi accennavo.

“Persino tra gli stessi abitanti della prefettura di M., probabilmente sono in molti a non essersene mai accorti. All’estremit�� meridionale del distretto di S., proprio dove la baia di I. si affaccia sull’Oceano Pacifico, si trova una piccola isola del diametro di meno di due ri, che emerge dalle acque come un manjū verde rovesciato [...]” [Edogawa Ranpo, ‘La strana storia dell’Isola Panorama’]
Quest’isoletta, precedentemente nota come Ojima, si trova dirimpetto alla costa di Toba, nella prefettura di Mie, a cui sin dal 1970 è collegata da un ponte sopraelevato. Fu proprio qui che nel 1893 Mikimoto Kōkichi, un imprenditore locale figlio di ristoratori, riuscì a realizzare la prima coltivazione di ostriche perlifere al mondo, diventando ben presto uno dei più facoltosi uomini d’affari della zona. Si dice che la sua passione per le perle fosse dovuta al fascino che su di lui esercitava la figura delle ama (海女), le pescatrici subacquee che tradizionalmente s’immergono nel mare del Giappone alla ricerca di prodotti del mare (in particolare l’abalone), note anche al pubblico italiano tramite il reportage fotografico di Fosco Maraini realizzato nel 1954. Pare tra l’altro che mentre in origine le ama si tuffavano coperte soltanto di un perizoma, fu proprio Mikimoto a inventare la muta bianca che indossano ancora oggi nel momento in cui decise di coinvolgerle nel suo progetto. Edogawa Ranpo ebbe modo di assorbire tutte queste suggestioni per creare il suo romanzo “La strana storia dell’Isola Panorama” quando tra il 1918 e il 1919 faceva il contabile presso un cantiere navale proprio a Toba, dalla cui finestra si poteva facilmente vedere l’isola di Ojima, tant’è vero che il protagonista che arricchitosi riesce a realizzare il proprio paradiso terrestre su un’isola ricorda molto la figura di Mikimoto Kōkichi e le sommozzatrici-sirene che ingaggia nel romanzo sono un chiaro riferimento alle ama.

「伊勢の海の あまの島津が 鰒玉とりて 後もか 恋のしげけむ」 “Ise no umi no / ama no shimatsu ga / awabitama / torite nochi mo ka / koi no shigekemu” (Man’yōshū 7: 1325) “La pescatrice isolana del mar di Ise raccoglie le perle dell’abalone. Se anch’io potessi aver la mia, pur dopo averla colta l’amerei”
La figura delle ama è rintracciabile persino nella più antica raccolta di poesie giapponesi giunta sino a noi, il Man’yōshū, compilata intorno alla seconda metà dell’VIII secolo e contenente componimenti che risalgono addirittura alla seconda metà del V, ma è pur vero che a meno che non sia usata la grafia 海女 (i cui caratteri significano inequivocabilmente “donna del mare”), risulta spesso difficile asserire con certezza se i poemi trattino proprio delle pescatrici dato che lo stesso termine scritto con i sinogrammi 海人 o nell’alfabeto sillabico あま fa riferimento ad una persona che si occupa di pesca in senso lato, e quindi potrebbe essere tradotto anche come ‘pescatore’ (che aveva un solco lungo il viso, come una specie di sorriso, NANANANANANANANA NANANANANANANANAAA). Di indubbio c’è invece il fascino di queste donne e dell’isobue (磯笛, ‘il fischio della spiaggia’ o 海の嘆き umi no nageki, ‘il lamento del mare’), l’acuto fischio tipico che emettono risalendo dopo l’apnea per riequilibrare la respirazione e decomprimere i polmoni inducendo un’iperventilazione. Metafora del duro mestiere delle pescatrici, questo suono è stato incluso tra i 100 più rappresentativi del Giappone e dovrebbe ispirare in chi lo ascolta un sentimento di malinconia, pari solo a quello che effettivamente si prova quando si pensa che oramai queste donne sopravvivono solamente come attrazione per i turisti, e per quanto sia stato emozionante vederle all’opera nel mare dell’Isola delle Perle di Mikimoto, in effetti devo ammettere che non mi sono sentito completamente a mio agio nel far parte del gruppo di curiosi che scattavano loro foto mentre si tuffavano dalla barchetta che le trasportava per raccogliere abaloni preventivamente gettati lungo la costa a uso e consumo dei visitatori.
L’isola ospita anche un museo dove è sintetizzata la storia delle perle in Asia e dove sono esposti molteplici manufatti realizzati con esse. Sin dal periodo Nara (710-794) si riteneva che fossero uno dei sette tesori del Buddhismo, materiali preziosi che rappresentavano un valore spirituale dell’essere umano, nel caso delle perle l’altruismo. Vi sono versioni discordanti su quali sarebbero gli altri sei ma in linea generale possiamo annoverare l’oro (tesoro della convinzione), l’argento (tesoro della virtù), il lapislazzuli (tesoro della coscienza), l’agata (tesoro dell’ascolto), il corallo (tesoro della generosità) e l’ambra (tesoro della saggezza). Nel periodo Heian (794-1185), il territorio di Shima doveva versare un tributo in perle alla corte imperiale, mentre nel periodo Edo (1603-1868) se ne faceva un uso principalmente medicinale (e i no-vax muti).

Per ordine di chi? 🍑
Vicino al museo c’è anche uno shop dove palesemente si vedeva che ero entrato per sport visto che non potevo permettermi nulla di quello che vendevano, fino a quando scherzando con l’amico giapponese che aveva accompagnato me e la mia capa sull’isola non ho detto che nel caso ci fosse stato in vendita un rosario buddhista con una perla ci avrei fatto un pensiero e mi sono sentito rispondere: “Ma guarda che li vendono, eccolì là”. A parte il fatto che non so se mi abbia sentito qualcuno del marketing e si sia precipitato a crearne uno all’occorrenza perché il tempismo è stato sconvolgente, però visto che non costava neppure tanto (probabilmente la perla era di plastica lol) non ho potuto tirarmi indietro e ho aggiunto il terzo rosario al polso.
Poco distante si trova anche un memoriale dedicato al fondatore dell’isola, Mikimoto Kōkichi. Oltre ad una lunga serie di pannelli che illustrano la sua vita e raccontano la sua storia di imprenditore di successo, è presente anche una ricostruzione del ristorante di udon “Awako” gestito dalla sua famiglia. La figura di questo ricchissimo uomo d’affari, signore dell’isola che prenderà il suo nome, non può non aver ispirato Edogawa Ranpo nella creazione del protagonista de “La strana storia dell’Isola Panorama”. Curioso e molto suggestivo, tra l’altro, che prima di avere successo con le sue perle coltivate Mikimoto veda più volte i suoi molluschi da un’invasione di alghe altrimenti detta “marea rossa", lo stesso colore che domina la scena conclusiva del romanzo in cui allo stesso modo il protagonista perde tutto.

Toba non sembra aver dimenticato il passaggio di Edogawa Ranpo: tra le sue casette di legno dall’aria vissuta e i vicoletti che si snodano lasciandosi il mare alle spalle, ospita infatti un piccolo museo dedicato allo scrittore di mystery e noir nipponico.

Precedentemente dimora di Iwata Jun’ichi, storico, scrittore e illustratore locale che collaborò con Edogawa e divise con lui proprio quella abitazione per un certo periodo, espone diversi oggetti collegati al maestro giapponese del mistero cercando di ricreare l’atmosfera dei suoi racconti, e per quanto non sia forse eccessivamente istruttiva mi sento di consigliarne la visita per tentare di captare l’aura di Edogawa che, chissà, magari come i protagonisti di altre sue opere vi spia dalla soffitta o nascosto dentro a una poltrona...
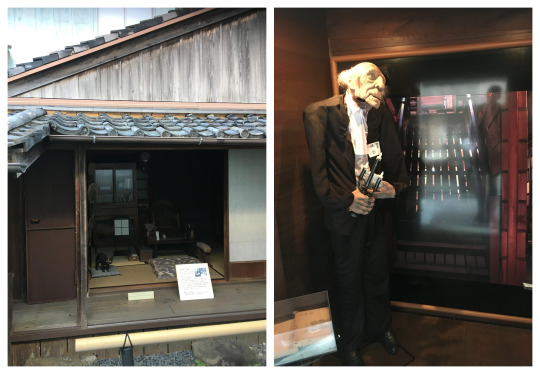
Shout-out per il corvo trashissimo sulla spalla del maggiordomo che gracchiava “Nevermore! Nevermore!” con una vocetta metallica preregistrata.

A sinistra, la moneta di rame da due sen che dà il titolo al primo racconto di successo di Edogawa. A destra, è il gatto ad essere inquietato dal vicentino.
Non sono sicuro di riuscire a trasmettere a parole in questo post l’emozione di metaletterarietà che ho provato aggirandomi per le isole del Kyūshū e di Mie, rincorrendo Edogawa Ranpo sulle tracce del suo romanzo. È stato grazie a lui che ho scoperto dell’esistenza di Okinoshima e dell’Isola delle Perle di Mikimoto, e riuscire a visitarle dopo averne lungamente letto e studiato per parlarne nell’introduzione de “La strana storia dell’Isola Panorama” mi ha fatto sentire quasi catapultato tra le pagine del suo racconto, o forse è più vero il contrario, e cioè che mi è parso che la sua opera prendesse vita, proprio come in una specie di diorama che è imitazione talmente ben riuscita del reale che lascia meravigliati nella sua illusorietà.
Oltre a questo, gli devo però anche la prima pubblicazione di una mia traduzione. Ricordo ancora l’emozione provata la prima volta che, appena immatricolato a Ca’ Foscari nel lontano 2010, sono entrato in Ca’ Foscarina e ho visto tutti i libri delle edizioni Mille Gru, dedicate alla letteratura giapponese, che fino ad allora avevo solo sporadicamente trovato in qualche libreria della mia città, riempire interi scaffali uno accostato all’altro. Ricordo il biglietto da visita farlocco preparato per il corso di trattativa commerciale con il quale finsi giusto il tempo dell’esame di lavorare come traduttore per Marsilio, e già quella finzione mi parve irrispettosa lol. La retorica dei sogni che si avverano è stucchevole, mi rendo conto, ma ho iniziato a studiare giapponese perché un giorno mi sarebbe piaciuto diventare un traduttore e contribuire ad ampliare l’offerta di opere di quegli autori che tanto mi avevano affascinato e che avrei fortemente voluto che più persone potessero leggere, e sebbene io non abbia di certo scoperto la cura per il cancro ma semplicemente tradotto un romanzo, sono estremamente felice di questo piccolo passo che si muove nella direzione che avrei sempre voluto intraprendere.

“Where’s Ranpo?” © Courtesy of C.S., grazie infinite stella, con questa foto mi hai fatto un regalo gigantesco (T ^ T)
"La strana storia dell’Isola Panorama” arriva dopo un anno e qualche mese di ore rubate al sonno ogni giorno dopo 9 ore di ufficio (visto che purtroppo la traduzione letteraria non può essere il lavoro che mi paga l’affitto, nonostante sia esattamente quello che vorrei fare ‘da grande’), di piatti non lavati e camicie non stirate per guadagnare tempo, di piccole rinunce nel weekend o durante le vacanze, e dopo quasi un altro anno di labor limae con l’editore per presentarlo al meglio. Ci ho lavorato a Tokyo, a Izu Ōshima, in Italia, in tutti i luoghi e in tutti i laghi. È stata un po’ una sfida all’inizio cercare di entrare nello stile di Edogawa Ranpo che, come un mandala, si dipana intorno a quello che effettivamente vuole dire in cerchi concentrici che vanno restringendosi fino a cogliere il punto, ma perdersi nelle sue frasi cercando di ricondurle alla mia lingua madre è stata un’esperienza incredibile. Prima di questo avevo già tradotto un altro romanzo di un altro autore, ma il progetto era naufragato perché sfortunatamente i diritti erano già stati acquistati, tra l’altro probabilmente non troppo prima che io lo avessi terminato, e per tutto il tempo che ho impiegato a tradurre “La strana storia dell’Isola Panorama” ho avuto l’ansia che chissà, magari qualcun altro ci stesse lavorando e potesse pubblicarlo prima che io riuscissi a finirlo, per cui quando l’ho visto annunciato ufficialmente ho tirato un enorme sospiro di sollievo.
L’altra cosa che però mi ha profondamente commosso e colpito è stato ricevere le foto del libro dalle persone più disparate, magari dall’altra parte del globo, magari che non sentivo più da un sacco di tempo e che, anche non essendo necessariamente fanatici della letteratura giapponese, hanno deciso di fidarsi e di dare il loro sostegno a questo romanzo. Un po’ come quando ho iniziato il blog, ho avuto modo di risentire persone provenienti dalle più svariate fasi della mia vita, e mi sono sentito pieno di gratitudine per tutto il supporto ricevuto, semplicemente. Quello che era solo un documento di Word sul mio computer portatile ormai vecchissimo adesso è un volumetto di 192 pagine che vedo girare su internet, su Twitter, su Instagram, maneggiato da persone che a volte non conosco ma che sono entusiaste perché fan di Edogawa Ranpo, o perché contano di usare questo libro per i loro progetti di tesi, o perché avevano letto il manga che finora era l’unico adattamento tradotto in italiano di questo racconto e vogliono leggere l’opera originale. Se l’avete già letto o vorrete leggerlo, sarò davvero felice di sentire il vostro parere, perché dopo averci lavorato così a lungo e con tutta la dedizione di cui sono stato capace mi interessa molto il riscontro dei lettori. Vi lascio qui sotto alcuni link utili e magari anche qualche recensione che ho trovato nel Web, in una lista che cercherò di tenere aggiornata se ne troverò altre più avanti. Nel frattempo, un grazie immenso a tutti quelli che l’hanno letto, che l’hanno comprato, che l’hanno aspettato, che hanno supportato il progetto, che hanno creduto che un giorno sarebbe finalmente arrivato in libreria, che mi hanno incoraggiato e spronato anche quando le pagine ancora da tradurre non sembravano diminuire. Sento che vorrei dire molto altro, ma semplicemente, grazie 💙

Easter egg per chi è arrivato a leggere fino a qui: per l’immagine di copertina, ho scelto un’opera di Kawase Hasui, un esponente dello shin-hanga (新版画, che potremmo definire le stampe ukiyoe moderne), “Futago Islands of Matsushima”. Matsushima, con le sue isolette disseminate di pini, è uno dei tre paesaggi più suggestivi del Giappone, ma in particolare le due ritratte in questa illustrazione vengono chiamate ‘le isole gemelle’, ed essendo l’intera vicenda giocata su uno scambio di identità tra due sosia, ho pensato che potesse essere adatta...
La strana storia dell'Isola Panorama - Marsilio Editori Scheda libro nel catalogo Marsilio Sonzogno Recensioni: Libri e Recensioni.com MondoFox: 10 libri (e qualche fumetto) da non perdere a marzo 2019 I dolori della giovane libraia Cinemalia.it laRegione - Follie da un altro mondo Alias - Il Manifesto Videorecensione: Matteo Fumagalli Videorecensione: spiccycullen Consigli di Lettura: 'La strana storia dell'Isola Panorama' di Edogawa Ranpo Il Segnalibro - RadioSvizzeraItaliana
6 notes
·
View notes
Text
Cose che forse non valevano molto la pena
Dopo un maggio e un giugno un po’ instabili, a Tokyo fanno ormai da settimane quasi 40 gradi fissi e l’umidità ha raggiunto livelli tropicali. Ho capito perché lo chiamano il Paese del Sol Levante: in estate si registrano praticamente le stesse temperature che sulla fotosfera.
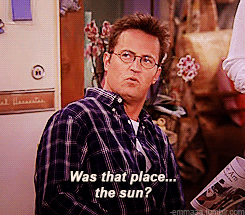
Per quanto personalmente preferisca comunque questa sofferenza a quella inflittaci dall’inverno, bisogna ammettere che simili condizioni meteorologiche ti spingono a valutare molto attentamente quali cose valgano effettivamente la pena di abbandonare il sollievo offerto dall’aria condizionata sparata a palla nella propria stanza ー le bollette che ne conseguono, per esempio. Purtroppo ho cominciato solo di recente a svolgere questo esercizio diligentemente, e ci sono state cose negli ultimi mesi che mi hanno strappato alla comodità del mio appartamento ma da cui, onestamente, credo di essere stato bellamente gabbato. Le ho dunque raccolte per voi e procederei a citarvele di seguito:
① Il Festival dei Glicini al santuario di Kameido.

Il Kameido Tenjinja di per sé è un piacevole santuario nel quartiere di Kōtō, dove tutte le farmacie vendono carta igienica al mango e ai frutti tropicali (tornerò), relativamente vicino allo Sky Tree e dedicato a Sugawara no Michizane, poeta del periodo Heian che assurse dopo la morte a divinità protettrice delle lettere, venerata a Kyōto al mio amato Kitano Tenmangū (è proprio su questa falsariga che il Kameido Tenjinja viene anche chiamato Kameido Tenmangū).

#throwback a uno dei miei primi post da Kyōto quando sproloquiavo sulla commistione tra modernità e tradizione. Ed era subito orientalismo da treno
Iconici sono i suoi due ponti ad arco, l’Otokobashi (男橋, ‘Ponte degli Uomini’) e l’Onnabashi (女橋, ‘Ponte delle Donne’), che in un inaspettato afflato femminista ante litteram rappresentano rispettivamente il primo il passato e il secondo la speranza nel futuro.

Altrettanto iconici sono i tralicci di glicine che adornano il santuario, immancabili in qualsiasi rappresentazione del luogo nelle più svariate stampe ukiyo-e e protagonisti della festa che si svolge tra la fine di aprile e i primissimi di maggio.

A sinistra, "Ponte del santuario di Tenjin a Kameido" di Utagawa Hiroshige, 1856; a destra, “Kameido” di Hiroshi Yoshida, 1927. Ci hanno messo settant’anni ma son cresciuti bene sti glicini, eh? lol
Quindi insomma, fomentato dalla letterarietà di questo luogo nonché amante dei glicini che non mi capita spesso di vedere nella giungla di cemento che è Tokyo, potete immaginare quanto possa essere rimasto deluso nello scoprire che non fosse rimasto mezzo E DICO MEZZO fiorellino che non fosse completamente avvizzito in tutto il santuario.

“Perché a me neanche un fiorellino?” 100% CAN RELATE
Tra l’altro il fine settimana successivo, non contento, ci ho pure voluto riprovare e sono andato al santuario di Nezu per il Festival delle Azalee, E ANCHE LÌ era tutto quanto sfiorito.
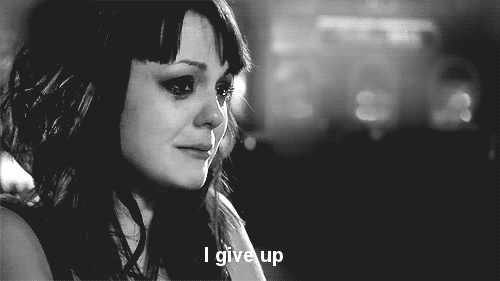
② Vittima sacrificale di questa poetica strategia di marketing stagionale che ossessiona gli abitanti di Tokyo con i festival dei fiori più vari, vi pare che potessi darmi per vinto? OVVIAMENTE NO, e così, ispirato dalla rivista Tokyo Trend Ranking, una pubblicazione gratuita che si trova in tutte le stazioni della metro e a cui mi ha iniziato la mia capa, ho deciso di spingermi fino a Satte, nella prefettura di Saitama (dai tokyoiti affettuosamente apostrofata con il nomignolo di ‘Dasaitama’, in cui ‘dasai’ ダサい significa ‘da sfigati’), a quasi due ore di treno da Tokyo, per ammirare quella che doveva essere una ricca e splendida fioritura di ortensie (ce le avete presente? quei fiori che appena li vedi fanno subito casa di nonna) lungo l’argine del Gongendō.
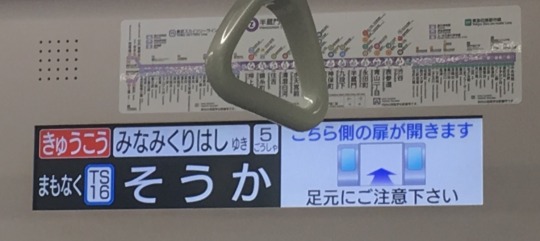
Menzione di merito per un paio di toponimi incontrati durante il viaggio in treno e in autobus: la città di Sōka, che potremmo tradurre come ‘ah sì?’, per cui immaginatevi i dialoghi derp che devono subirsi gli abitanti di sto posto sperduto: “dove abiti?” “a Sōka” “ah sì?” “eh sì”; e la fermata di Arajuku, che giustamente visto che siamo a Dasaitama dev’essere la versione dasai di Harajuku lol

Mettiamola così: la scampagnata ci stava, nonostante il freschetto da giacchino che non ci si aspetterebbe il 16 giugno, ma diciamo che per quanto godibile e bucolicamente poetico il paesaggio non vale il viaggio. E lo dico nonostante fossi partito con pochissime aspettative lol

I AM A BEAUTIFUL HYDRANGEA! Ortensia fiore totemico, dovevo venire fino a Satte per poter finalmente sbocciare.
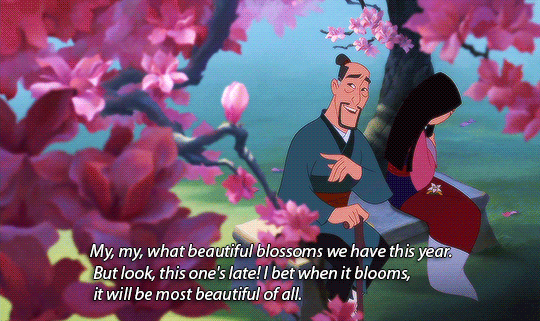
E a proposito di totem, a dare un senso a sta giornata quantomeno c’erano LE CAPRETTE, miei animali guida 💙

Piccola vergognosa parentesi mistica: mi rendo conto che il prossimo passo sarà diventare un No-Vax e iniziare a dare credito ai terrapiattisti, però sono sempre stato affascinato dall’astrologia e di recente mi è capitato di leggere alcune teorie circa il mio segno zodiacale, il Capricorno, governato dal pianeta Saturno che secondo alcune scuole di pensiero è profondamente legato anche etimologicamente a Satana (e d’altra parte vogliamo dimenticarci che Sailor Saturn in giapponese è Sērā Satān セーラーサターン?).
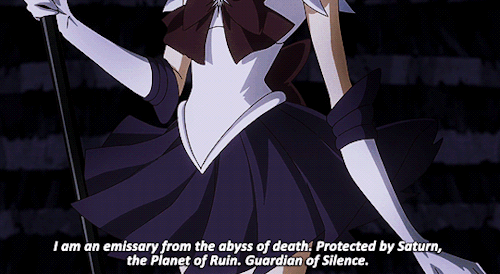
Anche simbologicamente il caprone è spesso collegato al Demonio e il colore associato al Capricorno è effettivamente il nero, ma a parte questo indovinate che data è associata a Satana? Il 23 dicembre. E il giorno della settimana? Il lunedì. Non credo che serva che vi dica che sono nato il 23 dicembre 1991, che cadeva proprio di lunedì.

③ Little Venice a Jiyūgaoka.
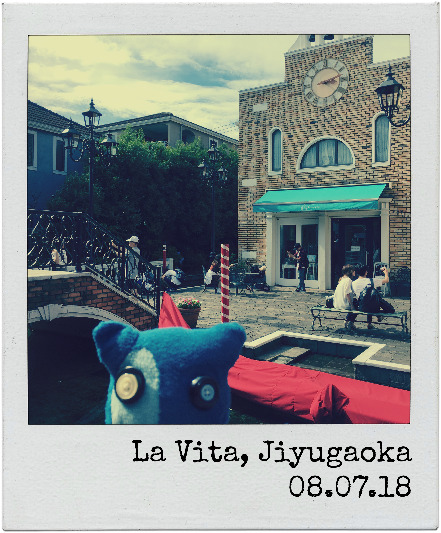
Jiyūgaoka è una zona molto carina nel quartiere di Meguro che viene considerata una sorta di piccola Europa, e nonostante non goda di fama eccessiva ha quel discreto fascino radical chic a portata di poraccio che la rende una valida opzione se si vuole passeggiare per delle stradine eleganti fingendo di potersi permettere quello che vendono i negozi lì intorno. Non troppo lontano dalla stazione, si trova un complesso commerciale denominato “La Vita” che prova a inscenare un paesaggio tipicamente veneziano con tanto di canale e gondola. Diciamo che se il tentativo non è eccessivamente maldestro, si tratta veramente di una piazzetta minuscola dove si trovano solo esercizi commerciali che offrono cose inutili e a me sconosciute tipo trattamenti skin care o yoga per cani (RIPETO, YOGA PER CANI). Insomma, diciamo che sebbene per qualche nanosecondo sia stato proiettato indietro con la memoria ai tempi in cui mi aggiravo per Venezia accaldato alla ricerca della sede dove si sarebbero svolti gli esami della sessione estiva dato il solleone che ha accompagnato la mia visita a Little Venice, l’autosuggestione è durata veramente pochissimo tempo e pochissimi metri quadrati lol
④ Il Kairakuen di Mito.
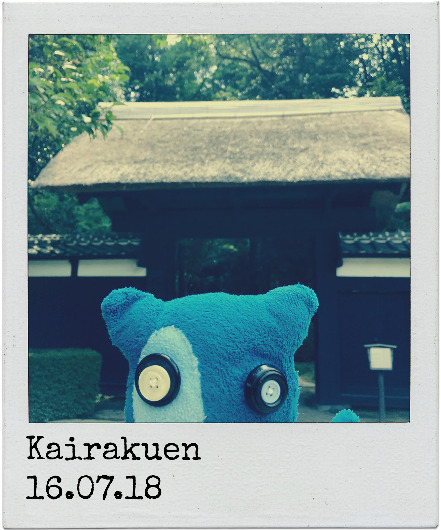
Insieme al Kōrakuen di Okayama e al Kenrokuen di Kanazawa, questo giardino è considerato uno dei tre più famosi del Giappone (日本三名園 Nihon Sanmeien). Fu fortemente voluto dal signore del feudo di Mito, Tokugawa Nariaki, che nel 1842 lo fece costruire non a proprio uso esclusivo come nel caso degli altri due, ma affinché fosse usufruibile anche dal pubblico, come testimoniano i tre caratteri che ne compongono il nome, 偕楽園, che significano rispettivamente “insieme”, “godere” e “giardino”, quindi “un giardino da godere assieme”.
Prima di addentrarmi nella trattazione delle (poche) sorprese che il Kairakuen riserva, menzione speciale per il treno veloce che in un’ora e un quarto collega Mito alla stazione di Tokyo, che ha il sistema di assegnazione posti meno intuitivo dell’universo mondo. Dopo aver comprato il biglietto speciale al binario con un’inaspettata facilità, d’accordo con i due amici giapponesi che mi hanno seguito abbiamo optato per non selezionare i posti ma sederci su quelli liberi che avremmo probabilmente trovato in qualche carrozza (ma chi ci va al Kairakuen il 16 luglio con 35 gradi all’ombra?). Abituati allo Shinkansen, stupidamente ci aspettavamo infatti che ci sarebbe stata una carrozza adibita ai posti non assegnati, E INVECE praticamente in tutti i vagoni sopra ad ogni sedile c’è una lucetta che può essere rossa, gialla o verde a indicare se il posto è libero, prenotato da un viaggiatore che salirà più avanti o occupato. Inutile che vi dica che i posti liberi non sono segnalati dalla lucetta verde come un normodotato potrebbe presumere facendo delle similitudini con i colori del semaforo, ma da quelle rosse, JUST BECAUSE.
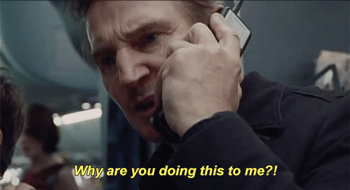
Raggiunto a piedi dalla stazione di Mito dopo uno dei pochissimi pasti cattivi che abbia mai fatto in Giappone (frittura del giorno prima su spaghettoni fatti a mano da un tipo che avvolgeva la sfoglia in un canovaccio e ci camminava sopra salendo sul tavolo, che in effetti è il modo tradizionale di lavorare la pasta per gli udon), il Kairakuen offre il meglio di sé verso i primi di marzo quando i susini fatti piantare da Tokugawa Nariaki, che ne apprezzava non solo la bellezza ma anche l’utilità, sono in fiore. Speravo che andandoci d’estate avremmo comunque potuto apprezzare qualche altra fioritura, ma sono stato prontamente smentito dalla realtà dei fatti.
Notevole comunque la foresta di bambù che occupa parte degli inutili 13 ettari che il Kairakuen misura, e a cui si accede direttamente dall’entrata principale (Omote-mon 表門). Il bambù fatto piantare da Nariaki venne importato da Kyōto ed è di una varietà denominata mōsōdake 孟宗竹, particolarmente robusta e che deve il suo nome a un racconto edificante di origine cinese, contenuto nella raccolta “Ventiquattro Esempi di Pietà Filiale” (二十四孝, Èrshísì Xiào) compilata da Guō Jūjìng nel XII-XIII secolo. Uno degli episodi vede protagonista appunto Mèng Zōng (孟宗, Mōsō in giapponese), il quale, uscito di casa in pieno inverno alla disperata ricerca di germogli di bambù con i quali preparare una zuppa per la madre malata, non trovandone iniziò a piangere e subito dopo ne vide spuntare di nuovi nella foresta dove si era fermato stremato. All’interno della foresta di bambù si trova una fonte naturale chiamata Togyokusen (吐玉泉), che a quanto pare prima del terremoto del 2011 zampillava molto più impetuosamente di come non faccia ora, ma che comunque in seguito al sisma divenne per qualche tempo l’unico luogo da cui attingere acqua potabile nella zona, dal momento che la rete idraulica era stata gravemente danneggiata.

Come spiegatoci dalla guida volontaria che ci ha attaccato la pezza mentre ci abbeveravamo alla suddetta fonte, a Mito è fortemente legata anche una figura (quasi mito-logica, è il caso di dirlo lol) molto amata dai giapponesi: quella di Tokugawa Mitsukuni, daimyō della città vissuto tra il XVII e il XVIII secolo e nipote dello shōgun Tokugawa Ieyasu, resa celebre dai numerosi sceneggiati che negli anni Cinquanta e poi dagli anni Settanta fino al 2011 lo videro protagonista insieme alle sue fidate guardie del corpo, lo spadaccino Suke e il forzuto Kaku.

Scusate, non ce l’ho proprio fatta a resistere.
Erudito mecenate (fu proprio lui a far compilare il Dai Nihonshi, mastodontica opera storica in 226 volumi), meglio conosciuto come Mito Kōmon (水戸黄門, altisonante soprannome autoattribuitosi che significa “la porta dorata di Mito”, anche se sfortunatamente per lui kōmon scritto con due caratteri diversi significa anche ‘ano’, lol), si narra che girovagasse per i suoi possedimenti terrieri per controllarne in incognito l’amministrazione, e imbattendosi in ogni episodio delle serie TV a lui dedicate in signorotti locali arroganti e dispotici che, dopo averlo maltrattato, ne scoprivano con sgomento la vera identità e con la coda tra le gambe rimanevano in attesa della giusta punizione. Iconico il momento del disvelamento delle reali sembianze di Mito Kōmon: Kaku, affiancato da Suke, estrae l’inrō (una specie di portasigilli) con l’emblema della malvarosa, simbolo dello shogunato, e annuncia che il prepotente di turno si trova al cospetto del signore di Mito.

「ここにおわすお方こそ、前の副将軍・水戸光圀公にあらせられるぞ! 頭が高い、控えおろう!」 “Koko ni owasu okata koso, mae no fuku-shōgun Mito Mitsukuni-kō ni araserareru zo! Atama ga takai, hikaeorō!” “Chi vi sta davanti è il signore di Mito Mitsukuni, vice dello Shōgun! La vostra testa è troppo in alto, inchinatevi!”

...E poi ci siamo noi, che sbagliamo pure a disporci lol. Comunque per tutti i nostalgici degli anni Ottanta, la storia di Mito Kōmon sembrerebbe essere faticosamente giunta anche in Italia nel 1981 grazie a un cartone animato (SI DICE ANIME!!1!!111!1!!!!111!) trasmesso da qualche rete locale (così povera che ha addirittura mantenuto la sigla originale in giapponese) con il titolo de “L’invincibile shōgun”, che poi è pure errato perché non era lo shōgun, ma chi sono io per giudicare visto che come già accennato non so neanche come mi devo mettere in posa nella foto qui sopra lol
Unica altra attrazione che potrete visitare all’interno del Kairakuen è il Kōbuntei, edificio a tre piani fatto costruire da Nariaki per ospitarvi artisti e poeti. Pensavo fosse questo il motivo dietro alla scelta del nome (kōbuntei 好文亭 significa infatti ‘padiglione per l’apprezzamento delle lettere’), e invece c’è un collegamento ancora più profondo con il Kairakuen: pare che kōbun sia un nome alternativo del pruno, albero simbolo del giardino, perché un vecchio adagio cinese, probabilmente riferito all’Imperatore Jìn Wǔdì, farebbe corrispondere alla dedizione e alla cura per il sapere la fioritura dei pruni, che in caso contrario, in un regno culturalmente povero, non sboccerebbero.

Vista sul Kairakuen dal Kōbuntei. Sullo sfondo, il lago Senba con in mezzo l’Alcatraz giapponese lol

Alcuni dettagli interessanti all’interno del Kōbuntei: sulla foto di sinistra, decorazione in legno scolpito a foggia di ramoscelli di bambù nella stanza del (non indovinerete mai) bambù, appunto; e nella foto al centro e a destra, un antico esempio di portavivande, un oggetto a cui sono filologicamente affezionato perché in inglese si dice ‘dumbwaiter’ che è tipo la mia parola inglese preferita ever.
Appena fuori dal Kairakuen si trova infine il Tokiwa-jinja, un santuario dedicato giustamente alle due figure di maggior rilievo della zona, Tokugawa Nariaki e Tokugawa Mitsukuni/Mito Kōmon. So che nessuno se lo stava chiedendo, ma se per caso vi capitasse di domandarvi come mai la linea che collega Tokyo a Mito si chiama linea Jōban, ebbene ‘jōban’ è un’altra lettura dei caratteri che compongono il nome di Tokiwa, 常磐, antico toponimo che individuava un’area della provincia di Ibaraki in cui Mito si trova.
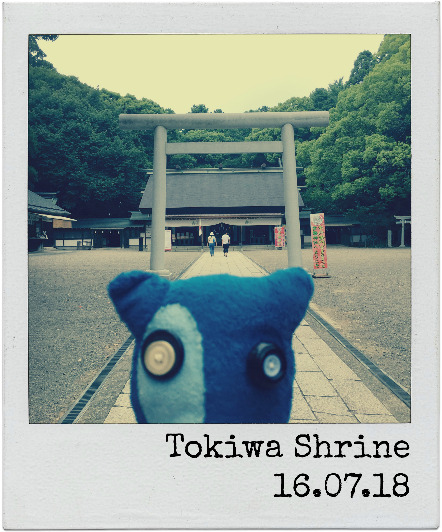
Insomma come avrete capito nonostante sentissi il dovere morale di portare a termine la visita di tutti e tre i giardini più famosi del Giappone, diciamo che il Kairakuen non mi ha particolarmente colpito e non so se lo consiglierei, anche solo per il fatto che tra andata e ritorno da Tokyo un 8000 yen di treno vi partono senza colpo ferire.
D’altra parte, come spesso succede nella vita ci sono cose che solo col senno di poi si può capire se siano valse la pena o meno, e o uno non prova per nulla e resta fuori dai giochi, oppure fa un tentativo e, pur mettendo in conto che potrebbe rimanere deluso, cerca di vedere se può portare a casa qualcosa di buono.

MOVING ON! Sperando che il prossimo post ci riservi qualche gioia in più lol
1 note
·
View note
Text
Cose che rendono la Golden Week davvero golden
Finalmente è arrivato il periodo più atteso dell’anno in Giappone: non Pasqua, non Ferragosto, non Natale, ché qui non se li fila nessuno, bensì la Golden Week, una settimana in cui ricorrono 4 feste nazionali (il genetliaco dell’Imperatore Shōwa, l’anniversario della Costituzione, il giorno del verde e la giornata dei bambini), con l’ovvia conseguenza che per una settimana intera di fila si sta tutti a casa HAHAHAHA certo, vi piacerebbe. No, come al solito combinando i giorni di festa nazionale con i weekend vengono fuori 3 giorni a casa, 2 di lavoro e poi altri 4 di vacanza. Io suggerirei di rivolgerci all’Ingegner Cane per importare cortesemente il concetto di “ponte” in questo Paese perché mi sembra che delle vacanze messe così non abbiano senso, poi non so, sarò io che sono un italiano fannullone evidentemente.

“Il ponte si fa!”
Nonostante l’insensatezza del calendario giapponese, la Golden Week rimane indubbiamente il periodo più gettonato per fare qualche viaggetto nei confini nazionali, e già verso marzo mi stava montando un’ansia da esame di maturità perché ancora non avevo deciso come impiegarla e dove andare, e già vedevo le mie ricerche su Airbnb darmi 0 risultati in qualsiasi città del Giappone. Alla fine, però, la scelta è caduta giusto in tempo su Kanazawa, la città principale della prefettura di Ishikawa, nella regione dello Hokuriku che si affaccia sul Mar del Giappone.
Devo dire che questo viaggio non sembrava essere partito sotto i migliori auspici: una settimana prima della partenza Airbnb mi aveva infatti comunicato che la mia prenotazione era stata cancellata perché probabilmente avevano beccato il mio host ad affittare camere senza permesso, e sono dovuto ripiegare su una sistemazione molto meno fancy (oddio, non malvagia eh, però la cinese che l’affittava credo avesse dimenticato la parrucca nella vasca da bagno a giudicare dal numero di capelli che ci ho trovato) perché era l’unica rimasta che non costasse uno sproposito (c’era un leggero divario di prezzo che Airbnb ha coperto come risarcimento per l’inconveniente, che carini, non me l’aspettavo). Il weekend prima di partire, poi, il mio nobile ed eroico tentativo di calarmi nel mood giusto leggendo per l’appunto “Sangue nobile, sangue eroico” (義血侠血 Giketsu Kyōketsu) di Izumi Kyōka, scrittore originario di Kanazawa dove questo romanzo è peraltro ambientato, non solo ha dovuto scontrarsi con l’impossibilità di reperire una copia cartacea in libreria o nei negozi dell’usato, ma è definitivamente fallito una volta che mi sono trovato davanti al testo online in un giapponese di fine 1800 che non avevo la minima idea di che cosa cercasse di comunicarmi, motivo per cui ho prontamente provveduto a mollare il colpo dopo la terza riga onde evitare di imbarcarmi in una lettura leggera quanto un saggio di Judith Butler. Scusami Izumi Kyōka, ti leggerò in traduzione oppure se dovessi finire in carcere, quando avrò veramente molto, molto, molto tempo libero.
I caratteri che compongono il nome di Kanazawa 金沢 significano letteralmente ‘palude dorata’, e a buon diritto: la città, capitale dell’antica provincia di Kaga capeggiata sin dal XVI secolo dal clan Maeda, era un ricco centro di produzione di riso ed è notoriamente legata alla lavorazione della foglia d’oro, che vi ritroverete dappertutto, nel caffé, sul gelato, nel liquore, sui piatti di pesce, sui dolci, a manciate proprio. Potete capire dunque quanto azzeccata potesse essere con tutto quest’oro come meta per la Golden Week lol

Dopo aver ingerito questi quantitativi di foglia d’oro posso andare in bagno di notte anche senza accendere la luce (adesso capisco il ‘kaga’ nel verbo ‘kagayaku’ che significa ‘splendere’ lol)
Raggiunta dopo otto faticosissime ore in un bus notturno che prometteva sufficiente spazio per le gambe e invece palesemente MENTIVA, la prima cosa che mi colpisce di Kanazawa appena sceso dal bus è quanto sia kirei 綺麗, una di quelle parole che molto comodamente possono significare cose diverse a seconda del contesto, in questo caso ‘bella’ ma anche ‘pulita’, perché si vede che se in greco antico kalòs kagathòs (καλός κἀγαθός, che con la provincia di Kaga avrebbe pure senso lol) suggeriva che il bello fosse anche buono, in giapponese pulizia e bellezza vanno di pari passo. Ad ogni modo tempo neppure dieci minuti e già oltraggio involontariamente la suddetta bellezza/pulizia dimenticandomi il sacchetto contenente tutta la spazzatura accumulata durante il viaggio in bus in un bar della stazione, contribuendo a fomentare l’odio verso gli stranieri che, piccola parentesi, non so per quale motivo a Kanazawa sono TUTTI ITALIANI (no, seriamente, questa cosa mi ha sconvolto perché non si tratta di Kyōto o Tokyo o una di quelle mete gettonatissime nel turismo internazionale, quindi cosa ci fanno tutti questi italiani qui? Come sono venuti a sapere dell’esistenza di Kanazawa?). E a proposito della stazione di Kanazawa, so che suonerà strano ma l’ho trovata semplicemente bellissima, con la sua cupola di vetro e acciaio (il Motenashi Dome) e il torii in legno ispirato a un tradizionale tamburo a clessidra (lo Tsuzumi-mon), relativamente recenti visto che sono del 2005, così come recente è il collegamento ferroviario fornito dallo Shinkansen che ha cominciato a servire Kanazawa solo nel 2015.
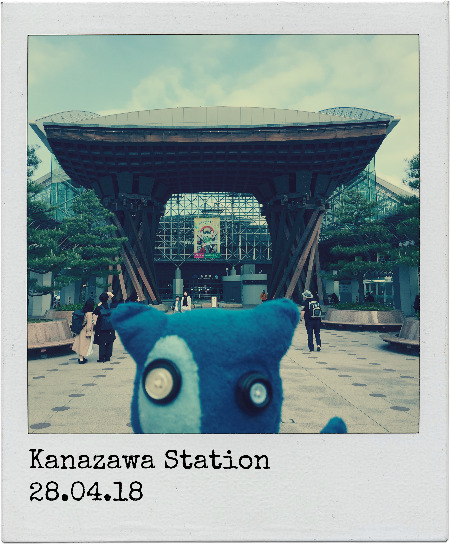
L’attrazione forse più peculiare di Kanazawa è il Kenrokuen, un giardino di periodo Edo (1603-1868) che fa parte dei tre più famosi del Giappone (日本三名園 Nihon Sanmei’en) insieme al Kōrakuen di Okayama e al Kairakuen di Mito, l’ultimo che mi manca da visitare. Il nome Kenrokuen significa ‘sestuplice giardino’ e fa riferimento alla combinazione dei sei attributi essenziali (spaziosità, intimità, artificio, antichità, corsi d’acqua e panorami) che dovrebbero comporre un giardino perfetto secondo il testo sui più famosi giardini di Luòyáng scritto dal poeta cinese Li Gefei.
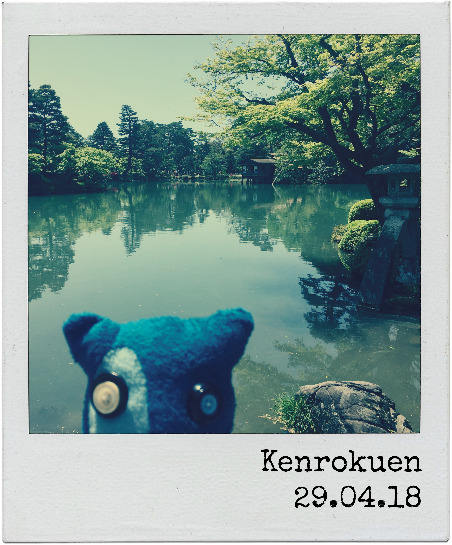
「ここがの、金沢の兼六園といって、百万石のお庭だよ。」【泉鏡花 • 義血侠血】 “Questo è il Kenrokuen di Kanazawa, il giardino (sulla strada) di Hyakumangoku.” [Izumi Kyōka, ‘Sangue nobile, sangue eroico’]
Situato su un pendio e originariamente giardino esterno del castello di Kanazawa che lo fronteggiava, fu distrutto da un incendio nel 1759 e ricostruito da Maeda Harunaga, che vi aggiunse la cascata Midori-taki e la casa da tè Yugao-tei nel 1774.

Altri pezzi forti del Kenrokuen sono: la fontana più antica del Giappone, le cui acque sgorgano dallo stagno Kasumigaike; l’inspiegabile torre della radio, installata nel 1933 dalla NHK, nel caso voleste far partire Spotify mentre vi promenate per il giardino; il ponte Gankobashi, le cui rocce sono disposte in modo da ricordare uno stormo di oche selvatiche in volo; le sette pietre che rappresentano gli Shichifukujin, i sette dei della fortuna; la statua di Yamato Takeru, leggandario principe che sarebbe vissuto tra il IV e il V secolo e avrebbe sottomesso svariate province del Giappone al regno del padre, l’Imperatore di Yamato.

All’interno del Kenrokuen si trova anche il Seisonkaku, una villa costruita nel 1863 da Maeda Nariyasu come residenza per la madre. Inizialmente denominata Tatsumi-shin-den, venne poi ribattezzata col nome attuale quando il Kenrokuen fu aperto al pubblico nel 1874.
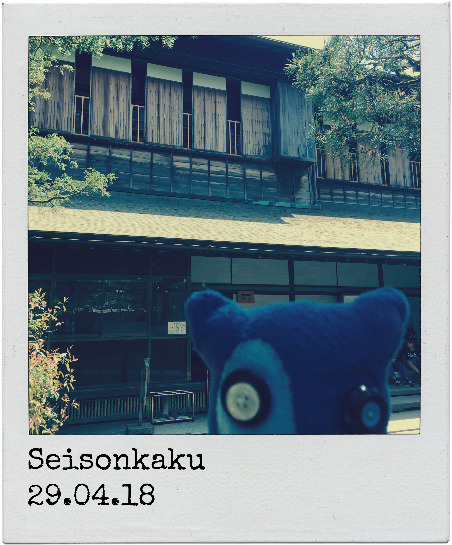
L’edificio è strutturato su due piani, il primo dei quali è nel solenne stile buke-shoin (武家書院) e comprende l’Ekken-no-ma (stanza per ricevere gli ospiti) e svariate altre stanze con nomi di piante e animali illustrati nella parte bassa delle pareti di legno, mentre il secondo è in uno stile molto più libero detto sukiya-shoin (数奇屋書院), sorprendentemente moderno con le sue pareti dipinte di colori quasi elettrici come il blu ultramarino, il rosso e il viola. Tutte le stanze sono disseminate di mobili antichi e oggetti tra cui non potrò purtroppo mai dimenticare le karako 唐子, inquietantissime bambole dalle fattezze cinesi che non ho potuto fotografare ma che erano ESATTAMENTE come quella che si vede in Paprika:
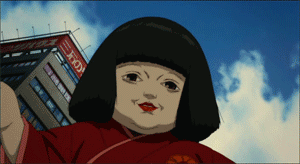
Per quanto riguarda il già citato castello di Kanazawa, diciamo che c’è e non c’è, nel senso che il mastio principale è andato in fiamme nel 1602 e non è stato mai più ricostruito, mentre invece rimangono diversi altri edifici tra cui le due torrette Tsuzuki-yagura e Hishi-yagura (la Torretta del Diamante, così chiamata perché i pilastri al suo interno sono su base romboidale) e il lungo magazzino che le collega, detto Gojukken Nagaya.
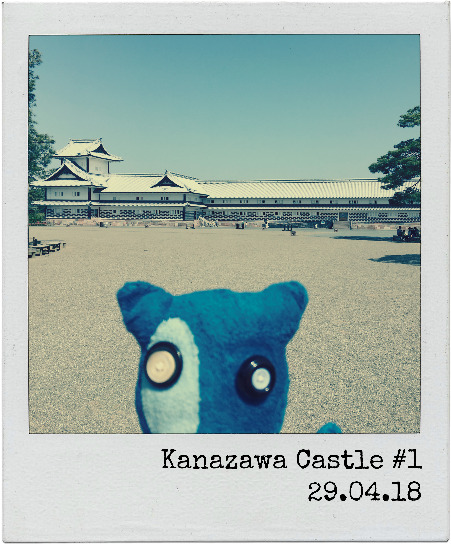
Caratteristica interessante del castello di Kanazawa, bruciato più volte nei secoli (e “bruciato” pure nel senso che bianco come si presenta sembra che l’abbiano candeggiato lol), è il complicato intreccio di strutture in legno che si incastrano e autosupportano permettendo di evitare qualsiasi uso di viti, secondo una tecnica tradizionale giapponese che rivediamo per esempio anche nel giocattolo-rompicapo chiamato “chidori” e che è stata ripresa dallo stesso famoso architetto Kuma Kengo per i suoi lavori più recenti.

Non molto distante, si trova anche il Museo d’Arte Contemporanea del XXI secolo, un moderno edificio dalle pareti di vetro inaugurato nel 2004 che ospita sia aree ad accesso libero che zone espositive per le quali avrei anche pagato il biglietto se non ci fossero state infinite ore di coda tutte le volte che ci sono passato davanti.
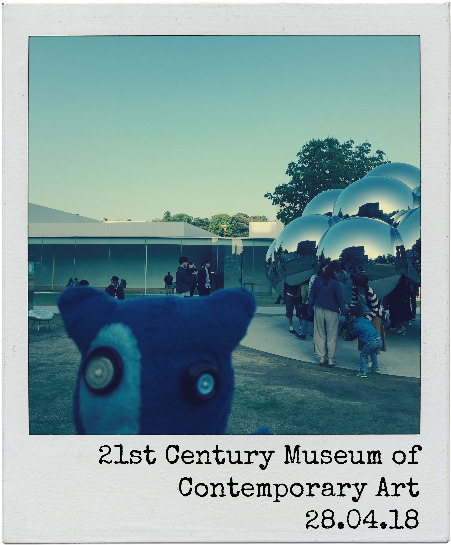
Anche senza visitarne le esposizioni, vale comunque la pena fare una capatina per rimanere meravigliati dalle piccole chicche del museo, come le colonne che lo sostengono, agghindate come se fossero gambe umane (dandovi la rara opportunità di poter affermare di aver allacciato le scarpe a un pilastro) e le divertenti installazioni interattive che giocano con le illusioni ottiche sia all’interno che tutt’intorno all’edificio. Proprio questi elementi tra l’altro mi hanno riportato con la mente a Naoshima, con la sua Benesse House e il suo parco giochi, per alcuni versi molto simili.
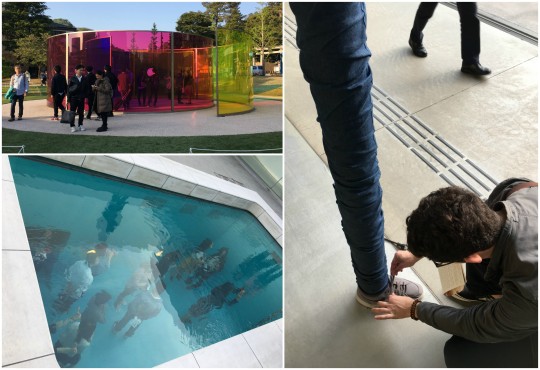
Per comprendere come mai Kanazawa venga anche chiamata “la piccola Kyōto della provincia di Kaga”, non si può assolutamente saltare la visita al quartiere di Nagamachi.
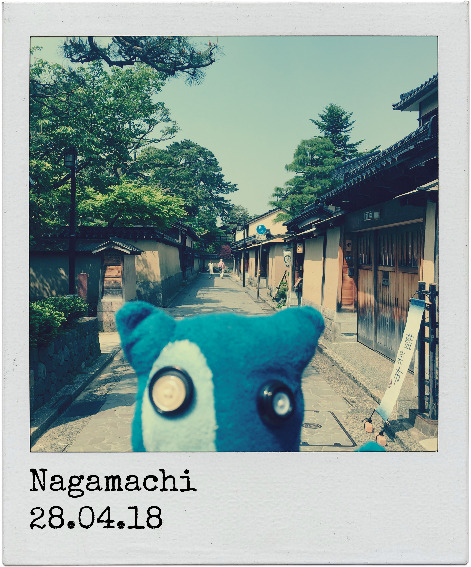
Esattamente come Kyōto, anche Kanazawa è stata pressoché interamente risparmiata dalla Seconda Guerra Mondiale, e questo ha permesso a molti siti storici e culturali di rimanere quasi intatti: tra questi, Nagamachi conserva l’atmosfera di un antico quartiere abitato da samurai e permette di fare una passeggiata tra le sue stradine delimitate da caratteristiche mura di cinta di fango, che con i suoi suggestivi scorci mi ha ricordato tantissimo il quartiere di Gion a Kyōto.

Una simile atmosfera si riscontra anche a Higashi Chaya-gai, il quartiere orientale delle case da tè, dove si trovano diverse abitazioni in legno tradizionalmente occupate dalle geisha, e che ora brulicano di negozietti e caffè.
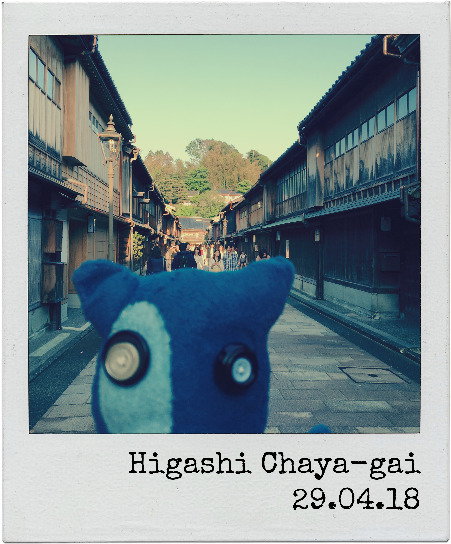
So che non ve lo stavate chiedendo lol, ma per dovere di cronaca è giusto che sappiate che così come esiste il quartiere orientale delle case da tè esiste pure quello occidentale: due fiumi più a sud-ovest, oltrepassati l’Asanogawa e il Saigawa (letteralmente “il fiume dei rinoceronti”, a cui darò zero stelline su TripAdvisor perché a dispetto del nome io di rinoceronti non ne ho visti), proprio attaccata all’Airbnb si trova infatti Nishi Chaya-gai, una stradina decisamente meno rinomata e popolata ma comunque suggestiva.
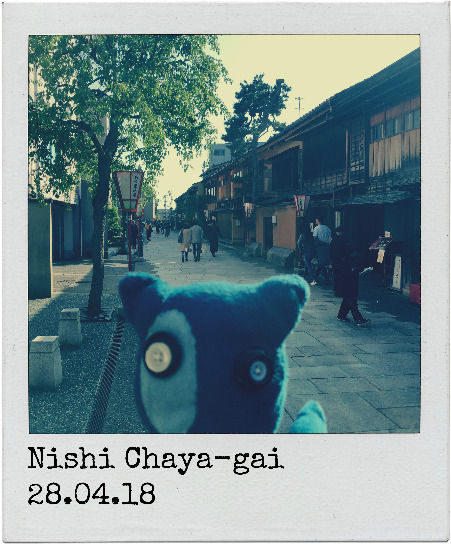
Nella stessa area sorge poi il quartiere di Teramachi, “la città dei templi”, così chiamata perché vi si trovano templi a grappoli, più numerosi delle liste alle elezioni politiche di quest’anno e più frequenti delle consultazioni indette da Mattarella per trovare il nuovo accordo di governo. Credo che a nessuno di noi dispiacerà se ne nomino solo due per tutti: il Gannenji e il Myōryūji, meglio noto come Ninja-dera (tempio dei ninja).
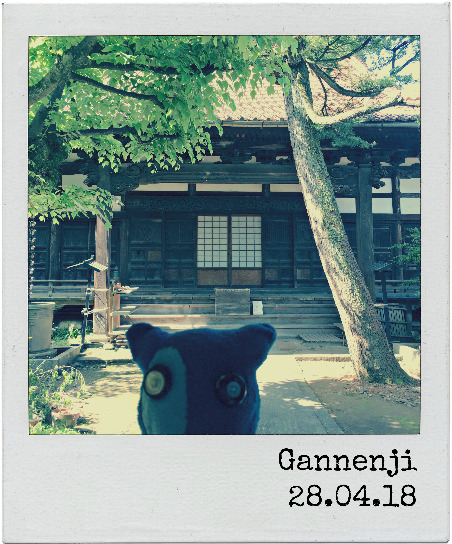
Adiacente al più famoso Ninja-dera, il Gannenji è legato al celebre poeta Matsuo Bashō che lo visitò durante il viaggio narrato nella raccolta “Oku no Hosomichi” (奥の細道, “Lo stretto sentiero del nord”). Venuto a conoscenza della morte dell’amico poeta Kobayashi Isshō, qui sepolto a fianco di una stele con il suo ultimo haiku (心から 雪美しや 西の雲 kokoro kara / yuki utsukushi ya / nishi no kumo, “Dal profondo del cuore, com’è bella la neve! Nuvole ad ovest”), a sua volta Bashō compose un haiku per compiangerne la morte (塚も動け 我が泣く声は 秋の風 tsuka mo ugoke! / waga naku koe wa / aki no kaze, “Smuoviti, o tumulo! Il mio pianto è il vento d’autunno”).
Il Myōryūji, invece, è un tempio (e non un santuario con mio enorme rammarico, perché in tal caso si sarebbe chiamato Ninja-jinja e sarebbe stato il massimo imho) concepito come nascondiglio in caso di attacco nemico e presenta scale dissimulate, camere segrete, vie di fuga, tunnel nascosti e finte porte che io non ho visto perché si accede solo prenotando una visita guidata e tutte le volte che ci sono passato davanti i tour erano già al completo. Ma vabbè, ce ne siamo fatti una ragione.
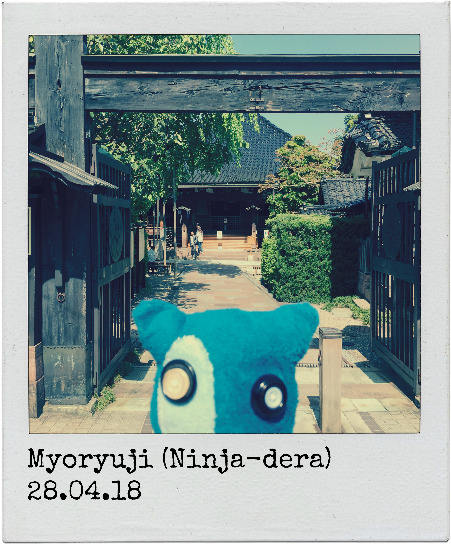
Ultime due menzioni d’onore vanno indubbiamente all’Oyama-jinja e al mercato Ōmichō.
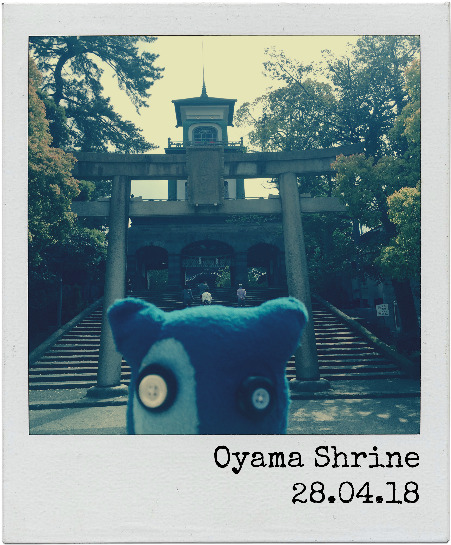
L’Oyama-jinja è dedicato al capostipite del clan Maeda, Toshiie, commemorato da una statua equestre poco lusinghiera visto che lo fa sembrare una chiocciola o in alternativa il gobbo di Notre-Dame, e si distingue per l’inusuale portale progettato da un architetto olandese che vi ha mescolato elementi cinesi, giapponesi ed europei (come le finestre in vetro colorato), probabilmente dopo aver mescolato diverse sostanze stupefacenti. Il vasto giardino presenta un laghetto che si può attraversare grazie a zigzaganti tavole di legno (八つ橋 yatsuhashi) e un negozio di souvenir che con la sua struttura in vetro e legno a momenti pare il Museo d’Arte Contemporanea del XXI Secolo e a primo acchitto risulta un filino troppo moderno per il luogo in cui si trova, ma tanto di strano c’è già il portale, quindi vale tutto immagino lol

Per quanto riguarda il mercato Ōmichō, invece, lo si può facilmente paragonare a quello di Tsukiji a Tokyo o a quello di Nishiki a Kyōto. Pieno di ristorantini che servono piatti di pesce freschissimo, ha gentilmente provveduto a fornire due dei tre pranzi consumati a Kanazawa, ma se non fosse stato troppo lontano ci avrei mangiato tranquillamente pure il terzo lol


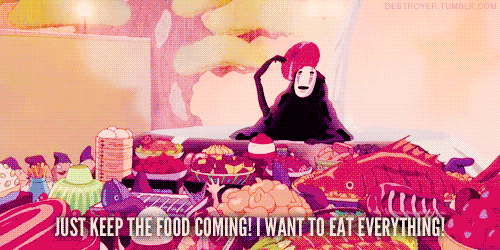
Quindi insomma, Kanazawa per me è decisamente un sì, dalle zone più tradizionali che mi ricordavano molto la mia amata Kyōto a quelle più mondane (Katamachi per esempio, paragonabile alla zona di Shijō-Kawaramachi a Kyōto, o Tatemachi, la strada dello shopping che vi permette di esperire Ginza e Harajuku senza andare a Tokyo lol). Tra l’altro, guardando per sfizio quanto costano gli affitti e scoprendo che sono praticamente la metà di quelli di Tokyo, devo ammettere che la tentazione un po’ mi è venuta - e d’altro canto, con tutti i turisti italiani che abbiamo beccato vuoi che non assumano una guida che parli italiano..?

0 notes
Text
Cose che ho collezionato qua e là in Giappone
Ero al primo anno di liceo quando una compagna di classe mi ha fatto scoprire i Pizzicato Five, gruppo iconico dello Shibuya-kei e del revival anni sessanta nel pop anni novanta. L’album che precede il loro scioglimento è datato 2001 e si intitola “Ça et là du Japon”, decisamente non uno dei migliori, anzi, a tratti quasi troppo fastidioso persino per essere messo di sottofondo mentre si lavano i piatti, ma interessante perché si configura come un’ironica miscellanea di brani che citano vecchi successi o addirittura pezzi tradizionali giapponesi, o che ancora giocano sagacemente con gli stereotipi orientalisti e auto-orientalisti sul Giappone visto dai Paesi d’oltreoceano e viceversa. Ho deciso di citare quest’album perché è con lo stesso spirito che scrivo questo post dopo TANTISSIMO. In questi mesi il mio tempo libero è stato assorbito principalmente da un progetto di cui qualcuno sa già ma che prima di fare appelli alla nazione vorrei avere la certezza di vedere concretizzato (non vi preoccupate, se e quando lo sarà non mi esimerò dallo sbandierarlo a destra e a manca fino a venire eliminato da tutti i miei contatti per spam lol), quindi non sono materialmente riuscito ad aggiornare il blog, ma siccome mi è comunque capitato di andare qua e là, ho pensato che fosse arrivato il momento di raccogliere tutto in una sorta di zibaldone di esperienze anche non proprio freschissime che probabilmente risulterà poco brillante (meno del solito? challenge accepted lol) ma che non solo a rileggerlo un giorno ma addirittura soltanto a scriverlo mi farà pensare con nostalgia ad alcune cose.
💿 La Chinatown di Yokohama.
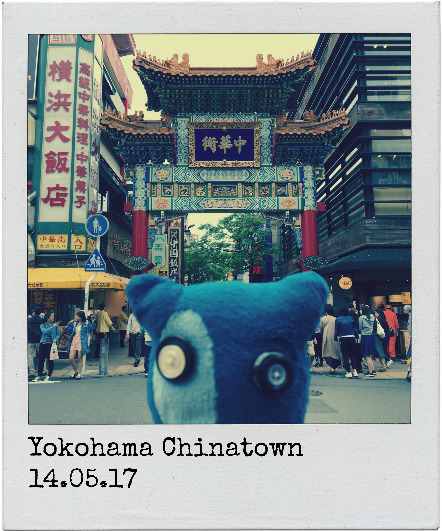
「ヨコハマもいいね!」► スキヤキ・ソング
Mentre quella di Kōbe, sorta nel 1868, si chiama Nankinmachi (南京町, ‘la città di Nanchino’, nomenclatura che io pensavo si applicasse a tutte le Chinatown e che usavo indistintamente, fino a che non sono stato corretto con tanto di commento “si vede che sei stato in Kansai” lol), quella di Yokohama, di quasi una decina d’anni più antica, si chiama Chūkagai (中華街, ‘città cinese’), e mentre la prima è poco più di una stradina, la seconda è tipo un mega quartiere dove vendono di tutto, e dove ho lasciato del tè al lichi in foglie che tuttora mi pento di non aver comprato e che è il motivo principale per il quale ci tornerò lol.
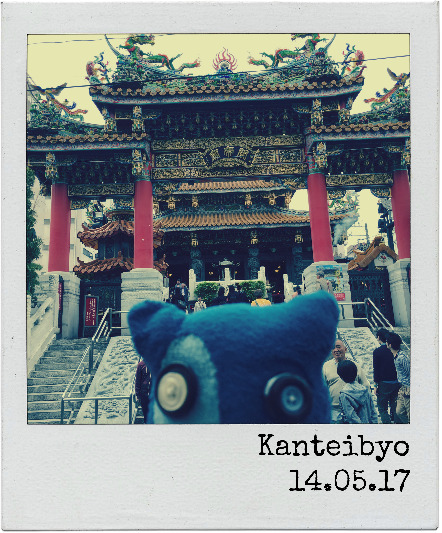
Degno di nota il Kanteibyō, vistoso tempio dedicato a Guāndì, generale cinese le cui gesta sono cantate nelle Cronache dei Tre Regni (in cui tra l’altro si narra che, giustiziato dopo essere caduto in trappola, sarebbe riuscito a eliminare il proprio nemico giurato Lǚ Méng addirittura da morto) e successivamente divinizzato come dio della guerra e delle arti marziali.

“Se non posso uccidere Lǚ Méng da vivo, lo farò da morto!” Onestamente, non mi ricordo questa scena, di Red Cliff mi ricordo solo Takeshi Kaneshiro ehm cioè, Zhūgě Liàng lol
💿 Ho finalmente scoperto che pianta è il rampicante che ricopre casa mia, una delle cose che tra l’altro mi hanno affascinato di questo appartamento quando l’ho scelto. All’inizio credevo fosse edera, ma le foglie erano abbastanza diverse, e mi è stato suggerito che poteva essere forse vite, fintanto che quest’autunno non ha fatto i frutti e no, non era uva, ma degli strani pomodori spugnosi e oblunghi che ho scoperto chiamarsi karasu-uri in giapponese (烏瓜, “la cucurbitacea dei corvi”), nome scientifico Trichosanthes cucumeroides, quindi della famiglia delle zucche, dei meloni e delle zucchine, che in teoria dovrebbe essere anche commestibile seppur non particolarmente prelibata.

Ho inoltre scoperto che c’è una canzone popolare dedicata a questo frutto, ambientata nientepopodimenoche ad Asagaya, a una fermata di treno da dove abito io. Coincidenze??? Non credo proprio.
💿 La galleria d’arte Dorado Gallery a Waseda.
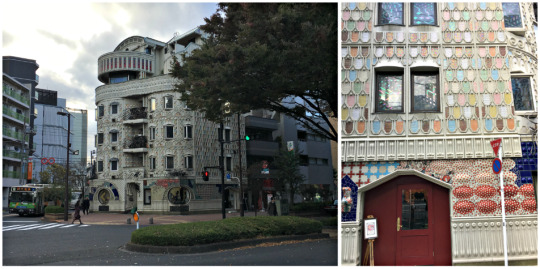
Ora, non vorrei dire, ma... non vi ricorda in maniera inquietante Casa Batlló di Gaudí a Barcellona? Uscito dalla stazione della metropolitana di Waseda stavo camminando verso la fermata del tram (il tram per davvero eh, non quello che io a Vicenza chiamo tram ma che in realtà è un autobus), che non sapevo neanche esistesse ancora a Tokyo e che al solo salirci mi ha ricatapultato in un passato che non ho mai vissuto, quando mi si para davanti questo inspiegabile edificio che, boh, non lo so, solo a me sembra meravigliosamente fuori posto e fuori contesto? Ma cosa ci fa qui? Ma cosa mi rappresenta?
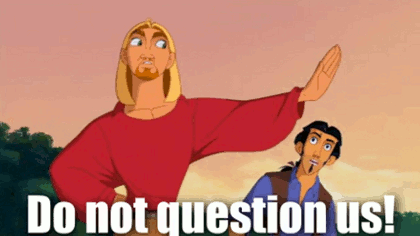
💿 Salendo sul tram al capolinea di Waseda si arriva in poche fermate a Kishibojinmae, nella zona di Zōshigaya, dove sorge un tempio dedicato a una divinità molto particolare.
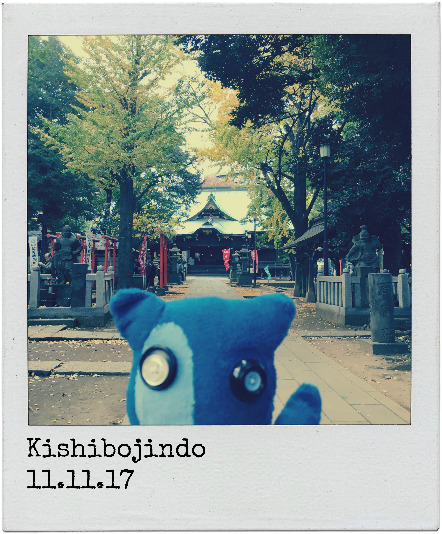
Kishibojin (o Kishimojin, 鬼子母神, i cui quattro caratteri significano rispettivamente ‘demone’, ‘figlio’, ‘madre’ e ‘divinità’) è il nome con cui in Giappone è nota Hārītī, divinità buddhista che nasce come demone femminile che rapiva i neonati per darli in pasto alla propria numerosissima prole, sino a quando Buddha non le sottrasse un piccolo per dimostrarle quanto dolore aveva inflitto alle madri a cui aveva sequestrato i figli. Pentitasi, Kishibojin si convertì e divenne la divinità protettrice dei bambini e delle madri a cui garantiva un parto indolore. Invece della carne dei neonati, cominciò a nutrirsi di melagrane, che con i loro semini simboleggiano innumerevoli figli, e che per questa ragione si dice portino fertilità alle donne e liberino dagli spiriti maligni i bambini che le mangiano. Non è quindi un caso che nel giardino del tempio di Zōshigaya siano piantati diversi melograni, alberi che non mi capita spessissimo di vedere a Tokyo e il cui frutto ho dovuto cercare in tre supermercati e due fruttivendoli diversi quella volta che mi è servito lol.
A parte il fatto che trovo assolutamente affascinante il parallelismo che si potrebbe fare con la mitologia greca, a partire dalla figura di Lamia (chi ti infamia) che, con un percorso opposto, vistasi uccidere i figli da Era che voleva punirla per essere stata l’amante di Zeus, si trasforma in una cannibale a caccia di bambini (al contrario della nostra fruttariana ante litteram lol), senza parlare poi della melagrana che nel mondo classico è il frutto infernale per eccellenza che Persefone mangia nell’Ade, un’altra cosa che mi ha intrigato è stato scoprire che il primo carattere di Kishibojin, quello di ‘demone’ 鬼 nel suo nome viene scritto senza il tratto in cima perché si tratterebbe della rappresentazione delle corna che ha perso dopo essersi convertita in una divinità.
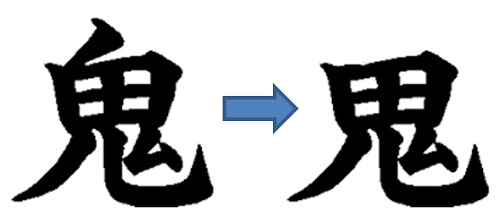
Ecco, così. Tra l’altro mi è tornato in mente che la variante senza corna l’avevamo già vista in tempi non sospetti quando siamo andati a vedere il kiraigō 鬼来迎 nel cartello che li indicava a Mushō.
💿 La tomba di Natsume Sōseki nel cimitero di Zōshigaya.

「吾輩は猫である。」 “Io sono un gatto.”
Il cimitero di Zōshigaya ospita le tombe di diverse celebrità letterarie tra cui Nagai Kafū, Izumi Kyōka e appunto Natsume Sōseki, compianto autore di svariati romanzi tra cui “Kokoro” (“Il cuore delle cose”, edizioni Neri Pozza che mi sento in dovere di citare per orgoglio vicentino lol), in cui tra l’altro la tomba dell’amico del protagonista si trova proprio nel cimitero di Zōshigaya, in cui ora lo scrittore stesso riposa:
“[La moglie del maestro] Disse molto gentilmente che il marito era fuori. Aggiunse che ogni mese, proprio quel giorno, aveva l’abitudine di andare a portare i fiori a una tomba nel cimitero di Zōshigaya. «È uscito proprio adesso. Saranno dieci minuti!» disse la signora con aria dispiaciuta. Io salutai e me ne andai. Dopo un centinaio di metri in direzione della tumultuosa città, mi venne voglia di fare una passeggiata a Zōshigaya. Mi spinse anche la curiosità di vedere se avrei incontrato il maestro. E tornai sui miei passi.
Entrai dalla parte sinistra di un orto, passai quindi nel cimitero e camminai lungo un ampio viale ornato con alberi di acero. Proprio allora, da una casa da tè che si scorgeva sul fondo, uscì a un tratto una persona che assomigliava al maestro. Mi avvicinai fino al punto da vederne la montatura degli occhiali brillare al sole, e gridai di soprassalto: «Maestro!» Egli si fermò di colpo, e mi guardò. [...] Attraversammo il cimitero per raggiungere la strada. Accanto alla tomba di una certa Isabel e di un certo Rogin, credente cristiano, si ergeva un cippo su cui era scritto: «Tutti gli esseri viventi portano in sé l’essenza di Buddha». C’era anche la tomba di un ministro plenipotenziario. E ce n’era un’altra, molto piccola, su cui erano incisi gli ideogrammi Andorei: chiesi al maestro come si dovessero leggere. «Probabilmente Andrea», rispose con un sorriso amaro. […] Ad una estremità del cimitero, dove una grande pianta di ginkgo si ergeva quasi a nascondere il cielo, lui guardò in alto, verso la cima, ed esclamò: «Tra poco sarà bella! Diventa completamente gialla e la terra, sotto, si copre di foglie dorate!» Una volta al mese passava inevitabilmente in quel luogo. [...] Io non avevo una meta precisa, per cui seguii il maestro. Era più silenzioso del solito, eppure non mi sentivo troppo a disagio, e camminai lentamente con lui. «Ritorna subito a casa?» «Sì. Non devo andare da nessun’altra parte.» Scendemmo la collina in silenzio, verso sud. «Lassù c’è la tomba della sua famiglia?» chiesi di nuovo. «No». «È sepolto lì qualche suo parente?» «No». Non aggiunse altro. Anch’io, a quel punto, troncai il discorso. Poi, dopo un po’, ritornò inaspettatamente sull'argomento. «C’è la tomba di un mio amico». «Tutti i mesi va a fargli visita?» «Sì». Quel giorno non disse altro.”
💿 Il quartiere di Sugamo, conosciuto come la Harajuku dei vecchi lol. Era dai tempi del mio stage alla Camera di Commercio Italiana, quando un mio collega (ciao Ale!) me ne aveva parlato definendolo esattamente come sopra, che pensavo di andarci per vedere se fosse effettivamente così, ma con i miei fenomenali tempi di reazione dal dire al fare sono passati tipo due anni 🙈 Se la strada principale di Harajuku è Takeshita-dōri, Sugamo (so che è stupidissimo, ma tutte le volte questo nome mi fa tornare in mente lo spot della De Longhi col gondoliere che urla “chi ga sugà el canal??”) si sviluppa lungo una via che si chiama Jizō-dōri. I negozi che si trovano lungo questa strada si rivolgono palesemente a un pubblico di terza età, fetta di mercato di cui d’altra parte non si sottovaluta alcun tipo di esigenza dato che vi sono anche diverse bancarelle che espongono con spregiudicatezza della provocante biancheria rossa, e non in occasione del Capodanno.
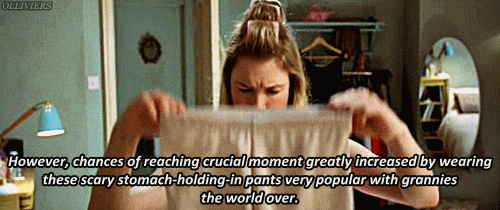
A Sugamo si trova anche uno dei sei Jizō di Edo, sei statue assise di Jizō (bodhisattva dei viaggiatori e dei bambini, in particolare di quelli mai nati) che vennero commissionate nei primi anni del 1700 e posti in diversi templi della città. Oggi ne restano cinque, uno dei quali è appunto custodito nel tempio Shinshōji a Sugamo.

💿 Il Kiyosumi-teien, giardino designato “sito di bellezza paesaggistica” dalla città di Tokyo nel 1979.
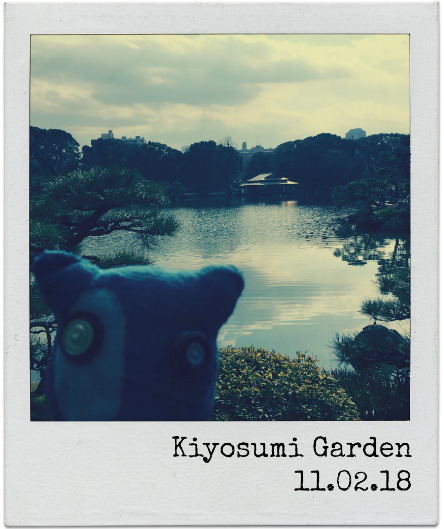
Nel periodo Edo, in questa zona sorgeva la residenza di un ricco mercante, Kinokuniya Bunzaemon. Tra il 1716 e il 1735, divenne la seconda casa di Kuze Yamatonokami, un signore feudale dell’odierna prefettura di Chiba. Nel 1878, questo terreno fu acquistato da Iwasaki Yatarō, fondatore della Mitsubishi, che ne fece un giardino che fungesse da luogo ricreativo per i suoi impiegati e per accogliere gli ospiti - proprio per quest’ultimo scopo venne edificato il padiglione Ryotei, una sorta di palafitta che riprende lo stile delle case da tè. Dopo il Grande Terremoto del Kantō nel 1923 e durante i bombardamenti aerei del 1945, servì come rifugio per gli sfollati, e fu donato alla città e aperto al pubblico nel 1932. Il giardino è nello stile kaiyū 回遊, cioè a circuito, e il laghetto al centro originariamente era alimentato dal fiume Sumida, che era stato appositamente deviato, mentre attualmente viene abbeverato solo dall’acqua piovana. Le pietre disposte al suo interno, tra cui quelle che formano delle passerelle note come iso-watari (磯渡り, “attraversamento di sassi”) provengono da tutto il Giappone, ed è presente anche una stele di pietra dedicata al poeta Matsuo Bashō su cui è riportato il suo famoso haiku “Vecchio stagno / una rana ci salta dentro / rumore d’acqua”.
E a proposito di Bashō, poco distante dal Kiyosumi-teien si trova una statua del poeta seduto davanti a ciò che resta del Saito-an (採荼庵), residenza del suo discepolo Sugiyama Sanpū e punto di partenza del suo viaggio iniziato il 27 marzo 1689 e riportato nella raccolta poetica “Oku no Hosomichi” (奥の細道, “Lo stretto sentiero del nord”). Immediatamente nelle vicinanze si estende un lungofiume puntellato di targhette in legno su cui sono incisi alcuni haiku del maestro.

Cercando di fare ‘la mossa’ in un fallimentare tentativo di approccio. Matsuo-sensei, straziami ma di Bashi saziami.
💿 Kawagoe, la “piccola Edo”. Situato ad appena mezz’oretta di treno da Tokyo, nella prefettura di Saitama, questo ridente borgo con le sue case simili a magazzini (蔵造り kurazukuri) dovrebbe mantenere almeno nell’architettura l’atmosfera del periodo Edo (1603-1867), quando ricopriva un importante ruolo politico e militare per la protezione che offriva alla città di Tokyo (al tempo Edo, appunto) da nord. Oggi l’unico ruolo che ricopre è quello di produttore di una birra alla patata dolce, praticamente la sola risorsa di Saitama lol, l’omonima birra Coedo. A dominare lo skyline di Kawagoe è la torre dell’orologio (時の鐘 Toki no Kane, ‘la campana del tempo’), il cui suono, udibile quattro volte al giorno (le 6 del mattino, mezzogiorno, le 3 del pomeriggio e le 6 della sera) è stato selezionato come uno dei 100 più rappresentativi del Giappone.
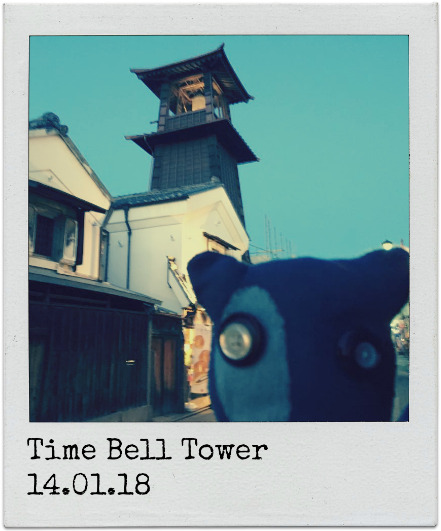
A riprova del ruolo strategico di Kawagoe, anticamente era presente anche un castello dove risiedevano gli emissari dello shōgun mandati da Edo, ma fu smantellato nel 1870. Ne resta solo una porzione nota come Honmaru Goten, che giustamente era chiusa alle visite quando ci sono andato.
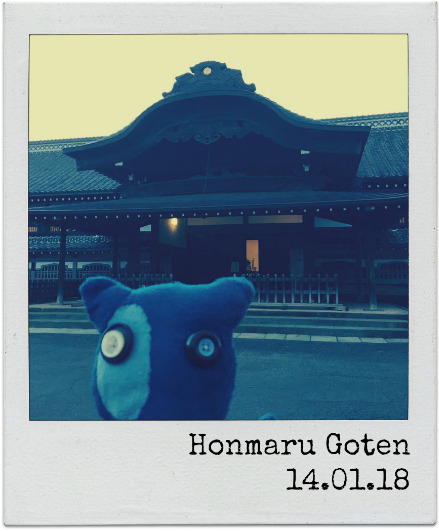
Altro punto d’interesse della zona è il Kita-in, un tempio buddhista della setta Tendai fondato nell’830 da Ennin (quello dello Yamadera e dello Zuiganji, ma di preciso quanti templi ha fondato questo?). Inizialmente faceva parte di un complesso di tre templi (Kita-in, Naka-in e Minami-in, rispettivamente il tempio del nord, del centro e del sud), ma nel 1599 assunse il ruolo di centro principale e i caratteri del suo nome vennero modificati da 北院, ‘tempio del nord’, che aveva una connotazione sinistra, a 喜多院, ‘tempio delle molte gioie’. Tappa obbligatoria, dunque, per tutti coloro che fanno parte del team #maiunagioia.
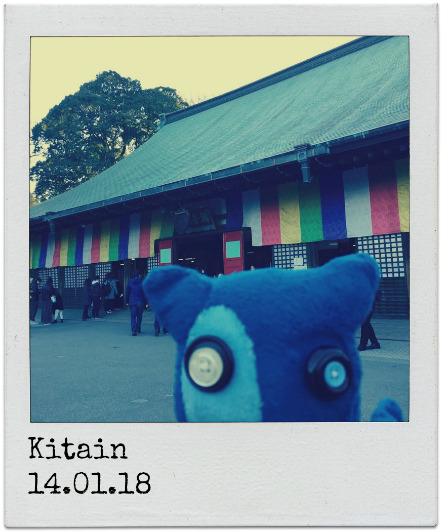
Proprio lì accanto, in un padiglione separato, si trovano anche i 500 Rakan, 540 statue scolpite tra il 1782 e il 1825 che rappresentano i discepoli di Buddha e sono una diversa dall’altra.
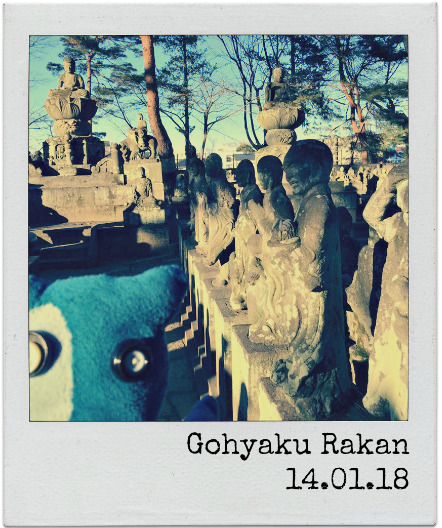
La leggenda vuole che se si riesce a individuare durante la notte l’unica statua la cui pietra è calda, il giorno dopo se si ricorda la posizione in cui si trova si scoprirà che è quella più simile a sé. Avete capito cos’ho detto?
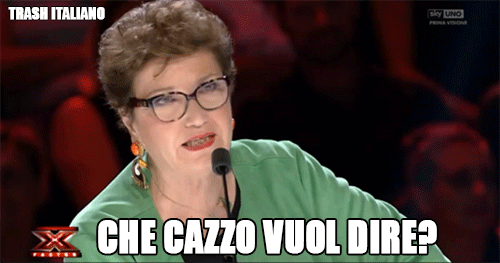
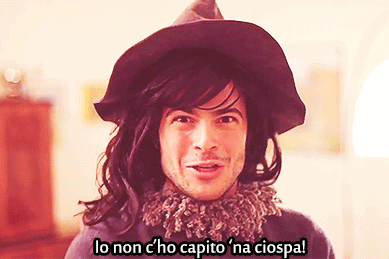
Boh, ma d’altra parte pure i cartelli a Kawagoe danno delle indicazioni alquanto criptiche:

...Okay.
Quello che vi posso dire è che tra i 500 Rakan se ne nascondono 12 che portano con sé gli animali dello zodiaco cinese, come una guida volontaria giapponese ha fortissimamente voluto comunicarmi in inglese nonostante a più riprese gli abbia risposto in giapponese, ma d’altra parte è colpa mia che dovrei imparare a stare al mio posto e a parlare la lingua che ci si aspetta da me.

Sotto il segno della pecora! 🐑 Tra l’altro nello zodiaco occidentale sono Capricorno mentre in quello cinese pecora, in sostanza...

Ciliegina sulla torta, ho tenuto da ultimo il monumento più rilevante e rappresentativo di Kawagoe, che sicuramente molti di voi conosceranno:

Ma chi se l’è arrubbata?
Nonostante saccheggi i nostri monumenti più preziosi, devo dire che Kawagoe non mi è affatto dispiaciuta, anche se avrei voluto avere più tempo per girarla con più calma. Altro errore madornale è stato andarci d’inverno: conoscendomi, dovrei sapere ormai che se voglio fare del turismo devo aspettare la bella stagione perché camminare fuori al freddo mi indispone tantissimo. Mi sono quindi ripromesso di tornarci d’estate, quando avrà anche più senso fermarsi a bere una birra per rinfrescarsi.
💿 Approfittando del fatto che la tradizionale gara di sci intercamerale mi aveva riportato nella prefettura di Nagano, sono tornato a Matsumoto per vedere il museo civico che ospita alcune opere di Kusama Yayoi, originaria appunto della città. Devo dire che mi sono ritrovato a chiedermi come diamine sia riuscito l’anno scorso a vedere in una giornata sia Matsumoto che Nagano senza sbattermi particolarmente a pianificare cambi e coincidenze, visto che quest’anno a causa della penuria di treni ho perso ore ad aspettare nelle stazioni e non avevo ricordi di averci messo così tanto per gli spostamenti. A parte questo, comunque, Matsumoto si riconferma una cittadina molto graziosa, con il suo castello e le Alpi giapponesi ad abbracciarla. Questa volta sono riuscito anche a farmi una passeggiata lungo Daimyōchō-dōri, una via che avevo già adocchiato durante la mia prima visita ma che non avevo avuto tempo di esplorare. Piena di negozietti che si susseguono in piccoli chioschi di legno, è qui tra l’altro che si trova il santuario di Yohashira, dedicato alla dea del Sole Amaterasu e a tre divinità primigenie, Takami-musubi no Kami, Kami-musubi no Kami e Ame no Minaka-nushi no Kami. So che sembra una supercazzola, invece è tutto scritto e documentato nel Kojiki, il testo che racconta il mito fondativo del Giappone.
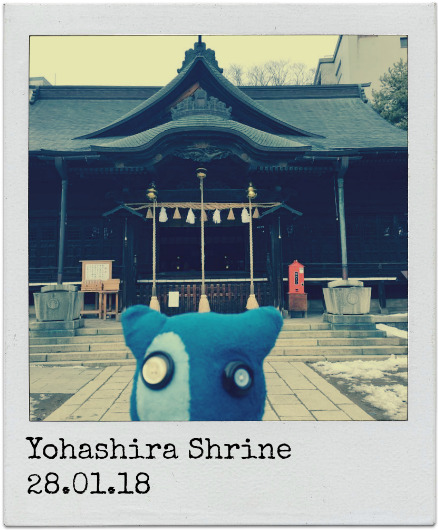
Motivo pricipale del ritorno a Matsumoto come accennavo era il museo di Kusama Yayoi, inconfondibile fin dalla facciata esterna che già vi catapulta nel mondo a pois dell’artista.
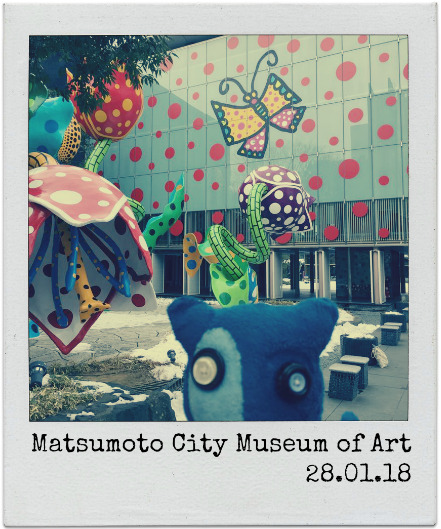
All’interno le opere esposte non sono tantissime devo ammettere, quindi non so se da solo varrebbe un viaggio fino a Matsumoto, ma se uno è in città indubbiamente vale la pena di farci un salto. Anche solo per vedere con che dedizione tutto è uniformato alla poetica di Kusama Yayoi, persino i distributori automatici lol.

💿 A proposito di Kusama Yayoi, dato che evidentemente non ne avevo avuto abbastanza lol, meno di tre mesi dopo sono andato a visitare il museo di Tokyo a lei dedicato, aperto nel gennaio 2017 e dai racconti che avevo sentito all’epoca preso talmente d’assalto che per i primi mesi i biglietti erano già tutti esauriti. I quadri esposti occupano una stanza al secondo piano, e li conoscevo perché praticamente li avevano già esposti tutti alla mostra che avevano fatto su di lei al Centro di Arte Nazionale di Tokyo, mentre è stato decisamente molto interessante entrare nella stanza delle zucche dove finalmente ho visto con i miei occhi una riproduzione delle sue famose installazioni giocate sulla luce, sul buio e sulle immagini delle zucche riflesse allo specchio.
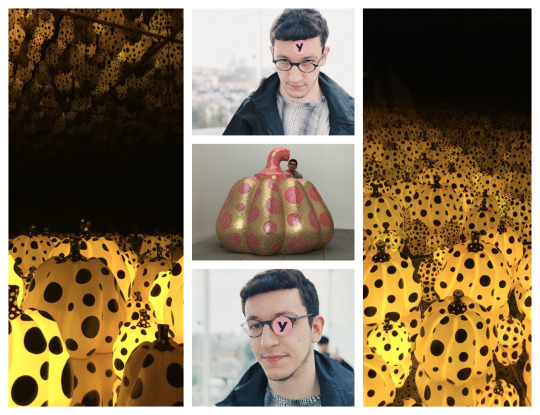
💿 Il centro di cultura e turismo di Asakusa, e la vista del Sensōji che si può godere dalla terrazza all’ultimo piano.

Left pic: © L.S.
Quest’edificio è firmato dal famoso architetto Kuma Kengo, che tra l’altro abbiamo avuto l’onore di avere come speaker a uno degli eventi della Camera Svizzera. Credo che non dimenticherò mai il giorno della presentazione in cui l’ho incontrato di persona e, dopo aver scambiato mail con il suo ufficio in giapponese ma ricordando loro a più riprese che l’evento sarebbe stato in inglese, mentre lo accompagnavo al podio mi fa con estrema nonchalance: “Ma posso parlare tutto il tempo in giapponese, vero?”, facendomi venire un colpo apoplettico. Comunque è bastato dirgli di no perché sfoggiasse un inglese molto navigato, che aplomb. MA ADESSO BASTA CON TUTTA QUESTA CULTURA e ricordiamoci del vero motivo per cui dovreste andare ad Asakusa, e cioè i taiyaki, dolcetti a forma di orata, che invece in un negozietto della zona abbiamo trovato a forma di MAGIKARP.

「ラ・ラ・ラ 言えるかな? ポケモンの名前!」► ポケモン言えるかな?
💿 Per concludere, vorrei che riflettessimo tutti un momento insieme sul fatto che io non avevo idea di che cosa fosse la pinsa romana (da bravo polentone del freddo nord-est) e che ne ho scoperto l’esistenza solo una volta trapiantato in Giappone, quando ho scoperto un negozio che la vendava ad Omotesandō.

Credo fossero due anni che non mangiavo della mortadella, mi stavo per mettere a piangere. Senza contare che non credevo avrei mai visto della mortadella, dei pistacchi e del mascarpone tutti nello stesso piatto qui a Tokyo :Q_
Quindi la mia prima pinsa romana l’ho mangiata a Tokyo, ma vi sembra che abbia un senso questa cosa?
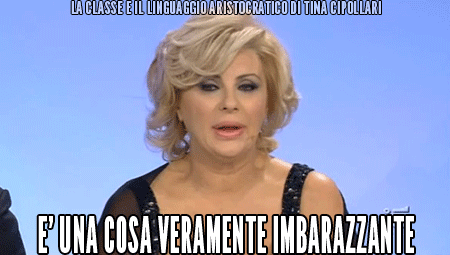
Beh, come testimonia il fatto che è già il secondo weekend di fila che ci vado, una cosa che posso garantirvi è che di sicuro non sarà l’ultima.
0 notes
Text
Cose con cui prepararsi a un anno col pedigree
Sembrava non finire più dicembre quest’anno. Sarà che nonostante mi fossi comprato un calendario dell’avvento all’IKEA (che potrebbe anche pagarmi per dirlo), in realtà non c’era nessun countdown da fare, non tornando in Italia per le vacanze natalizie. Natale è passato abbastanza in sordina a Tokyo. Ammetto le mie colpe: non mi sono sbattuto minimamente per ricreare il clima delle feste, calendario dell’avvento a parte non ho recuperato neppure un tristissimo alberello mignon al tutto un euro. D’altra parte, go big or go home, e in un certo senso a casa ci ero già.
Non è stato il primo Natale che ho passato in Giappone (nel 2014 ero a Kyoto), ma è stato il primo a Tokyo. E così pure per il mio compleanno, che cade il 23 dicembre, lo stesso giorno in cui fatalità è nato l’attuale Imperatore del Giappone. Per quanto si tratti soltanto di una coincidenza, ho sempre trovato divertente questa sorta di legame immaginario che per certi versi potrebbe legittimare il mio amore per il Giappone e in più di un’occasione quando mi è stato chiesto di scrivere un tema su di me in giapponese per allungare il brodo ho scritto per scherzo che un giorno mi sarebbe piaciuto fare una festa di compleanno assieme al mio birthday twin. Nel 2017, approfittando del fatto che per la prima volta mi trovavo a Tokyo nella fatidica data, ho deciso che era finalmente arrivato il momento di vivere il mio sogno metaumoristico e, non potendo organizzare festeggiamenti comuni, recarmi quantomeno al Palazzo Imperiale per fargli gli auguri. Anche perché metti che funziona come col Dalai Lama e cioè che il successore dev’essere nato lo stesso giorno, io intanto lascio giù il curriculum, scusa eh lol
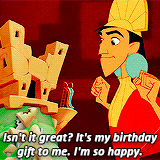
...a proposito di lama... Scherzi a parte, il 23 dicembre è effettivamente una delle uniche due date in cui il Palazzo Imperiale è aperto al pubblico (l’altra è il 2 gennaio, quando vengono fatti gli auguri di buon anno).
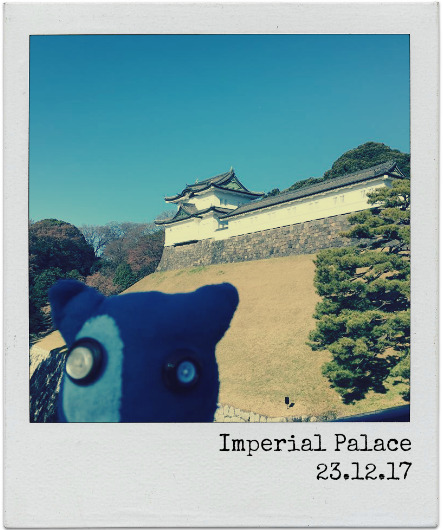
Nel giorno del suo compleanno, l’Imperatore tiene un discorso di ringraziamento e insieme agli altri membri della famiglia imperiale compare diverse volte dal suo balcone superblindato tra le 9 e le 12:30 per salutare la folla accalcata in questo spiazzo che fa un po’ Mulan e un po’ piazza Kim-Il Sung in Corea del Nord.

La lunghissima fila che si dipana fuori dal palazzo viene fornita all’occorrenza di bandierine del Giappone da sventolare e deve passare i non proprio severissimi controlli prima di poter accedere alla residenza imperiale. In verità devo dire che la coda si è smaltita anche in fretta, o meglio non mi è parso di aspettare un’infinità si tempo per entrare, per quanto non fossi assolutamente arrivato tra i primi.

「天皇誕生日一般参賀:みんな待つ(松)」
Una volta varcata la soglia del Palazzo, in un clima di trepidante attesa, tra stupore e tremori, Akihito si mostra da dietro uno schermo di vetro affiancato dai suoi cari e tiene un commoventissimo discorso che riassunto suona più o meno così: “Grazie di essere venuti nel giorno del mio compleanno. Anche quest’anno sono successe un sacco di cose. Speriamo che l’anno prossimo sia prospero e felice”. Ora, vabbè che è l’Imperatore, che c’ha 84 anni e che tiene questo discorso ogni anno da 28 anni, però minchia Akihito c’hai avuto un anno di tempo, potevi anche sbatterti un attimino di più eh. Per fortuna a rendere decisamente indimenticabile la cerimonia c’era proprio dietro di me un gruppetto di inquietanti nazionalisti che ha fatto partire assordanti cori da stadio cantando a squarciagola l’inno giapponese e urlando “天皇陛下万歳” (tennō heika banzai, “lunga vita all’Imperatore”), una di quelle espressioni che studi e che conosci ma che non ti aspetteresti mai di sentire pronunciare dal vivo, e invece ti traforano i timpani proprio il giorno del tuo compleanno.
Per consolarmi del fatto che l’Imperatore non mi avesse nemmeno citato nel suo discorso, quella sera per ripicca ho deciso di fare una cosa che lui non può fare in modo da sentirmi superiore: sono andato a mangiare il pesce palla (河豚, fugu). Come ci insegnano i Simpson, se non preparato a dovere il pesce palla è estremamente velenoso perché contiene nel fegato, nelle gonadi, negli occhi e nella pelle quantità letali di tetrodotossina, una sostanza cento volte più tossica del cianuro che provoca la paralisi del diaframma con conseguente morte per insufficienza respiratoria. Non a caso il mio adorato Tsutsui Yasutaka, uno degli scrittori giapponesi più ironici che mi sia mai capitato di leggere e anche uno dei pochi, nel suo “Gendaigo Ura Jiten” (現代語裏辞典, “Dizionario del lessico occulto contemporaneo”, un vero e proprio vocabolario in cui riporta più di 12000 parole della lingua giapponese dandone una definizione spiritosa e a volte estremamente irriverente), alla voce “paralisi” scrive: “Allora, era buono il fegato del pesce palla?”. Il motivo per cui l’Imperatore non può mangiare questo pesce è dunque presto spiegato: non sarebbe bello né per il Paese né per il cuoco che per una distrazione nella preparazione delle carni ci restasse secco.

A tale proposito, si racconta che nel 1947 venne offerto del pesce palla all’Imperatore Hirohito, recatosi nella prefettura di Yamaguchi nel suo pellegrinaggio attraverso il Paese che era appena uscito sconfitto dal secondo conflitto mondiale. Il governatore di Yamaguchi, infatti, aveva domandato ad Akiyama Tokuzō, il cuoco imperiale, quale fosse la pietanza preferita di Hirohito, ma lo chef si era rifiutato di rispondere perché temeva che se la notizia fosse trapelata si sarebbero visti preparare lo stesso piatto ovunque si fossero fermati lungo il tragitto. Il governatore, a quel punto, optò per una delle specialità più prelibate della zona, il pesce palla appunto, e Akiyama Tokuzō, per quanto riluttante, sarebbe stato anche disposto a fare da assaggiatore per scongiurare ogni pericolo di avvelenamento, ma il ciambellano Irie Sukemasa si oppose fermamente non solo perché temeva per l’incolumità dell’Imperatore, ma anche per evitare che venisse sdoganato un consumo poco avveduto delle carni del pesce palla da parte del popolo con conseguenti casi di intossicazione. Ma le controversie che questo piccolo pesciolino ha fatto sorgere nel Paese del Sol Levante hanno una storia molto più antica: nel XVI secolo, durante il periodo degli Stati combattenti, Toyotomi Hideyoshi, uno dei tre grandi unificatori del Giappone, ne vietò il consumo perché diversi soldati del battaglione che aveva lasciato di stanza nella prefettura di Saga in Kyushu mentre combatteva nella penisola coreana morirono proprio per avvelenamento da pesce palla; proibito ai soldati ma non alla plebe nel periodo Edo (1603-1868), poi a tutto il Paese in periodo Meiji (1868-1912), nel 1888 venne servito al Primo Ministro Itō Hirobumi per mancanza di altre pietanze nonostante fosse contro la legge proprio a Yamaguchi, ed egli lo apprezzò a tal punto da esentare dal divieto quell’unica prefettura; bisognerà però aspettare il secondo dopoguerra perché il consumo di pesce palla torni ad essere legale in tutto il Paese.
Insomma, tutto questo pippone per un pesce che poi NON SA NEANCHE DI NIENTE, o meglio, sa dai condimenti con cui viene servito, e cioè un’erba simile all’erba cipollina, salsa di soia e una salsina allo yuzu, un agrume giapponese. Altrimenti, giuro, pare di masticare gomma.

Pelle, carni e lattume del pesce palla, giusto per non lasciare nulla di intentato, vuoi mai che ti sfugga una parte potenzialmente letale. Il lattume è forse l’unica parte vagamente saporita, anche se purtroppo il film “Okuribito” mi ha crudelmente svelato di cosa si tratta 🐡

Visto che comunque dal giorno del mio compleanno fino al 5 di gennaio mi ero preso ferie, mi sarebbe sembrato un delitto passarle tappato in casa, anche perché sentivo che era arrivato il momento di prendere una pausa da Tokyo e andare da qualche parte dove non ero ancora mai stato. Scegliere una meta non è stato semplicissimo perché molti dei posti che ancora non ho visto del Giappone probabilmente rendono meglio se visitati con la bella stagione, e fare del turismo in inverno per me che odio il freddo in generale non è proprio il massimo. Ma visto che ancora non controllo il tempo come Pudge, l’unica cosa che mi sono sentito di fare è stato dare un senso al freddo e fare un giretto nel Tōhoku, la zona più a nord dello Honshū, facendo base a Sendai, la città principale e unica metropoli della regione, famosa per la zunda (ずんだ), che pensavo fosse una roba che si fa in palestra e invece è una pasta dolce di fagioli di soia, e il gyūtan (牛タン, ‘lingua di bue’).

「仙台のずんだ青空の下で」
Ora, prima che io prosegua oltre, fatemi aprire una parentesi che mi sta molto a cuore - sono ancora un po’ fomentato perché ne ho recentemente parlato sia con delle connazionali che nella loro esperienza avevano notato esattamente la stessa cosa sia con giapponesi che non riuscivano affatto a cogliere il senso della mia obiezione. Io ho un enorme problema con il modo di fare turismo dei giapponesi, che principalmente consiste nell’andare in giro a mangiare. Lo so, è abbastanza ironico che un italiano muova questa critica visto che una delle cose per le quali siamo famosi nel mondo è proprio la cucina, però c’è qualcosa di profondamente sbagliato dal mio punto di vista nel fatto che le guide turistiche giapponesi di QUALSIASI POSTO contengano due pagine striminzite di luoghi di interesse e altre trecentoquaranta di cibi locali, café, ristorantini, specialità culinarie e quant’altro. O ancora, che se parlo con un giapponese di un posto dove voglio andare la prima cosa che mi dirà è cosa si mangia di tipico lì, e su quello tutti ferratissimi, mentre se timidamente gli faccio notare che in realtà ci vado per vedere [aggiungi luogo di interesse a caso] la metà delle volte non avrà neppure idea di cosa sia. Per carità, se c’è un piatto tipico particolarmente celebre in una città che visito chiaramente mi fa piacere assaggiarlo, ma questa cosa non può diventare la priorità numero 1 del viaggio e offuscare completamente tutto il resto. Ora, vero è che a Sendai e dall’idea che mi sono fatto pure nel resto del Tōhoku dal punto di vista culturale rispetto ad altre aree del Giappone non c’è troppissimo di interessante, per cui almeno puoi dare un senso al viaggio trasformandolo in un tour gastronomico, ma questo problema non riguarda mica solo le guide turistiche di Sendai e del Tōhoku, per cui faccio fatica a giustificarla. Comunque vabbè, sarò io che col mio punto di vista eurocentrico do giudizi colonialisti credendo di essere meglio, non so.
Ah, già che siamo in tema di giudizi colonialisti: menzione d’onore all’appartamento in stile tradizionale trovato con AirBnB a Sendai, che era anche l’unico che era rimasto e quindi non è che ci fossero tante alternative, però ragazzi le stanze in legno e carta col tatami mi vanno pure bene, ma il bagno enorme con la doccetta che esce dal muro perché tu ti possa insaponare e sciacquare a secchiate prima di immergerti nella vasca ha senso se però C’È UNA VASCA, ma se non c’è diventa semplicemente una stanza gigantesca dove prendere freddo, soprattutto se la pressione dell’acqua è praticamente un valore negativo che la fa risalire al contrario nei tubi invece che farla uscire. Boh, grazie commodoro Perry per aver portato la civilizzazione quella volta aprendo la strada agli unit bath.
Finito questo sfogo razzista, passiamo invece alle meraviglie che il Tōhoku teneva strette nella morsa del freddo, a partire dallo Yamadera, nome con cui è comunemente noto il Risshakuji (立石寺, “Tempio delle Pietre Erette”).
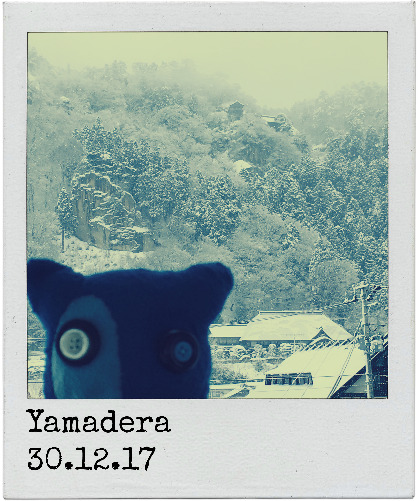
Questo tempio buddhista di scuola Tendai, fondato da Jigaku Daishi/Ennin nell’860, si trova a un’oretta di treno da Sendai, nella vicina prefettura di Yamagata, ed è incastonato tra le rocce di un pendio boscoso che Matsuo Bashō visitò alla fine del 1600 componendovi un famoso haiku contenuto nella raccolta “Oku no Hosomichi” (奥の細道, “L’angusto sentiero del Nord”).

「閑さや 岩にしみ入 蝉の声」【芭蕉松尾】 “La quiete filtra tra i sassi, il frinire delle cicale” (Matsuo Bashō) Okay, definitely wrong season.
I gradini che conducono sino al punto più alto del complesso sono 1015 e con la neve e il ghiaccio sono semplicemente impraticabili. Se non fosse stato per il solido corrimano che fortunatamente non mi ha mai abbandonato (mi perdonerà Hannah Arendt, ma avrei voluto vedere lei con le Vans al mio posto), credo che avrei fatto una bruttissima fine visto che anche aggrappandomici sono riuscito a scivolare lo stesso un’infinità di volte. Una delle prime tappe a cui si giunge è il Konponchūdō, la sala principale e più antica dove si dice arda ancora la fiamma che venne trasportata dall’Enryakuji di Kyōto (dove Jigaku Daishi/Ennin era entrato alla giovane età di 14 anni), di cui lo Yamadera sarebbe una sorta di filiale. Ah, ecco perché mi è toccato visitare anche questo tempio sotto la neve e in terribili condizioni di disagio, si vede che c’è un fil rouge che non può essere spezzato.
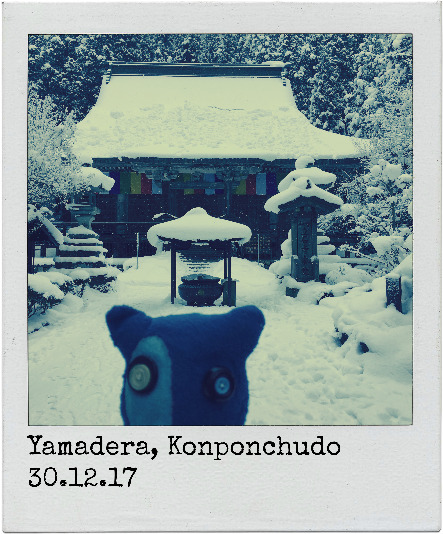
Diversi scivolosi scalini dopo, si passa di fianco alla Midahora, un’altura rocciosa con diverse rientranze modellate dagli agenti atmosferici che dovrebbe portare fortuna a chi è in grado di vedervi il volto di Buddha, e si attraversa la Niōmon, una delle porte più nuove del complesso, per raggiungere la zona più elevata del tempio.
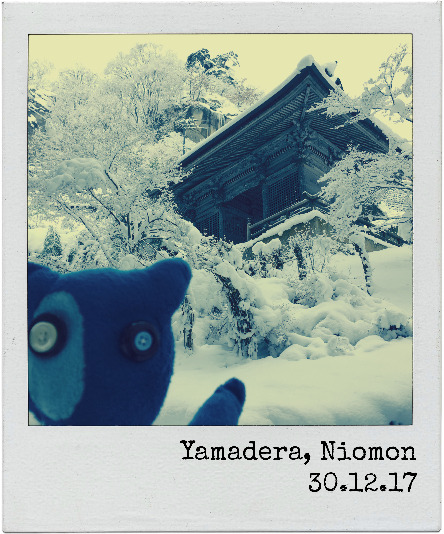
Oltrepassata la porta, il paesaggio che si gode dalla cima del tempio è davvero spettacolare, e particolarmente suggestivo proprio perché ammantato di neve, cosa che mi fa rivalutare il fatto di esserci venuto in inverno.

「只居れば 居るとて雪の 降にけり」【小林一茶】 “C'ero soltanto. C'ero. Intorno cadeva la neve” (Kobayashi Issa)

「消えにけり 今ぞまことの 雪仏」【山崎宗鑑】 “Si è sciolto: è ora davvero tale questo Buddha di neve” (Yamazaki Sōkan)
Altra tappa che non si poteva saltare essendo a mezz’oretta da Sendai è Matsushima, la cui baia disseminata di isole ricoperte di pini è uno dei tre più suggestivi paesaggi del Giappone (日本三景, ‘Nihon Sankei’) annoverati da Hayashi Razan nel XVII secolo insieme al torii galleggiante di Miyajima e l’istmo di Amanohashidate.
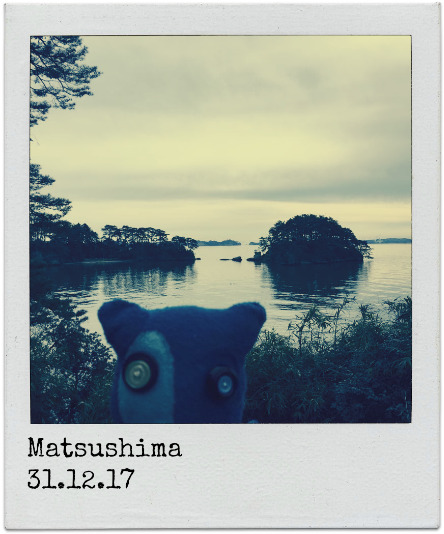
Mi mancava solo Matsushima per poter affermare di averli visti tutti, per cui figurarsi se mi lasciavo scappare l’occasione di completare il Pokédex.

Le tre vedute del Giappone, di Utagawa Hiroshige, e le tre peggiori foto mai fatte loro, di Alberto Zanonato.

Devo riconoscere che probabilmente la vista della baia non rende tantissimo in inverno, specie sotto un cielo cinereo, ma al di là di questo credo che nella mia personale classifica Matsushima occupi solo il terzo posto tra le vedute, mentre metterei il torii galleggiante in seconda posizione e darei la medaglia d’oro ad Amanohashidate che è decisamente il paesaggio più spettacolare dei tre. Delle numerose isolette di Matsushima, quella di Fukuurashima è l’unica raggiungibile a piedi tramite un ponte, detto Fukuurabashi, ed è l’ideale per fare una passeggiata circondati da una sorprendente varietà di piante e alberi alla ricerca del punto migliore per ammirare il panorama circostante. Che io chiaramente non ho trovato. (E a proposito di panorama, anche se ovviamente si tratta di autosuggestione, girando per Fukuurashima mi sono sentito un po’ come se fossi sull’isola di Okinoshima citata da Edogawa Rampo nel suo racconto “La strana storia dell’Isola Panorama”).
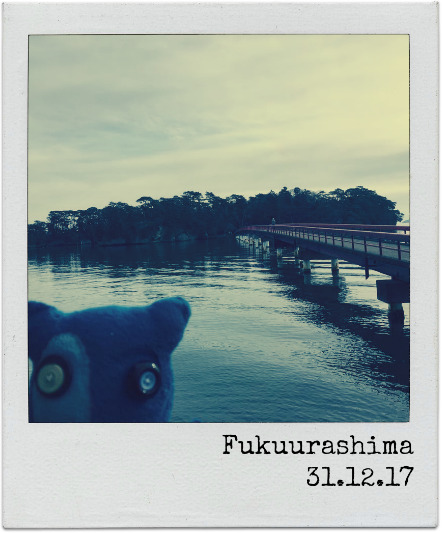
Non distante dalla baia, è possibile visitare lo Zuiganji, un tempio fondato nell’828 sempre da Jigaku Daishi/Ennin, inizialmente appartenente al buddhismo Tendai (sin da allora, venivano svolte pratiche ascetiche nelle cavità rocciose che ancora fanno parte del complesso), ma convertito poi in periodo Kamakura (1185-1333) a sede del buddhismo zen. In seguito a un periodo di declino, durante il quale non fu più il tempio di un tempo (lol), venne fatto restaurare tra il 1604 e il 1609 da Date Masamune, signore di Sendai, che voleva usarlo come seconda roccaforte in caso il castello di Sendai fosse stato espugnato (tanto che presenta i tipici pavimenti scricchiolanti detti “a usignolo” che ha anche il Nijōjō a Kyōto). Diversi edifici tra cui la sala principale e il refettorio (庫裡, kuri) sono tesori nazionali e i bei dipinti di scuola Kanō che ospitano sono proprietà culturali importanti.
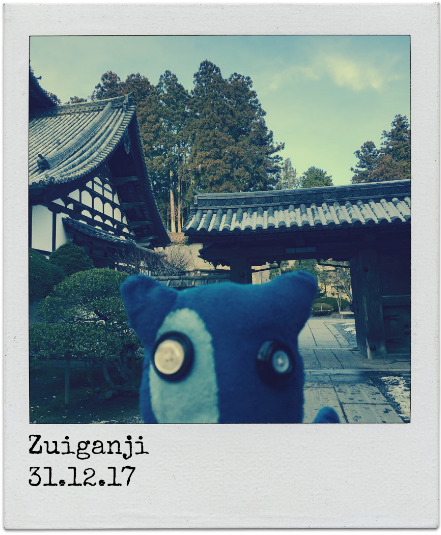
Camminando lungo il viale di cedri secolari all’entrata del tempio, parte dei quali furono piantati dall’Imperatore Meiji nel 1876, si noterà un cartello che ricorda il punto dove è arrivato lo tsunami dell’11 marzo 2011, colpendo lo spettatore come uno schiaffo dato all’improvviso.

“I came into the world after Buddha. I leave the world before Miroku. Between the Buddha of the beginning and the Buddha of the end. I am not born, I do not die.” (Ungo Kiyō, monaco zen presso lo Zuiganji)
Tornando a Sendai, devo dire che freddo a parte la città non mi è affatto dispiaciuta, nonostante la Lonely Planet non se la calcoli nemmeno. La chiamano la città degli alberi (杜の都, ‘mori no miyako’) perché pare che sin da prima delle restaurazione Meiji (1868) fosse una delle città più verdi del Giappone, al punto che i residenti erano incoraggiati a piantare alberi e piante nei loro giardini. Non è casuale che la principale circoscrizione si chiami Aoba (青葉, “giovani foglie”) ed è tuttora è possibile ammirare una sessantina di alberi di zelkova lungo le vie Aoba-dōri e Jōzenji-dōri, dove tra l’altro sono presenti tre statue di scultori italiani (Emilio Greco, Venanzo Crocetti e Giacomo Manzù).

“Ricordi d’Estate” di Emilio Greco e “Odisseo” di Giacomo Manzù
Se da un lato visitare Sendai in inverno è un po’ un peccato perché non si coglie di preciso il senso del suo soprannome visto che gli alberi sono quasi tutti spogli, dall’altro proprio nel mese di dicembre vengono decorati con luminarie lungo tutta Jōzenji-dōri creando quello che viene chiamato lo Hikari no Pageant (光のページェント, “Corteo delle Luci”).

Catch a falling star, you'll go far in the pageant of the bizarre, and tonight I give you my heart ☆彡
Nella stessa zona si trova la Mediateca di Sendai, opera dell’architetto Toyo Ito, una struttura di vetro quadrata su sette piani che vengono attraversati da 13 pilastri metallici che si torcono e deformano dal piano terra verso l’alto a ricordare delle alghe.
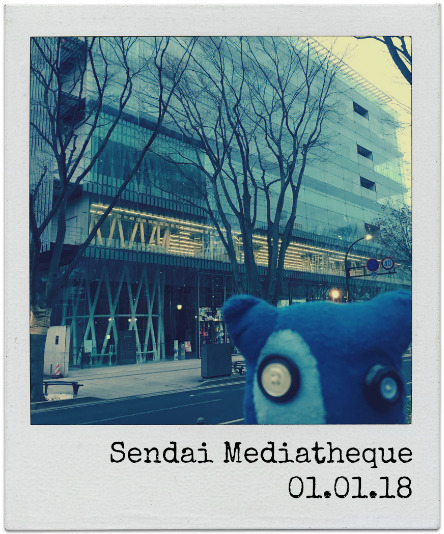
Sendai ha due linee metropolitane, la Tōzai e la Nanboku, che come suggerisce il nome in giapponese portano la prima da est a ovest e la seconda da sud a nord. Ce le abbiamo anche a Tokyo con lo stesso nome per lo stesso motivo, ma la cosa che mi ha fatto sorridere è che anche a Sendai hanno gli stessi identici colori di Tokyo, la prima celeste e la seconda verde-acqua. Ora, se da un lato apprezzo la coerenza, mi volete dire che con tutti i colori dell’iride non potevate sceglierne due di un po’ più distintivi per Sendai? Senza parlare poi dell’infelice coincidenza che fa sì che l’abbreviazione di Sendai Subway, riportata nel logo, sia disgraziatamente SS.

Tokyo complex anyone? Sono anche i miei colori preferiti, eh, però viva la fantasia! lol
La storia della città è indissolubilmente legata alla figura del daimyō Date Masamune, il “drago da un occhio solo” (独眼竜 ‘dokuganryū’ come veniva soprannominato a causa dell’occhio mancante), che nel 1600 vi fece edificare il proprio castello, l’Aoba-jō, di cui oggi non è rimasto praticamente nulla. Una statua equestre nello spiazzo dove una volta sorgeva la sua roccaforte ne ricorda le gesta, e suggerisce che sia morto per le ferite riportate in battaglia dato che una zampa del cavallo è sollevata, ma poiché dalla sua biografia non mi risulta credo suggerisca semplicemente che lo scultore non si rifà alla simbologia delle statue equestri lol
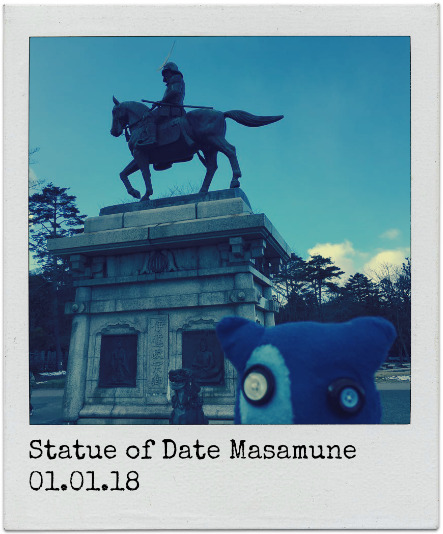
Si deve tra l’altro proprio a Date Masamune la scelta dei caratteri cinesi che compongono il nome di Sendai (仙台, “la piattaforma dell’eremita” o, in senso più lato, un territorio molto elevato), tratti da un componimento in cinese di epoca Tang intitolato “Tóng tí xiānyóu guān” (同題仙遊観, tradotto in inglese come “Inscribed in the Temple of the Wandering Genie”) in cui il poeta Han Hong loda il palazzo dell’Imperatore Wen della dinastia Han paragonandolo ai picchi dove abiterebbero eremiti dai poteri soprannaturali con i seguenti versi: 仙臺初見五城楼 I face, high over this enchanted lodge, the Court of the Five Cities of Heaven, 風物凄凄宿雨収 And I see a countryside blue and still, after the long rain. 山色遙連秦樹晩 The distant peaks and trees of Qin merge into twilight, 砧聲近報漢宮秋 And washing-stones at the Han Palace make their autumnal echoes. 疎松影落空壇淨 Thin pine-shadows brush the outdoor pulpit, 細草春香小洞幽 And grasses blow their fragrance into my little cave. 何用別尋方外去 Who needs to be craving a world beyond this one? 人間亦自有丹丘 Here, among men, are the Purple Hills. I primi due caratteri, semplificati poi in 仙台, dovevano essere di buon auspicio affinché la città prosperasse a lungo al pari di una montagna abitata da eremiti immortali, e andarono a sostituire quelli precedenti, 千代 (che comunque significa “mille generazioni”, sputaci sopra lol) che a loro volta erano un riferimento a un tempio che si trovava nella zona ed ospitava mille statue di Buddha (千体, ‘sentai’). Questi mille Buddha non esistono più ma in compenso dalla piattaforma dove sorgeva il castello di Date Masamune si può scorgere all’orizzonte la colossale statua del Sendai Kannon, alta cento metri e che vi sfido a individuare nella terribile foto qui sotto.

Ma quello là in fondo cosa sarebbe? Un angelo? SHINJI PREPARATI A PILOTARE L’EVA!

E a proposito di cose inquietanti che si ergono giganti dove non dovrebbero, beccatevi la bambola kokeshi del Nishi Park:

Le kokeshi sono bambole in legno dipinto originarie della regione del Tōhoku, dove iniziarono ad essere prodotte alla fine del periodo Edo (1603-1868) come souvenir per i turisti che soggiornavano alle terme. Tra le loro caratteristiche vi è la mancanza di braccia e gambe e l’estrema stilizzazione dei tratti del viso e delle decorazioni del kimono, anche se poi ogni regione del Tōhoku ha un proprio modo peculiare di realizzarle. E niente, forse sono rimasto traumatizzato dalla bambola di Paprika, ma le trovo abbastanza perturbanti.
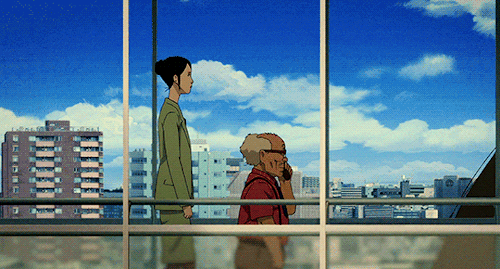
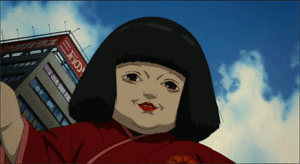
Sempre nelle vicinanze delle fondamenta del castello, si trova anche il Gokoku-jinja (護国神社), un santuario dedicato ai soldati caduti che rappresenta una sorta di ramo distaccato dello Yasukuni-jinja a Tokyo, di cui ricopre la stessa funzione. Essendo il primo gennaio c’era una lunghissima fila di gente accorsa per la prima visita al santuario dell’anno (初詣, hatsumōde) che sinceramente mi ha pure fatto passare la voglia di entrarci, ma fa più bello dire che mi sono rifiutato di visitarlo come forma di protesta antimilitarista.

Ho anche provato ma il Nekomata da solo non sarebbe bastato a coprire la folla per evitare che si vedesse solo quella nella foto, e allora ho semplicemente lasciato perdere lol
La salma di Date Masamune, morto nel 1636 all’età di 70 anni, è custodita nello splendido Zuihōden, un tempio riccamente decorato nello stile Momoyama che venne costruito per fungere da mausoleo e che divenne Tesoro Nazionale nel 1931. Tragicamente distrutto da un raid aereo nel 1945, quella che vediamo oggi è una ricostruzione del 1974.
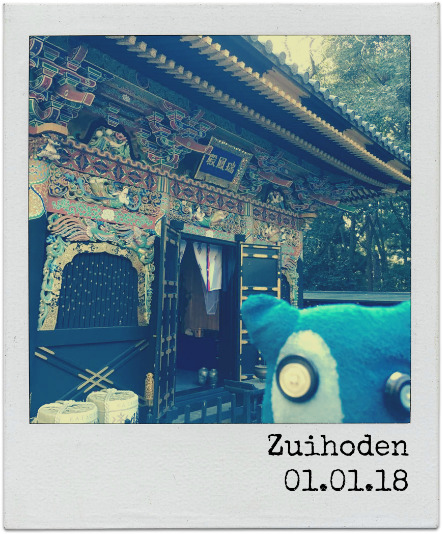
Poco distanti dallo Zuihōden, sempre immersi nel verde, si trovano anche i mausolei dei successori di Masamune, Date Tadamune, sepolto nel Kansenden, e Date Tsunamune, le cui spoglie si trovano nello Zennōden. Proprio all’entrata del parco in cui si trova il complesso, è possibile visitare anche lo Zuihōji, tempio zen di scuola Rinzai voluto da Date Tadamune.
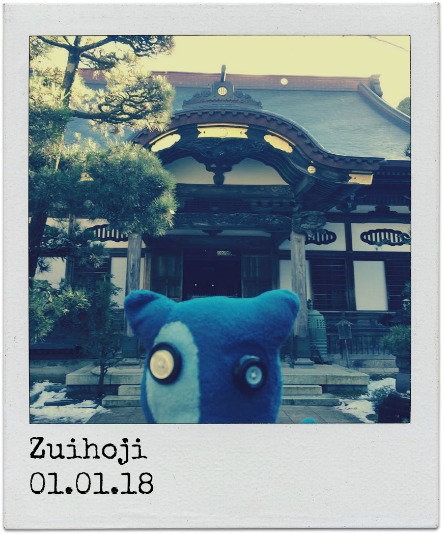
Già che tutti facevano hatsumōde, pareva brutto non incolonnarsi con altre centinaia di giapponesi davanti all’Ōsaki Hachimangū, santuario voluto da Date Masamune, dove estraendo l’omikuji (御神籤, oracolo scritto su carta che riporta il grado di fortuna in vari campi, dall’amore al denaro agli affari, robe che Brezsny levati) ho beccato il daikichi 大吉, che è il grado di fortuna più alto, ma mi è stata messa la pulce nell’orecchio circa il fatto che il primo giorno dell’anno probabilmente ne mettono molti più del solito onde evitare che la gente si faccia condizionare e pensi di essere destinata a un’intera annata demmerda... Non so, non ho prove che sia o che non sia così, però c’avrebbe pure senso, a meno che non li vogliano trovare tutti nella foresta dei suicidi così poi Paul Logan può fare i big views.
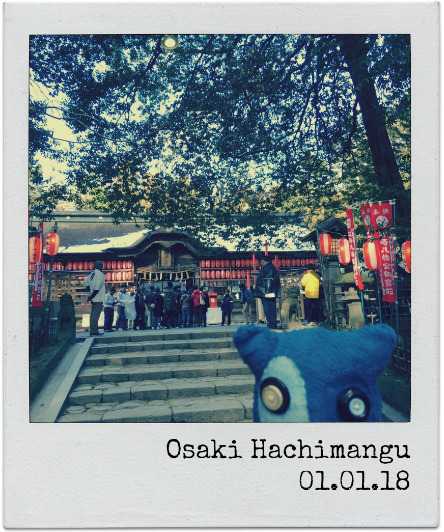
Finisce qui il mio giro del Tōhoku. Devo essere sincero: mi ha fatto molto piacere esplorare una parte del Giappone che mi mancava ancora completamente e Sendai è una piccola Tokyo in miniatura che probabilmente vorrei revedere con temperature più favorevoli al turismo (senza contare che adesso che l’ho visitata posso cantare “Chennai, Sendai, I’ve been all over the world now” insieme a Maia Hirasawa con più convinzione lol), ma detto questo l’idea che mi ero fatto circa la regione più settentrionale dello Honshū (e cioè che se ti interessano i paesaggi naturali ci può anche stare, ma se sei alla ricerca di luoghi di interesse culturalmente rilevanti hai veramente poco da vedere) temo non fosse troppo lontana dalla realtà. Mentre aspettavo la corriera che mi avrebbe riportato a Tokyo e guardavo le destinazioni degli altri pullman mi sono messo a cercare su Internet cosa ci fosse in quelle città, e la cosa più interessante che ho trovato è stata un ponte. Per cui insomma, spero mi ricapiti di tornare nel Tōhoku perché ci sono delle zone che mi piacerebbe visitare, ma diciamo che non è la zona del Giappone che prediligo. Ma vabbè, il primo posto in classifica rimarrà sempre di Kyōto e lo sappiamo tutti, chevvelodicoaffare lol
Postilla: mi sono reso conto che una figura mitologica mi ha seguito durante tutto questo viaggio. Me lo sono ritrovato a Matsushima in diverse copie a decorare le pareti di un santuario, poi incartato nel foglietto dell’omikuji all’Ōsaki Hachimangū, che eccezionalmente aveva allegato anche un piccolo portafortuna, e infine sottoforma di portachiavi scolpito nel legno di sofora giapponese da un artigiano che mi ha convinto a comprarne uno. Si tratta di Daruma-san, figura che rappresenta in maniera stilizzata Bodhidharma, patriarca dello zen, a cui è usanza dipingere un occhio quando ci si prefigge un obiettivo aspettando di portarlo a compimento per poter dipingere anche l’altro, e che per la sua particolare forma ritorna in piedi anche se si tenta di spingerla verso il basso. Questa caratteristica è vista come un sinonimo di costanza ed è ben riassunta da un proverbio, nanakorobi yaoki (七転び八起き, “cadi sette volte e rialzati otto”). Dato che ci siamo lasciati alle spalle il 2017 e abbiamo appena iniziato il 2018, quindi abbiamo fatto cadere il 7 sostituendolo con l’8, mi è parso che nella sua totale casualità Daruma-san avesse fatto la sua comparsa proprio nel momento giusto e che fosse il modello perfetto a cui ispirarsi nel nuovo anno. Vi, anzi, ci auguro questo per il 2018: di trovare sempre la forza di rialzarci anche quando cadiamo mentre rincorriamo i nostri obiettivi. Banale, lo so, ma non per questo facile a farsi. E niente, buon anno del Cane, speriamo non un anno da cani 🐕

0 notes
Text
Cose con cui cambiare aria quando arriva l’autunno
"Il sole a settembre mi lascia vestire ancora leggera", canta Cristina Donà in qualche angolo della mia testa mentre mi godo il bel tempo che Tokyo ancora regala anche se ci avviciniamo sempre di più all'autunno, e mentre in un altro angolo L'Orso canta "ottobre come settembre", purtroppo appena giro il calendario perché si è fatto il primo di ottobre pioggia, freddo, sintomi influenzali e stanchezza di vivere mi fanno capire che invece il nuovo mese sarà tutt'altra cosa, con buona pace del povero orso. La solita Cristina Donà cantava pure "sembra che non finisca mai settembre" proprio ne "I calendari" di DiMartino tra l'altro, ma sfortunatamente a me sembra sia proprio finito e anche in modo tremendamente brusco. Signora mia, non esiste più la mezza stagione.

Sono nato in inverno ma è la stagione che più detesto, e anche dell'autunno non è che sia proprio un fan sfegatato. Certo, ci sono le foglie rosse degli aceri e il maple coffee al conbini e più nessuno stigma sociale sul bere tè caldo, ma da sole queste cose non sono sufficienti a farmi superare il trauma della fine della bella stagione. Soprattutto a Tokyo dove probabilmente le uniche foglie rosse che vedrò saranno quelle di plastica esposte dagli esercizi commerciali per ricordare ai potenziali acquirenti l'arrivo di entusiasmanti seasonal goods, limited edition. Insomma, per dirla con la Littizzetto, arriva l'autunno, cadono le foglie e pure i maroni.
Per fortuna in questo momento di insofferenza e spleen, un evento della Camera mi ha provvidenzialmente portato nel Kansai, dove a pensarci bene potrei dire che tutto è iniziato, storicamente per il Giappone ma pure per me lol. Avevo proprio bisogno di andarmene affan***o (affannato, affannato is the word. O anche bird, bird is the word, always) lontano da Tokyo, lontano da tutto, lontano da me per qualche giorno. Approfittando del fatto che i tre giorni precedenti all'evento sarebbero stati festivi, ho ben pensato di approfittarne per fare un giro nel buon vecchio Kansai, a Ōsaka e a Ise, due città che sentivo avessero ancora qualche sorpresa da riservarmi. È stata la prima volta che pur essendoci così vicino non sono andato a Kyōto, che pure era in lista quando ho valutato le zone limitrofe dove avrei potuto sostare, ma essendo l'evento proprio a Ōsaka non avevo troppa voglia di spostarmi due volte in tre giorni e alla fine ho optato per rimanere il più vicino possibile alla città. Non posso dire però che operare questa scelta non mi abbia fatto uno strano effetto, come se stessi rinunciando a ricongiungermi con una parte di me, del mio passato, ma a volte serve anche cambiare proprio aria, senza rifugiarsi nei bei tempi andati.
Viaggiare da solo non è l'opzione che preferisco di solito, ma in questo caso specifico avevo davvero bisogno di riprendermi i miei spazi e rispettare i miei tempi, anche per dimostrarmi che anche senza un'oculata organizzazione e solo una vaga idea di cosa fare sono perfettamente in grado di gestirmi lol. Il sabato del mio arrivo, in cui tutto fila liscio e procedo con sicurezza persino oltre la portineria dell'AirBnB affittato illegalmente da una tizia che già mi aveva avvisato che avrei forse dovuto mentire al custode annunciandomi come un suo amico, provvedo già a smentire questa mia tesi fiondandomi al Sumiyoshi Taisha, un vasto santuario famoso per il suo ponte rosso, i cui principali luoghi di interesse, a causa dell'orario e di un'imprevista cerimonia nuziale, sono, purtroppo, inaccessibili.
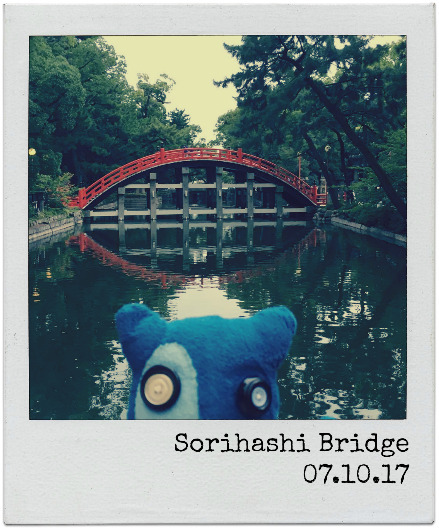
Ponte Sorihashi, anche noto come Taikobashi (太鼓橋, "Ponte del Tamburo") per la forma circolare che si crea grazie al riflesso nell'acqua.
Arrivo tra l'altro quasi a litigare con un sacerdote incaricato di officiare il matrimonio perché evidentemente giudica che il fatto che io mi sia accorto sulla soglia del padiglione dove avviene la cerimonia e mi sia girato per tornare sui miei passi non siano sufficienti garanzie del fatto che me ne sto per andare, e con incedere solenne fa per venirmi incontro. "Non si può entrare oggi immagino, vero?" chiedo timidamente, convinto che la conversazione si chiuderà con una sua veloce conferma. "Questo è invero un edificio molto speciale", risponde lui (???), e comincia un imbarazzantissimo ping-pong verbale in cui io cerco di ribadire che me ne sto andando tentando di dimostrargli che ho capito che oggi non potrò visitare il padiglione, ma lui continua a replicare con informazioni che non gli ho richiesto ("guardi non c'è problema, torno anche domani..." "chissà se è aperto domani. Ha controllato?" MA SENTI MA LA PIANTI È UN MODO DI DIRE), e solo un'estenuante e pressoché inutile contrattazione riesco a farmi confermare che si, oggi visite non se ne fanno, OH, WE GOT THERE, adesso mi lasci andarmene affan***o che ci volevo andare da solo da sei ore e l'unica cosa che me lo ha impedito è la pezza che mi hai attaccato?
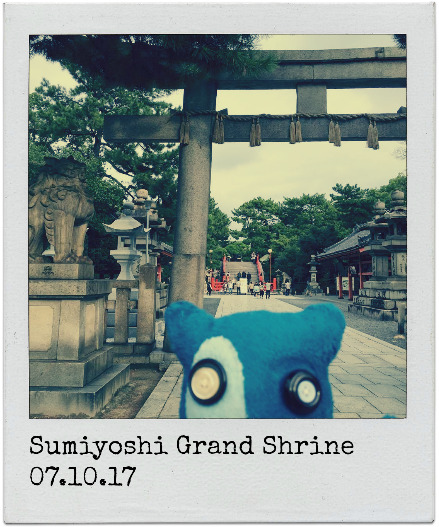
Il Sumiyoshi Taisha è stato fondato nel 211 ed è a capo di quasi altri 2300 santuari omonimi sparsi per tutto il Giappone. Anche se gli edifici attuali sono stati ricostruiti dopo essere stati danneggiati dai bombardamenti nella seconda guerra mondiale, è stato preservato lo stile architettonico originale che è uno dei più autentici e antichi esempi di architettura scintoista di periodo Yayoi che si possa ancora apprezzare. È dedicato alle divinità del mare, della navigazione, della poesia e della guerra e commemora la traversata dell'imperatrice Jingū che aveva guidato l'esercito alla conquista della penisola coreana ed era tornata vincitrice.

Come accennavo causa orario, matrimonio e litigio col prete non sono riuscito a vedere la zona del Godairiki, nel cui suolo sassoso si celano dei ciottoli con inscritti i caratteri cinesi di "cinque" (五), "grande" (大) e "forza" (力), che se reperiti garantirebbero uno dei cinque grandi poteri (forza fisica, intelligenza, buonasorte, ricchezza e longevità), ma a parte il fatto che quasi sicuramente non li avrei trovati va bene anche lasciarsi qualche zona inesplorata per un eventuale ritorno. Il santuario di Sumiyoshi non è proprio centralissimo e mentre aspettavo il treno per rincasare mi sono ritrovato a stupirmi del fatto che ci fosse solo una corsa ogni venti minuti, che per gli standard di Tokyo è impensabile. Ma veramente quando abitavo in Kansai ero abituato a questi tempi d'attesa? Sarà che venendo da un paesino dove c'è un treno all'ora (sempre che non lo cancellino) l'offerta mi sembrava già quintuplicata, per cui probabilmente all'epoca mi pareva comunque un enorme miglioramento lol
L'indomani, approfittando del bel tempo, decido di svegliarmi di buon mattino per affrontare il viaggio di due ore e mezza che mi separa da Ise, una città il cui rinomato santuario ho già visitato nel mio primo soggiorno in Giappone ma che lungo la costa ha ancora un'attrazione in serbo per me: i Meotoiwa, gli scogli marito e moglie. Fallisco nel mio tentativo di alzarmi alle sette per prendere il treno delle otto e sono un'ora in ritardo sulla mia ideale (o meglio, idealistica) tabella di marcia, ma nonostante questo alle undici e mezza riesco a raggiungere la stazione di Futaminoura, la più vicina al lungomare. Non capisco esattamente dove ho sbagliato ma non trovo alcun tornello per passare la carta della metro e pagare la tratta né nella stazione di cambio a Ise, dove salgo direttamente su un macinino sgarrupato che barcollando mi porta fino a Futaminoura, né in quest'ultima stazione una volta sceso, per cui confuso ma felice decido di non approfondire e lasciare in sospeso i miei conti con le ferrovie del Kansai per il momento lol.
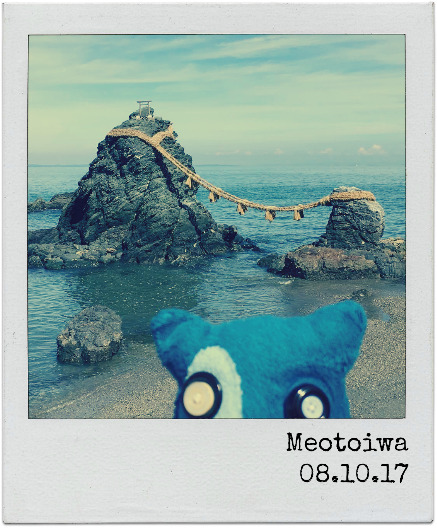
I Meotoiwa sono scogli sacri che nella tradizione scintoista rappresentano le due divinità progenitrici del Giappone, Izanami e Izanagi, unite da una fune sacra detta shimenawa lunga 35 metri, 16 dei quali sono avviluppati intorno allo scoglio maschile e 10 intorno a quello femminile, lasciando tra i due 9 metri di corda in paglia di riso. Lo scoglio marito è alto 9 metri e porta in cima un piccolo torii, mentre la moglie è alta 4 metri. Fenomenale sembra essere lo spettacolo del sole che sorge tra i due scogli, ma se non sono riuscito a svegliarmi alle sette figuriamoci se potevo mai essere lì all'alba. Tutt'intorno vi sono statue di rane, emissarie di Sarutahiko Ōmikami, divinità nel cui nome è presente il carattere di “scimmia” e che quindi avrebbe più senso che come emissari avesse delle scimmie ma fa niente, a cui è dedicato il vicino santuario di Futami Okitama, diviso in due edifici principali, il più importante proprio di fronte agli scogli, e uno più piccolo detto Ryūgūsha (龍宮社, “santuario del palazzo del drago”) dedicato a Watatsumi, divinità marina dalle sembianze di drago figlia di Izanami e Izanagi.
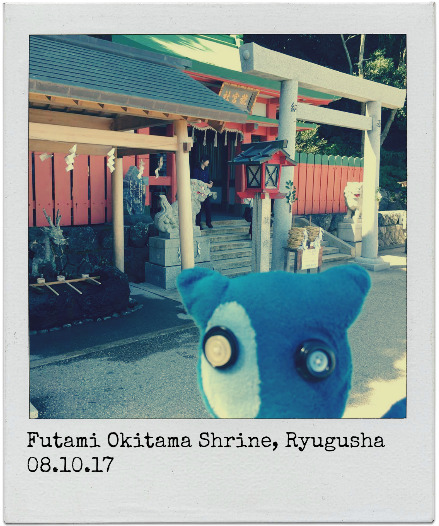
Avrei voluto fare una foto anche al padiglione più grande, ma non riuscivo più a rimanere in quel luogo impregnato di maschilismo ed eteronormatività, quel povero scoglio femmina non ha bisogno di un marito per essere completa!


Tra moglie e marito non mettere il dito, dicevano, e invece io sfrontatissimo.
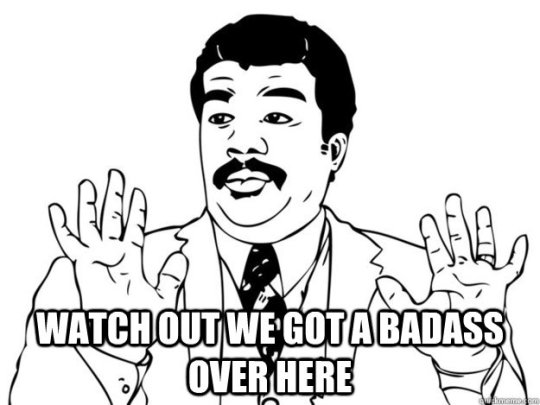
Tornato sui miei passi, salgo di nuovo sul trenino scassato che dovrebbe portarmi alla stazione di Ise, da cui si prende il treno che porta poi fino a Ōsaka. Questa volta mi accorgo che a bordo c’è un distributore automatico che dispensa il biglietto che poi andrà pagato direttamente in contanti alla stazione di cambio, e la cosa in effetti mi pare pure avere un senso - ma c’era anche nel treno che ho preso all’andata? Non che sia una garanzia, ma io non mi ero mica accorto. Scendo a Ise, pago la tratta allo sportello della linea locale e tecnicamente dovrei usare la carta per rientrare dai tornelli, ma siccome ufficialmente da quei tornelli non sono mai uscito e ancora il conto del viaggio dell’andata non risulta saldato, ovviamente appena ci provo il lettore magnetico mi dà errore e parte a sirene spiegate l’allarme che urla al ladro. Mostro la carta all’addetto della linea locale che mi dice di andare a parlare con il suo collega della linea che devo prendere per raggiungere Ōsaka, che molto convenientemente lavora in uno sportello che è da tutt’altra parte e dove devo rifare la fila da capo. Spiego la situazione giustificandomi col fatto che all’andata non mi sono imbattuto in alcun tornello e in alcun biglietto sul trenino malconcio diretto a Futaminoura, ma far capire la dinamica al tizio richiede una cosa come un quarto d’ora perché non si capacita che io possa essere riuscito a scappare ai miei debiti con le ferrovie dello stato e alla giustizia, per cui mi chiede conferma dei miei movimenti sette volte prima di prendere atto e accettare che ci sia effettivamente una falla in Matrix. La conclusione è che devo usare la carta per uscire intanto dai tornelli così la tratta principale dell’andata risulterà saldata e poi chiedere al suo collega della linea locale, quello con cui ho parlato prima, di farmi pagare il pezzettino che manca fino a Futaminoura e che non ho potuto pagare perché non ho preso il biglietto. Chiedo se non posso pagare direttamente a lui perché non vorrei fare di nuovo la fila, ma a quanto pare non è un’opzione.

Siccome nel frattempo con sta storia mi hanno pure fatto perdere la coincidenza e davvero non ho intenzione di rispiegare tutto daccapo al collega del tizio, decido che anche senza i miei 210 yen le ferrovie giapponesi non falliranno e che invece sfrutterò l’ora che mi resta da aspettare per tornare a visitare dopo 4 anni l’Ise Jingū.
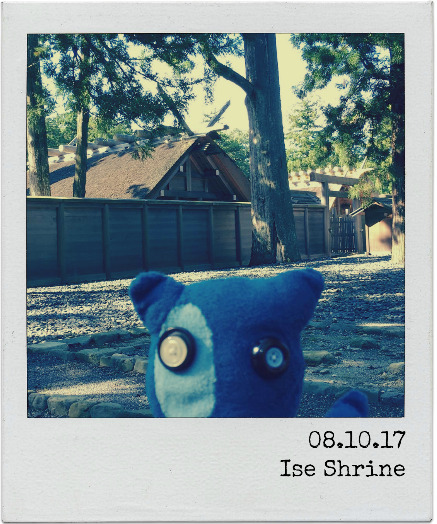
Questo santuario, uno dei più importanti per lo scintoismo, è dedicato ad Amaterasu, la dea del Sole, nata dall’occhio sinistro di Izanagi (il cui scoglio sono appena andato a visitare, daddy says hi!) quando questi si purificò nelle acque di un fiume dopo essere disceso negli Inferi per cercare di riportare indietro la sposa defunta, secondo una dinamica molto simile a quella del mito di Orfeo ed Euridice. Purtroppo per questioni di tempo (non vorrei perdere pure il treno successivo per Ōsaka) riesco solo a rivisitare velocemente parte del Santuario Esterno (外宮, Gekū), dedicato a Toyouke-no-Ōmikami, divinità del cibo, delle vesti e della casa, ancella di Amaterasu a cui porta il riso che i sacerdoti le offrono. Per il Santuario Interno (内宮, Naikū), dove la divinità del Sole è venerata ed è custodito il sacro specchio che fa parte delle tre insegne imperiali del Giappone, dovrò aspettare il prossimo viaggio a Ise temo. Potervi tornare anche solo brevemente, però, è stato bellissimo, soprattutto dopo la visione del documentario “Umi Yama Aida - Ise Jingu no Mori kara Hibiku Message” (うみやまあひだ ~伊勢神宮の森から響くメッセージ~, “Tra mare e montagna - Un messaggio che risuona dalla foresta del Santuario di Ise”), ambientato proprio qui e riguardante la pratica del tokowaka 常若, l’“eterna giovinezza” che contraddistingue questo luogo che ogni vent’anni viene ricostruito esattamente come prima, com’era successo nel 2013 quando per la prima volta vi ho messo piede. Ritrovarlo quattro anni più invecchiato e pensare a quante cose siano profondamente cambiate in questo breve arco di tempo è stato, devo ammettere, emozionante.
L’indomani ho in progetto di rivedere il basco dopo credo quasi un anno, non prima di un fallimentare tentativo di pranzare al café Pennennenemu, che mi interessa per un puro riferimento letterario visto che è citato in una canzone di una delle mie band preferite ma che, nonostante abbia casualmente scoperto essere ragionevolmente vicino, essendo piccolino ha un sistema abbastanza fastidioso per regolare il flusso della clientela: occorre accaparrarsi un biglietto la mattina entro le nove e mezza in modo da venire assegnati a una fascia oraria, per cui nel senso ciao ciao Pennennenemu, machittesencula tra l’altro, non posso credere che davvero ci siano talmente tanti avventori da permetterti di tirartela in questo modo.

『「死者に口なし生者に耳なし」ペンネンネネムは言った』 “Il Pennennenemu lo diceva che i morti non parlano e i vivi non sentono” Ecco Pennennenemu, senti amme, va’ a mori’ ammazzato va’.
Ritrovare il basco è stato come andare a una pizza dei vecchi compagni di classe: avevo proprio bisogno di farci una chiacchierata come si deve e aggiornarci su quello che è successo alle nostre vite mentre lui era a Ōsaka e io a Tokyo. Tra l’altro le nostre situazioni post periodo di studi a Kyōto neanche a farlo apposta hanno finito per avere svariati punti in comune, e poterne discutere con qualcuno che sa cosa signfichi perché ci è passato è stato impagabile. Il tutto mentre ci dedicavamo a uno dei nostri passatempi preferiti già ai tempi di Kyōto: scoprire improbabili posti nascosti nella città, in questo caso il tempio degli inferi, il Senkōji (全興寺).
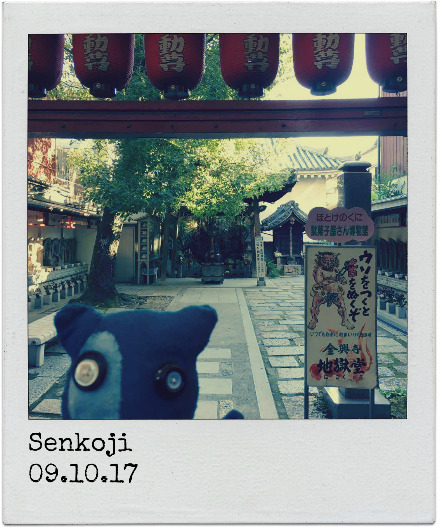
Questo bizzarro tempio, sperduto a sud di Ōsaka e soprannominato “Disneyland dei templi”, sorge dove lo volle più di 1300 anni fa Shōtoku Taishi, mitico principe ereditario che in periodo Asuka fu uno dei più fervidi promotori del buddhismo. Originariamente dedicato a Yakushi Nyorai, il buddha della medicina, oggi chi lo visita è probabilmente più interessato al Jigokudō (地獄堂, ‘Sala Infernale’) e allo Hotoke no Kuni (ほとけのくに, ‘Terra di Buddha’).

Scendendo dei gradini in pietra si accede a una cava sotterranea, lo Hotoke no Kuni appunto, dove, circondati da 151 statue di Buddha, è possibile meditare al centro della stanza sopra un mandala in vetro colorato uscito direttamente dall’intro de “La Bella e la Bestia”, abbastanza kitsch devo dire.
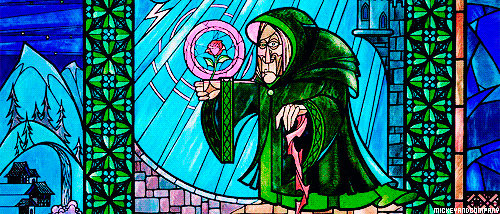
Nel frattempo, tutt’intorno si ode il suono di un suikinkutsu (水琴窟) strumento/ornamento della cui esistenza avevo sentito per la prima volta curiosamente proprio dal basco. Vedi come tutto torna, mica come l’acqua del suikinkutsu che scorre incessante ma non è mai la stessa.
Poco distante, in un altro padiglione, ci imbattiamo in un Buddha recumbente (涅槃仏, nehanbutsu) che galleggia in una specie di piscina e che ci turba per il suo astrattismo che lo fa somigliare più che altro al bozzolo di una crisalide.

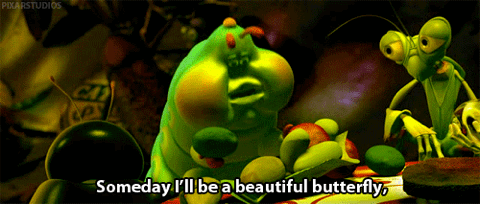
A Buddharfly!
A pochi passi, infine, il Jigokudō custodisce un altare dedicato a Enma, il giudice infernale, affiancato da figure di orchi e demoni, con tanto di filmato illustrativo delle torture inflitte ai dannati nell’oltretomba proiettato sul Jōhari no Kagami (浄玻璃の鏡), lo specchio che mostra le buone e le cattive azioni dei defunti quando Enma deve decidere della loro sorte nell’aldilà. Se non volete aspettare così tanto per sapere che fine farete, comunque, non c’è problema: fuori dal padiglione una praticissima macchinetta automatica a pulsanti vi indirizzerà con una serie di domande mirate verso il responso che più si confà alla vostra condotta, e i test del Cioè muti proprio.
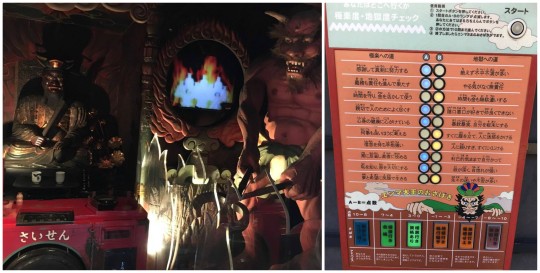
Vabbè che le autocertificazioni vanno sempre prese con le pinze, ma il mio risultato è stato “極楽行き資格あり”, cioè “idoneo per il Paradiso”. Ma, come recita la saggia macchinetta, non mi devo adagiare sugli allori perché è un attimo perdere tutte le credenziali.
Lasciatici alle spalle il Senkōji, il basco mi guida per le strade di Ōsaka, e si vede da come si muove che ci abita ormai da un po’. Se alcune zone mi risvegliano nostalgici ricordi del mio primissimo soggiorno in Giappone, quando studiavo nella periferia osakese e ogni tanto mi concedevo il lusso di esplorare la città, altre sono una meravigliosa scoperta, come i loschi bar e café di Umeda così infrattati da chiedersi se la gente che ci lavora faccia affari a sufficienza per poterne effettivamente campare. In uno di questi, assolutamente a caso, incontreremo due vinicoltori italiani con la passione per il surf venuti in Giappone a promuovere il loro vino, che rivedrò poi a Tokyo alla serata di presentazione a cui mi invitano calorosamente a partecipare. E boh, se da un lato è vero che questi incontri fortuiti erano all’ordine del giorno quando andavo in giro con il basco, che secondo me c’ha la calamita per queste situazioni, dall’altro comunque mi viene da pensare che certe cose (e con questo includo anche il gestore del locale giapponese ma con la passione per l’opera italiana che si esibisce per noi proponendo i pezzi forti del suo repertorio) succedono solo in Kansai, dove la gente sembra essere un po’ più accogliente e caciarona.
Ultima menzione di questo breve ma denso viaggio in Kansai va a Sasayama, quieta località di campagna a un’ora e mezza da Ōsaka, teatro dell’evento che mi ha portato in questa parte dello Honshū in quest’occasione, di cui quasi sicuramente non avrei mai sospettato l’esistenza e di cui invece ora so che è famosa per i suoi fagioli neri e per il castello che Tokugawa Ieyasu, il terzo dei grandi unificatori del Giappone, vi fece edificare nel 1609 e che i bombardamenti statunitensi distrussero durante la Seconda Guerra Mondiale. Menzione d’onore alla guida turistica che ci ha accompagnati soprattutto, un vecchietto giapponese che si era preparato un discorso in un inglese decoroso ma che ad ogni domanda rispondeva “Yes” così, proprio per partito preso, uno “yes” aperto alla vita, come quello di Molly nell’Ulisse di Joyce direi.
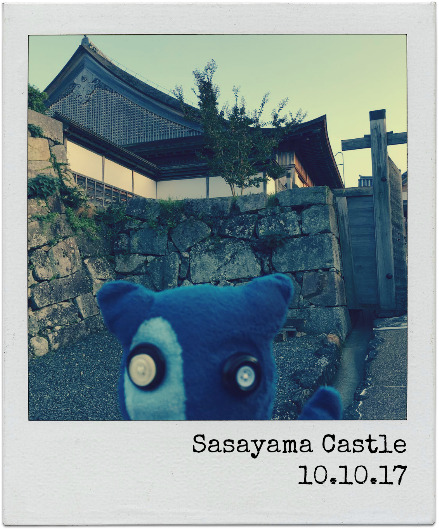
L’edificio principale, chiamato Ōshoin (大書院), venne ricostruito nel 2000 sulla base di testimonianze fotografiche, mentre di altre zone non restano che vestigia, come gli ambienti dove dovevano risiedere i samurai qui di stanza e di cui rimane solo la pianta tracciata in bianco sullo spiazzo antistante l’Ōshoin. Beh, in tutta Sasayama credo ci sia solo questo da visitare e noi siamo riusciti ad andarci nell’unico giorno di chiusura di tutta la settimana. Seems legit.

Nel vicino santuario di Aoyama (青山神社), eretto nel 1882, sono venerati nella loro forma deificata Tadatoshi e Tadayasu Aoyama, due signori feudali.
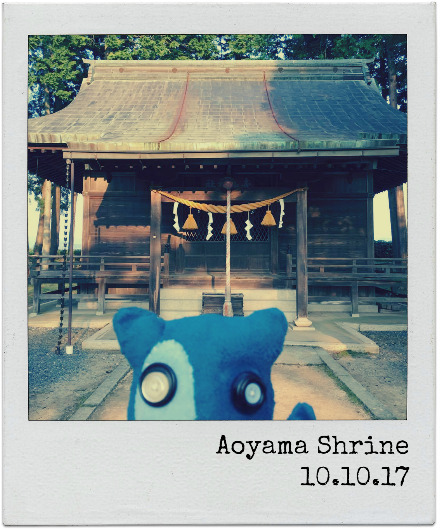
Anche se per pochi giorni, credo che prendere una pausa da Tokyo e godermi un po’ di Kansai non mi abbia fatto altro che bene. Mi rendo conto di ribadirlo ogni volta, ma è veramente una dimensione diversa da quella della capitale, come raccontavo a una delle partecipanti al nostro evento sul minivan che ci ha scarrozzati da Ōsaka a Sasayama e viceversa, che essendo lei stessa della zona si trovava assolutamente d’accordo e anzi non ha potuto che rafforzarmi in questa convinzione corroborandola di esempi provenienti dalle sue personali esperienze. Mi ha fatto anche molto piacere scoprire nuove facce di Ōsaka, una città che mi sono reso conto di conoscere in maniera estremamente superficiale, e che invece celava sorprese insospettabili (e di sicuro molte altre ne nasconde ancora).
Mentre finisco di scrivere questo post, a Tokyo infuria il tifone che da qualche giorno ci regala pioggia ininterrotta e vento, durante i quali poche altre opzioni oltre a piumone e riscaldamento a manetta mi sembrano poter rientrare tra i piani per il weekend. Ma, come dice Murakami in “La fine del mondo e il paese delle meraviglie”, “‘Quando verrà la primavera tutto sarà più facile. Se il mio cuore sopravviverà all'inverno, e se la mia ombra sarà fisicamente sopravvissuta, i miei sentimenti ritroveranno una certa chiarezza.’ Come aveva detto la mia ombra, dovevo essere più forte dell'inverno.”
1 note
·
View note
Text
Cose che mi disagiano a Ōshima
Me l'hanno annunciato le cicale di Yotsuya, di cui mi sono accorto con sorpresa e un po' di nostalgia nonostante avessi le cuffie mentre aspettavo nel piazzale davanti alla stazione: la stagione delle piogge è finita e l'estate giapponese, che nulla ha da invidiare a quella schifosamente umida e afosa padana (giusto forse i tombini di ghisa), ha ufficialmente raggiunto il punto in cui anche il più taccagno degli ambientalisti non può che arrendersi all'uso dell'aria condizionata se vuole sopravvivere.

Certo, se non me la sparassero a -50 gradi in treno tutte le mattine dopo che ho camminato sotto al sole per tutto il tragitto da casa alla stazione (che da solo basta comunque a trasformarmi in un Niagara di sudore) schivando le persone che intorno a me svengono per il caldo magari avrei fatto a meno di prendermi la broncotroncopolmonite a luglio, quando non ti aspetteresti di dover riesumare le medicine per il raffreddore che avevi usato d'inverno, ma insomma adesso non è che possiamo star qui a sindacare.
Per celebrare degnamente il weekend lungo di metà luglio (uno dei pochi del 2017, anno decisamente infausto per le vacanze perché molte feste nazionali cadono di sabato o di domenica) durante il quale si festeggia l'Umi no Hi (海の日, ‘giorno del mare’) mi sarebbe tanto piaciuto andare a Niijima, che saranno due anni che provo ad andarci, ma non siamo riusciti a trovare posto sul traghetto (che però D. ha prenotato senza problemi qualche settimana più tardi di quando avevo guardato io. Vabbè, vaffanculo). Dato che Niijima è solo una delle sette isole dell'arcipelago di Izu, abbiamo deciso di non scoraggiarci e di virare verso Ōshima, la più grande, che aveva ancora posti disponibili sul traghetto.
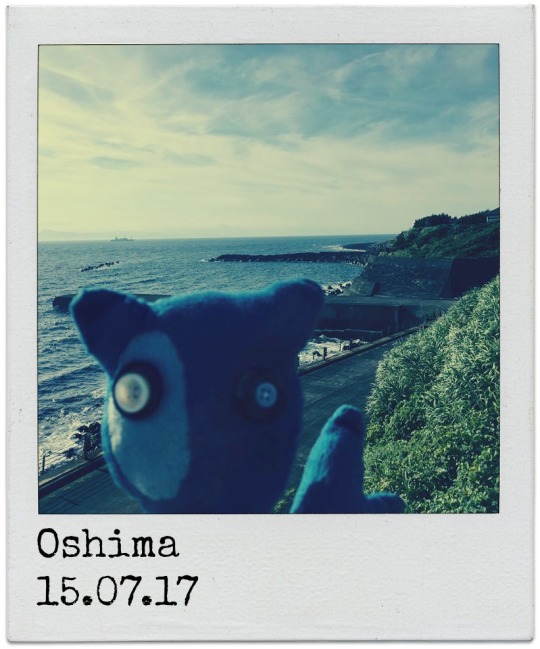
Trovare un alloggio si rivela comunque abbastanza complicato perché quasi tutti i posti che Google ci propone se hanno un sito per la prenotazione sono pieni, altrimenti vanno contattati per forza telefonicamente. Non una delle mie telefonate più brillanti visto che una delle prime domande che faccio è "giusto per sicurezza, c'è da pagare una penale per la cancellazione?" mettendo in allerta la padrona che ha già capito che degli stranieri non ci si può fidare, e a nulla vale assicurarle che mi porterò dietro anche un giapponese vero con cui eventualmente potrà prendersela. Il posto che faticosamente riusciamo a prenotare è un minshuku (民宿), cioè una locanda a gestione familiare in vecchio stile giapponese con i cuscini foderati di riso e pesce e nattō per colazione, che si trova pure in un'isola senza conbini che probabilmente ha saputo l'altroieri che è finita la guerra, quindi non c'è da stupirsi che ci sia un solo bagno per venti ospiti (o meglio, ci sono vari cessi e lavandini, ma una sola stanza con la doccia e la vasca da bagno, vasca da bagno che come nella migliore tradizione viene riempita una sola volta per tutti gli ospiti che dopo essersi lavati nelle doccia vi si possono immergere, facciamo che amo la cultura giapponese ma non tutta la loro coltura batterica, okay?), che la colazione venga servita alle sette e mezza e la cena alle sei e stacce, che il wi-fi non esista e che l'aria condizionata sia a gettoni (per fortuna il meccanismo con cui cercano di spillarti i soldi è abbastanza rudimentale e riusciamo quindi agilmente a sganciare la cassa che raccoglie le monete senza arrecare alcun danno e a riutilizzare sempre i soliti 100 yen). Y. dice che non è un problema insormontabile perché nelle vicinanze ci sono le terme e se non ci va di aspettare possiamo andare a lavarci là, però a parte il fatto che non ho capito perché dovrei pagare per farmi la doccia e soprattutto mi sfugge il senso di buttarsi nell'acqua calda quando fuori fanno 75 gradi all'ombra, devo confessare che ho un blocco psicologico enorme e la sola idea di essere nudo in mezzo a sconosciuti mi disagia a dei livelli inimmaginabili. Che poi i giapponesi sono quelli che tenersi per mano per strada è imbarazzante ma sguazzare nella stessa acqua tutti nudi appassionatamente con gente mai vista invece è normale, ma vi pare?
L'accoglienza è un po' freddina, ma noi ci vendichiamo scroccando aria condizionata e televisione via cavo - perdoname madre por mi vida ryokan. Ho l'impressione che la gente di Ōshima sia un po' diffidente nei confronti dei topi di città di Tokyo, che in un meccanismo centro-periferia degno di un romanzo di Ōe Kenzaburō li consideri con un misto di complesso di inferiorità e sufficienza, per la serie "forse era meglio se te ne stavi a Roppongi a sorseggiare la tua piñacolada invece di fare l'hippie e venire qui in villeggiatura, ma già che sei qui vediamo se riesco a guadagnarci due lire" (oltre alla padrona non troppo estroversa del minshuku, anche la signora del "café" dove ci fermiamo quando Y. le chiede il menù lo guarda bieca e lo canzona "qui non abbiamo menù, se ti va bene c'è caffè ma caffè americano, niente sofisticherie"). Mi viene quasi da pensare che per gli isolani i tokyoiti possano addirittura sembrare le cavallette di "A bug's life", che vengono, mangiano e se ne vanno.

Per fortuna io sono un topo di campagna ovunque in Giappone in quanto straniero e quindi la vecchietta del minshuku con me è pure gentile, mi spina il pesce con le proprie mani quando mi vede in difficoltà con le bacchette e al mio commento che in effetti con le mani si va di certo meglio mi percula sorniona con aria saputa: "tu soprattutto". Grazie nonna, lo so che sono un disastro con le bacchette, per cui immagino potrà passare per un incidente quando ti ci caverò un occhio.
Ōshima è un'isola vulcanica al largo della baia di Tokyo, della cui giurisdizione fa parte, ed è facilmente raggiungibile dal porto di Hamamatsuchō da cui partono imbarcazioni dirette a Motomachi e/o a Okata, i due porti rispettivamente a nord-ovest e a nord-est dell'isola. Prendiamoci per favore un minuto per riflettere su come il porto di Hamamatsuchō presenti una commistione di elementi che rimandano chiaramente a One Piece e a Spongebob.

Le due statue a destra in realtà sono moyai, riproduzioni dei più famosi moai dell’Isola di Pasqua realizzate a Niijima in riolite, una pietra vulcanica che si trova solo lì e a Lipari (lol). La parola ‘moyai’, scelta per l’assonanza con ‘moai’, ha anche la sfumatura di significato di ‘cooperare’, ‘lavorare insieme’ se scritta 催合い o 最合い, oltre che ‘attraccare’, ‘ormeggiare’ se scritta invece 舫. Si può trovare un altro esemplare di questi artifatti nel bel mezzo di Tokyo a Shibuya, poco distante dalla più famosa statua di Hachikō, e un altro anche a Bikini Bottom, ci abita Squiddi.

Avendo trovato posto sulla nave più veloce per il viaggio di andata, per la traversata impieghiamo soltanto circa due ore. Osservando distrattamente il panorama dall'oblò, noto che passiamo davanti a una strana installazione a forma di vela che mi ricorda quella della pubblicità della Q8 e che invece scopro con vergognosa sorpresa fungere da bocca di aerazione per l'Aqua-Line Baia di Tokyo, una galleria subacquea che passa sotto alla baia di Tokyo di cui non sospettavo minimamente l'esistenza.
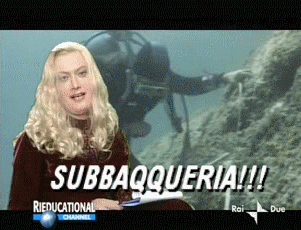
“Uno o più subbacqui!” [cit.] Il bello di essere ignoranti come lammerda è che il mondo è sempre così pieno di sorprese.
Il minshuku è vicinissimo al porto e di conseguenza anche al capolinea di praticamente tutti gli autobus che ci serviranno per girare l'isola. Non essendo rimasto molto tempo utile per il turismo, ci limitiamo a fare un giro di ispezione della costa vicino all'alloggio e già mi comincia a salire lo sconforto perché di spiagge balneabili non sembra esserci traccia, solo terrazzamenti di cemento digradanti verso un bel pot-pourri di scogli e rifiuti sospinti a riva dalla marea. Se li riportasse via come la marea la felicità almeno, ma mi sa che di gioie non ne vedremo. Allora però avevo ancora la speranza che fosse così solo la zona portuale e che invece la spiaggia dove avevamo in progetto di andare l'indomani fosse effettivamente la figata che promettevano nella guida. Che carino che ero, così giovane e inesperto.
Il giorno dopo comunque il piano prevede di ascendere al Miharayama, il vulcano attivo al centro dell'isola.
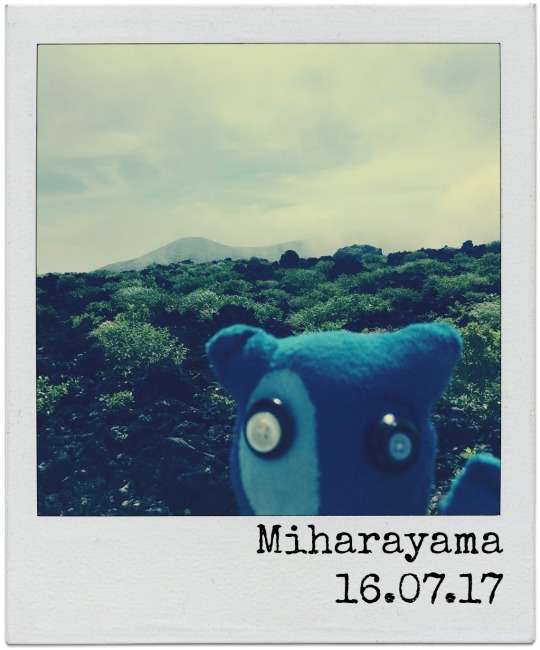
Un autobus ci porta fino alle pendici dove veniamo accolti da un paesaggio a dire poco surreale: il monte è completamente avvolto e celato da una fitta coltre di nubi che lasciano giusto intravedere la strada che presumiamo porti alla cima.

© Photos by Y.S.

Non siamo certi di dove stiamo andando ma i cartelli indicano che abbiamo imboccato il percorso giusto quindi non ci resta che fidarci e procedere. Il panorama intorno a noi è un susseguirsi di rocce vulcaniche in apparenza massicce ma dalla consistenza friabile e di arbusti verdi rigogliosi e talvolta persino fioriti. Su alcuni crescono anche delle more con le quali attento alla mia salute fallendo però nel mio tentativo di avvelenarmi.

Hey, però guardate qua, in Giappone pure i vulcani sono attrezzati con le prese della corrente per ricaricare i telefoni! Privatizzerò questo servizio e ne farò un business sotto il marchio di KaZanNa. (Sì, okay, non è una presa per la corrente, è una presa per il...).
La situazione inizia a farsi finalmente più chiara quando arriviamo al Mihara-jinja, un santuario in prossimità del cratere centrale, che un cartello ci assicura dovrebbe incorniciare uno spettacolare scorcio della valle ma che le nuvole purtroppo ci impediscono di ammirare.
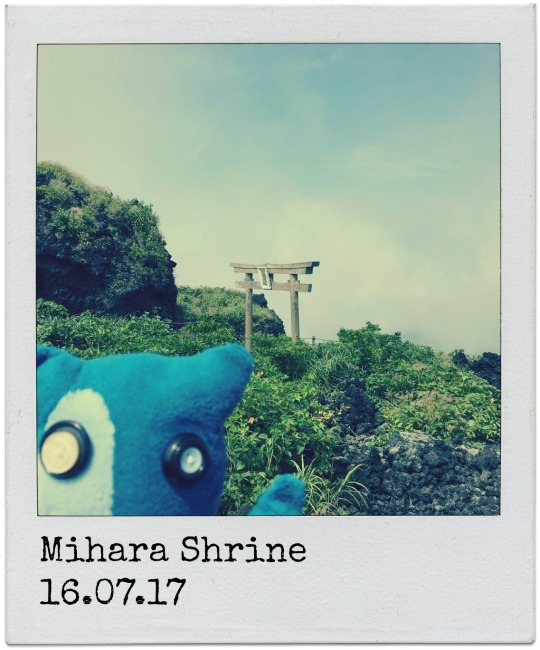
Il vento ha già cominciato a tirare fortissimo e durante l'ultimo tratto intorno al cratere è destinato solo ad aumentare. Mi sento un piccolo hobbit che scala il monte Fato mentre mi inerpico lungo la salita che ci condurrà in bocca al cratere, mentre nuvoloni di vapore acqueo provenienti dal vulcano ci spirano addosso trasportati dal vento a una tale velocità che non si riesce a sentire nient'altro, a parte del sano J-Pop ignorante sparato a palla che un gruppo di giapponesi tamarri ha giustamente deciso di portarsi dietro in un posto del genere. Da Suma a Ōshima, i tamarri sono proprio ovunque eh.
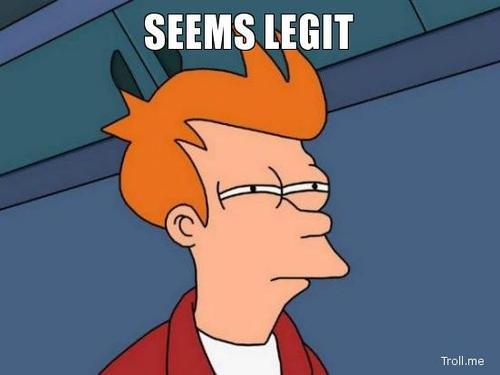
Mentre giriamo intorno al cratere del vulcano mi sento vagamente nell'episodio "Il Demone che piange" del film 'Sogni' di Akira Kurosawa, con la sua scenografia post-nucleare in cui una natura geneticamente mutata si riprende il proprio spazio in un brullo panorama post-apocalittico, e per quanto sia affascinante scoprire qua e là cespugli fioriti con prepotenza tra le pietre laviche, quasi ginestre di leopardiana memoria, fino a che non ci si para nuovamente davanti agli occhi il torii del Mihara-jinja ci è impossibile orientarci (cosa per me difficile già in condizioni normali lol) e capire a che punto della nostra circumnavigazione siamo.

Questo girare intorno potenzialmente infinito e indefinito, immersi nelle nuvole di vapore acqueo senza punti di riferimento e con il vento che si abbatte e infierisce da tutte le direzioni, mi fa quasi pensare a come potrebbe essere un limbo infernale, magari proprio quello dove verrò condannato lol
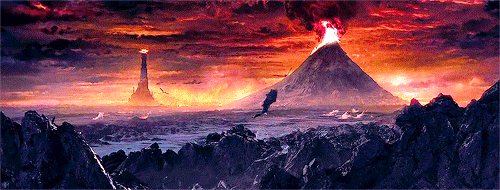
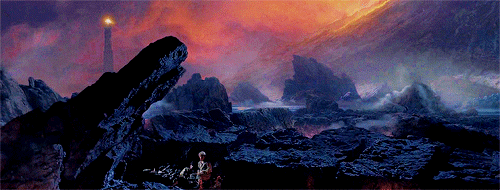
Dopo questa affascinante esperienza di pre-morte e dopo esserci rifocillati nell'unico baracchino che ci sembri vendere del cibo nei dintorni, il piano prevederebbe di fare finalmente un bagno nella fantasmagorica, rinomatissima e incantevole zona di Tōshiki, sulla scogliera a sud-est dell'isola, pubblicizzata con fierezza ed entusiasmo in tutti i depliant che la dipingono come una perla caraibica che la Barriera Corallina in confronto pare un immondezzaio.
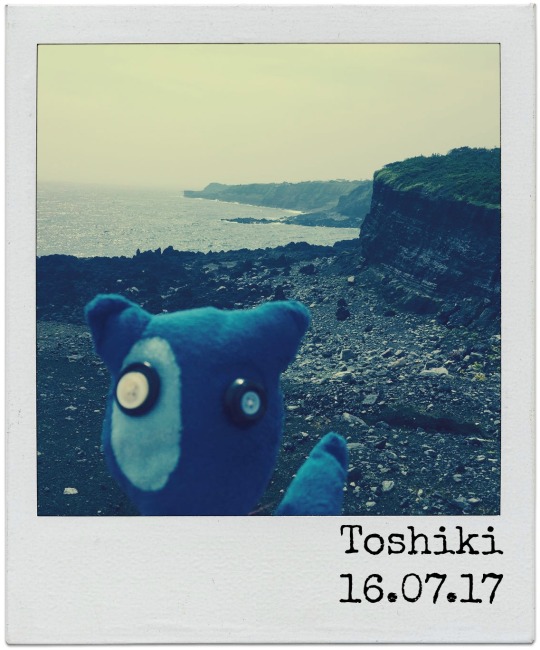
Per raggiungerla dobbiamo tornare al capolinea degli autobus al porto di Motomachi, cambiare e camminare per almeno venti minuti buoni fino alla caletta racchiusa tra le falesie, ma quel che ci troviamo davanti dopo tutta sta fatica è un pisciatoio che va da qui a lì delimitato da scogli in tutte le direzioni, l'acqua sporca e bassissima ma probabilmente per colpa del principio di Archimede che deve averla fatta traboccare visto che in ammollo vi sono già almeno una cinquantina di persone, metà delle quali bambini che quindi probabilmente rendono il mio paragone col pisciatoio quantomai calzante. La delusione è alle stelle soprattutto perché visto che sono le quattro e considerati i pochi autobus a disposizione non faremo in tempo a tornare indietro e andare in un'altra spiaggia se dobbiamo cenare alle sei. Ma anche volendo, l'unica altra spiaggia a portata di mano aprirà lo stabilimento balneare con docce e quant'altro solo a fine luglio (no ma adesso dico, in sta stracazzo di isola demmerda la gente viene solo sti tre giorni, qualcuno mi spiega per quale motivo apparente dovreste tenere chiuso? Seriamente?), e proprio per questo motivo è escluso che potremo fare il bagno l'indomani prima di partire a meno che non vogliamo farci tutto il viaggio di ritorno insalsedinati. Quindi INDOVINATE CHI non ha fatto il bagno a Ōshima in tre giorni nonostante fosse l'unico scopo che lo aveva spinto a metterci piede? Anyone?

Dopo un fallimentare ultimo tentativo di tirarci su il morale nel café di cui vi parlavo all’inizio, dove hanno solo caffé nero e anche quello è acqua sporca ma mi costa comunque come un caramel frappuccino con latte di soia da Starbucks, non ci resta che arrenderci e tornare nella nostra prigione per cena. Siccome vorrei in questi tre giorni dire di essermi immerso nell’acqua almeno una volta, almeno dieci minuti, decido di seguire Y. alle terme perché nello stesso stabilimento c’è anche una piscina e a parer suo ci saranno di conseguenza pure le docce. Beh, le docce ci sono, ma sono semplici spruzzini pendenti dal soffitto nel corridoio che precede l’entrata alla vasca, quindi non esattamente studiate per lavarsi, e come se non bastasse mentre le terme tengono aperto fino alle nove, la piscina chiude alle otto e mezzo così, a cazzo, solo perché la volevo usare io immagino, quindi essendo arrivati alle otto mi rimane poco meno di mezz’ora per nuotare. Dopo qualche vasca decido che mi sono reso sufficientemente ridicolo e, tornato in spogliatoio, non mi resta che scendere a patti con il mio senso di colpa cristiano che mi impedirebbe per pudore di denudarmi in pubblico e arrendermi ai barbari costumi del luogo visto che, se anche tornassi all’alloggio, sarebbero sicuramente passate le nove e non ci sarebbe modo di farsi la doccia.
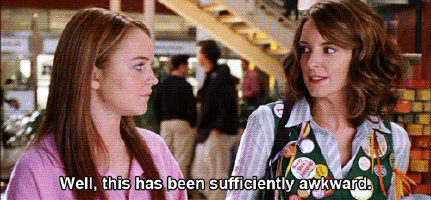
L’indomani, nelle poche ore che ci separano dal ritorno alla civiltà, Ōshima riesce quasi a darmi una mezza gioia. Dopo esserci fatti venire il nervoso guardando la gente che fa il bagno e si diverte nella vicina spiaggia di Kōbōhama, che se avessimo scelto invece di Tōshiki il giorno prima forse sarebbe stato meglio, decidiamo di visitare da ultimo il Villaggio delle Danzatrici (踊り子の里, ‘Odoriko no Sato’), all’estremità sud-est dell’isola, nella zona di Habu.
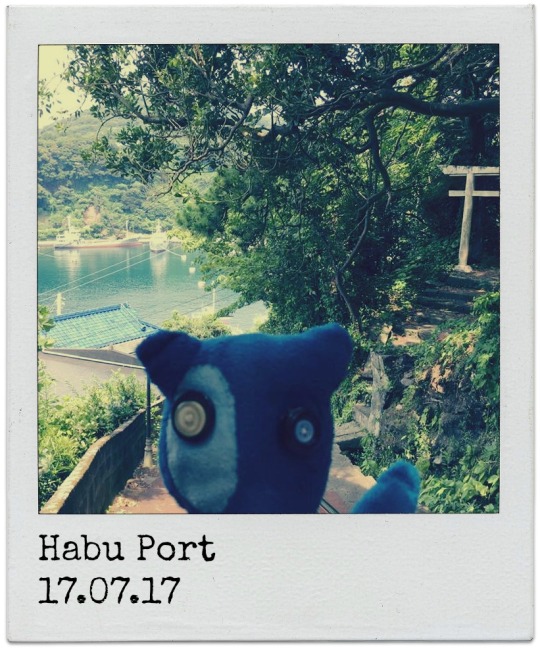
Il porto di Habu ha una storia particolare perché si è venuto a creare quando nel 1703 un violento terremoto e il rovinoso tsunami che ne seguì collegarono un preesistente lago vulcanico al mare. Fu però Heiroku Akihiro a mettere mano al disastro nel 1790 e a farlo diventare un fiorente scalo commerciale. Molti scrittori, Hayashi Fumiko per citare solo la più famosa (o meglio, l’unica che mi dicesse qualcosa (つД`) ) si recarono qui in visita tra il periodo Meiji e il periodo Shōwa, e lo stesso Kawabata Yasunari si ispirò a questo villaggio di pescatori per il racconto breve che lo consacrò nel panorama letterario, “La danzatrice di Izu” (伊豆の踊り子, “Izu no Odoriko”), storia d’amore impossibile e non consumato tra uno studente e una danzatrice in una compagnia di girovaghi originaria di Habu appunto.

“La compagnia era originaria del porto di Habu a Ōshima. Avevano lasciato l’isola in primavera ed ora stavano proseguendo il loro giro [...]. Ōshima rievocava in me pensieri poetici e intanto fissavo i bei capelli della danzatrice. Feci un mucchio di domande su Ōshima. «Gli studenti vengono qui a fare i bagni», precisò la danzatrice alla compagna. «Certo, in estate...» dissi io voltandomi indietro. La danzatrice era un po’ imbarazzata. «Anche in inverno...», mi sembrava che avesse risposto con una debole voce. «Anche in inverno?!». La danzatrice guardò la sua compagna e rise. «Si può nuotare anche in inverno?» chiesi di nuovo io. La danzatrice arrossì in volto e con aria volutamente seria annuì lievemente.” E invece no, stronza, manco in estate sono riuscito a fare il bagno in quest’isola demmerda.
In memoria di tutti gli scrittori che per un motivo o per l’altro hanno intrecciato il loro destino a questa zona di Ōshima, è stato istituito un percorso chiamato “Il sentiero della letteratura”, una strada costellata di lastre di marmo con incisi i loro nomi e passaggi delle loro opere, che si inerpica fino alla cima di un declivio dove si trovano altre vecchie case di pescatori che è possibile visitare e che sembrano sospese nel tempo, lasciate nel loro stato stato originario a testimonianza dei tempi che furono.
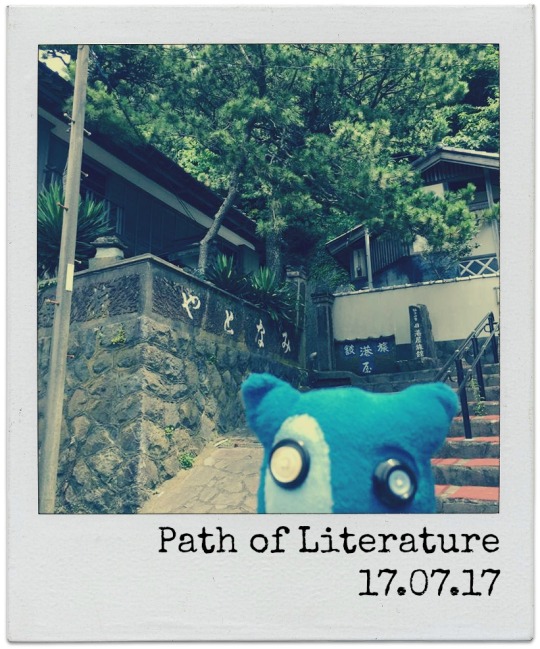
Insomma, Ōshima, io ci ho provato a rivalutarti, ma per quanto scalare il tuo vulcano sia stata un’esperienza indimenticabile e il villaggio di pescatori mi sia piaciuto, temo che dovrò arrendermi alla conclusione che forse sei un po’ troppo campagna persino per me. Mi dispiace perché del Giappone ho visitato e amato posti anche meno convenzionali delle grandi città, ma dopo tre giorni di “slow life” dai movimenti limitati dai pochi mezzi a disposizione e dai tempi scanditi da una quotidianità premoderna, senza manco essere riusciti a farsi un bagno in mare, avrei veramente voluto buttarmi giù da una delle tue scogliere e mi sa che ho iniziato a capire come doveva sentirsi Mitsuha in “Kimi no Na wa”.


1 note
·
View note
Text
Cose vecchie, cose nuove e scarpe buone per la Golden Week
Quando iniziate una conversazione con un giapponese nella sua lingua, in cuor vostro sapete già che, per quanto capre possiate essere, arriverà sempre il momento in cui il rappresentante di turno di questo popolo di falsi cortesi che manco i piemontesi si complimenterà con voi per la vostra bravura linguistica. 日本語お上手ですね。 E voi vi sarete magari semplicemente limitati a dire arigatò, ma con l'accento sulla o proprio eh. È un momento che vedrete proprio arrivare perché lo imparerete a leggere negli occhi del vostro interlocutore: il giapponese davanti a voi non ve lo vuole dire perché probabilmente non lo pensa, ma qualcosa, forse il fatto che ormai siete a corto di argomenti, lo spinge sconfortato a inscenare un teatrino il cui canovaccio risale probabilmente al periodo Edo quando i primi missionari portoghesi, un nome per tutti João Rodrigues, autore del Vocabvlario da Lingoa de Iapam, iniziarono a studiare il nipponico idioma e i daimyō locali cominciarono a lusingarli nella speranza di mettere le mani sugli archibugi portoghesi. Voi non ci crederete che state per fare tutta la sceneggiata, ma vi piegherete docilmente alle esigenze del copione: そんなことないですよ。 Un'altra domanda che immancabilmente seguirà riguarderà il motivo per il quale vi siate mai avventurati nell'irto sentiero dell'apprendimento di una lingua così complessa. Ebbene, il motivo per cui ho cominciato a studiarla è venuto finalmente a trovarmi in Giappone durante questa Golden Week.

Fruit ninja pronti per l'uscita del loro primo indie EP "You are the lemon of my eye and you are the kiwi of mine".
Sono sempre un po' in difficoltà quando devo rendere conto del perché mi sia messo a studiare il giapponese: di solito attacco con "quando ero alle medie una mia amica si era appassionata di manga e anime e aveva cominciato a studiare giapponese per conto proprio, e siccome diceva che era interessante mi sono fatto prestare da lei il manualetto di grammatica e mi sono messo a studiarlo anch'io". Ma dalla domanda successiva, che di solito è "che manga leggevi?", capisco che immancabilmente l'interlocutore non mi è stato a sentire e ha arbitrariamente deciso di riassumere tutto in "ho iniziato a studiare giapponese perché mi piacevano i manga". Ma va bene lo stesso, tanto non mi sta mai a sentire nessuno.
Questa mia amica è F., vicentina come me, un anno più grande, giovane talento del design, residente da qualche anno in Inghilterra e presto consorte di T., un lord delle terre di Albione che più di lei ama solo i giochi di parole squallidi, e che quindi non poteva che starmi simpatico. Finalmente, dopo aver passato praticamente l'infanzia e l'adolescenza insieme ed esserci poi rincorsi nei nostri ritorni in Italia in seguito alle rispettive diaspore, siamo riusciti a incontrarci in Giappone, dove ho potuto infine farle vedere in che razza di casino mi ha cacciato. Non ci potevo credere che sarebbe finalmente venuta in visita finché non me la sono ritrovata davanti all'uscita nord della stazione di Nakano un giovedì sera, con valigione e fidanzato, entrambi enormi lol
Grazie ai giorni di vacanza della Golden Week siamo riusciti a non limitare la visita a Tokyo ma ad andare anche a Kyoto, che per chi vede il Giappone per la prima volta secondo me rimane una tappa imprescindibile. Memore del monito di madre che, dopo il tour de force a cui ho costretto lei e sister durante la loro permanenza a Kyoto, mi ha ricordato che devo morire e non far morire gli altri, avevo cercato di ridurre il programma e diluirlo meglio, e anche se si è comunque rivelato troppo ottimista, siamo riusciti a portare a casa quasi tutti i must-see lasciando qualcosa per la prossima volta. Personalmente poi sono riuscito anche a visitare qualche punto di interesse che ancora mi mancava, per cui, come ci è spesso capitato di esclamare durante questo viaggio dove si è parlato una specie di esperanto che mischiava goffamente italiano, inglese e giapponese, "it became study!"
A dire la verità anche posti visitati mille volte hanno rivelato qualche sorpresa: per esempio, mi era completamente sfuggito il pino a forma di barca nel giardino del Kinkakuji, un bonsai di circa 600 anni sfuggito un po' di mano ad Ashikaga Yoshimitsu e cresciuto a dismisura modellato in modo da sembrare una barca. O tipo il pozzo nel giardino del Ryōanji, sapevo che riprendesse una vecchia moneta e che i quattro caratteri incisi (吾唯足知) significassero una cosa tipo "imparo solo come essere soddisfatto", ma mi era sfuggito che fossero stati scelti in modo da venire completati dal quadrato al centro che così diventa non solo un buco ma anche parte del significato (sono infatti disposti in modo che il radicale 口 presente in tutti e quattro sia occupato dal foro del pozzo).

Foto di repertorio scattata nel lontano settembre 2014, sigh.
Menzione speciale al Kiyomizudera che, giusto per non interrompere la catena di sfighe che sempre devono infierire ogni volta che faccio del turismo, era in ristrutturazione pesante - giapponesi, avete una settimana di vacanza in tutto l’anno e riuscite a fare i lavori in uno dei templi più visitati di Kyoto proprio in quel periodo lì? Ma guardate che siete magici eh.

Però ecco diciamo che almeno questa volta sono riuscito ad arrivare anche dall’altra parte della collina dove sorge la pagoda che sembra alta se la vedi spiccare tra le fronde dal tempio, e invece quando ti avvicini è abbastanza miserella. La vista del tempio da lì ad ogni modo ci ha ripagati della camminata in salita, così come il profumo di fiori e di verzura da cui eravamo circondati e che mentre io ho commentato con: “What a pleasant scent of flowers...” F. ha prontamente ucciso con: “These flowers stink, I hate them so much."

Tra le new entry di questo viaggio, comunque, citerei il Konkai-Kōmyōji, tempio di scuola Jōdō che in periodo Edo fu residenza di Matsudaira Katamori, capo della Shinsengumi, il corpo di polizia dello shogunato Tokugawa che se non fosse per Gintama credo avrei completamente dimenticato (AAAH ALLORA LO VEDI CHE LI LEGGI I MANGHI, PERZONA FALZAAAAA!!!1!!111!!!!11!).
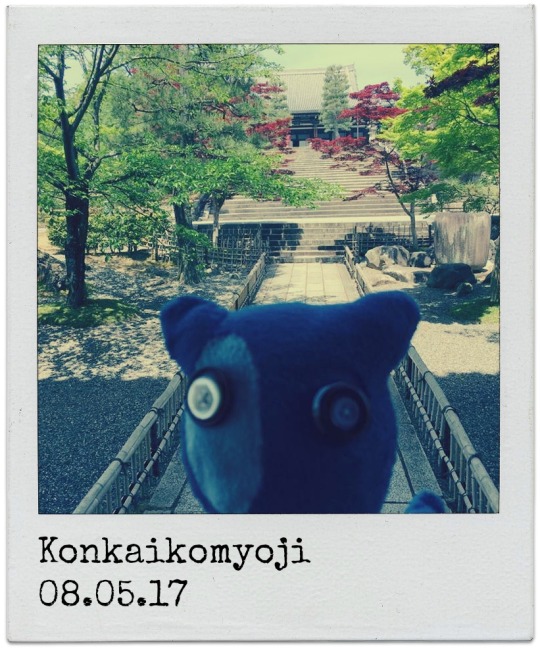
Il motivo che mi ha spinto a visitarlo però è stato piuttosto il fatto che tra le tombe nel suo precinto ospita una statua molto particolare, conosciuta dai kyotoiti come “Afro Buddha”. Si tratta in verità di una rappresentazione di Gogoh-shiyui-amida-butsu (五劫思惟阿弥陀仏, ‘il Buddha Amida in contemplazione per cinque kalpa’): si dice infatti che i capelli di Buddha crebbero a dismisura mentre egli era assorto in meditazione per cinque kalpa, un’unità di misura temporale infinita come l’eone, che può essere descritta come più lunga del tempo che occorre a una montagna per sparire se ogni cento anni la si strofina una volta con un pezzo di seta, o anche come il tempo che ci vuole per finire la Salerno-Reggio Calabria.
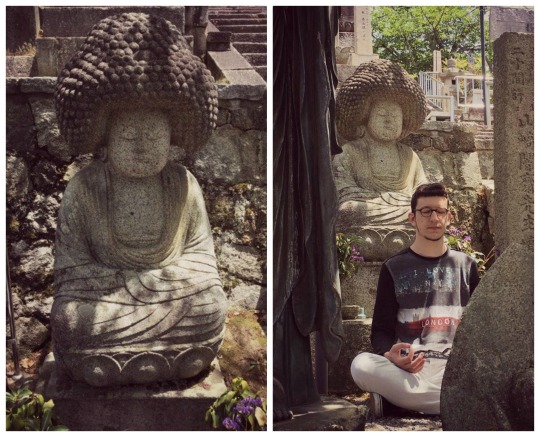

Altra piccola soddisfazione, ma per un motivo meramente metaletterario più che turistico, è stata riuscire ad andare a fare colazione allo Shinshindō 進々堂, un café dove si danno appuntamento i protagonisti dell’ultimo film di Yuasa Masaaki, “Yoru wa mijikashi, arukeyo otome” (「夜は短し、歩けよ乙女」“La notte è giovane fanciulla, cammina”).

Ora, lasciate che mi limiti ad aprire solo una piccolissima parentesi su quanto io stia in fissa con questo genio dell’animazione giapponese, di cui ho visionato tutte le visionarie opere su cui sia riuscito a mettere le mani. Tra tutte, ho particolarmente amato “The Tatami Galaxy”, deliziosa serie ispirata a un romanzo di Morimi Tomihiko regalatomi per i miei 23 anni dal basco e che ancora non ho letto adesso che vado per i 26, con l’inconfondibile character design di Yusuke Nakamura e contributi musicali degli Asian Kung-Fu Generation.
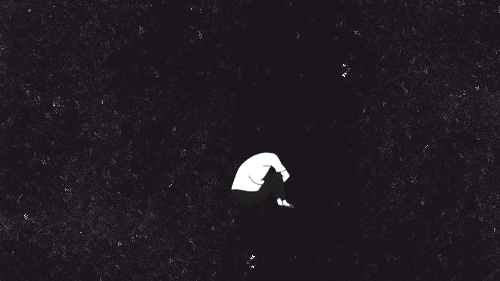
Quando quest’anno ho saputo che Yuasa avrebbe riportato sul grande schermo una nuova commistione di tutti questi elementi trasponendo un altro romanzo di Morimi mi sono straesaltato e sono corso al cinema appena ho potuto, ma evidentemente sono giunto a un’età in cui l’entusiasmo provoca sonnolenza perché credo di essermi abbioccato in diverse parti abbastanza cruciali dato che, per quanto il nonsense sia una delle cifre che caratteristicano le opere di questo autore, quando cerco di ricordare il contenuto del film ho dei buchi di trama abbastanza importanti. Questo non mi ha comunque impedito di fangirlare tantissimo e di innamorarmi perdutamente della canzone dei titoli di coda.

「あの娘がスケートボード蹴って表通り飛ばす ♪」

Beh insomma tutto molto bello, soprattutto perché i romanzi di Morimi sono spesso ambientati a Kyoto e quindi l’idea di vivere la città come se fosse un suo romanzo mi affascinava molto. Peccato solo che boh, non è che si mangi poi nulla di speciale in sto Shinshindō, e le tavolate coi banconi bassi non erano proprio quello che mi aspettavo dopo aver visto l’interno del locale nel film. Però insomma vabbè, uno si fa la foto ricordo e si porta a casa la lezione che se han tirato su la quarta parete ci sarà un motivo e si ricorda che non bisognerebbe mai buttarla giù.
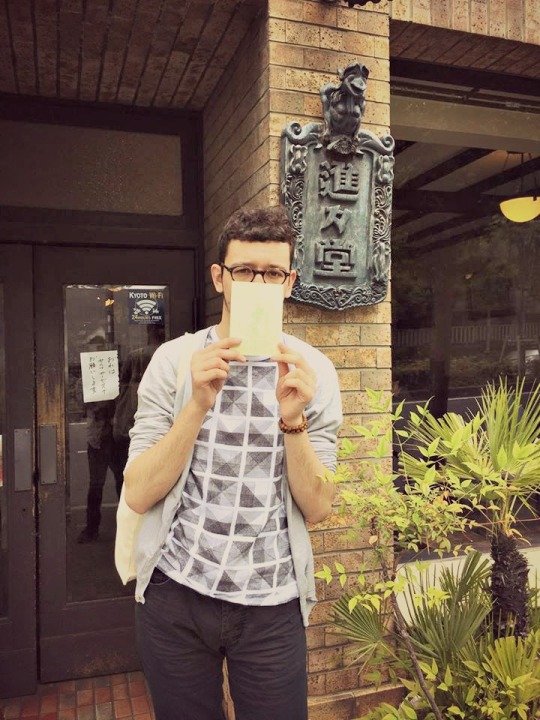
Tappa che mi sono reso conto di non essermi quasi mai fatto mancare quando sono nei dintorni di Kyoto, anche Uji, la città che profuma di matcha, ha rivelato delle sorprese. Innanzitutto il giardino del Byōdōin con i suoi tralicci di glicine, fiore che in giapponese si chiama fuji 藤, quindi immaginate se potevo risparmiarmi i miei soliti giochi di parole demmerda con un simile potenziale tra le mani.

(F)Uji!
Tra l’altro, se in inglese la più bella combinazione di parole è “cellar door”, credo che in italiano la migliore sia probabilmente proprio “tralicci di glicine”.
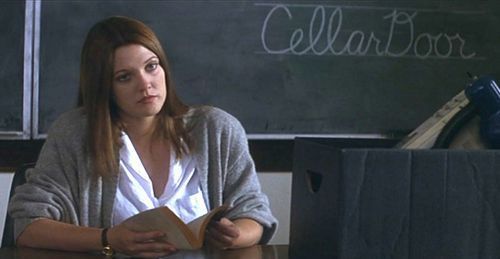
“This famous linguist once said that of all the phrases in the English language, of all the endless combinations of words in all history, ‘cellar door’ is the most beautiful.”
Nonostante fosse la mia quarta volta a Uji, anche in questo caso sono stato contento di riuscire a vedere comunque qualcosa di nuovo: l’Ujigami-jinja, altro patrimonio UNESCO come praticamente tre quarti di Kyoto e dintorni, che credevo di aver visitato ma che in realtà avevo confuso con l’Uji-jinja durante la mia prima gita a Uji. La storia dei due santuari dai nomi così simili è un po’ complessa e si può riassumere così: fino al 1868, l’Ujigami-jinja era parte dell’Uji-jinja e i due santuari erano conosciuti rispettivamente come Rikyu-kami e Rikyu-shimo. Dei due, l’Ujigami-jinja è il più antico e anzi si ritiene sia addirittura il più antico santuario ancora esistente di tutto il Giappone. Considerato una sorta di guardiano del vicino Byōdōin, è dedicato alle tre figure storico-leggendarie di Uji-no-Waki-Iratsuko, a suo padre, l’Imperatore Ojin, e a suo fratello maggiore, l’Imperatore Nintoku. Vi sono varie versioni circa l’avvicendamento dinastico, ma secondo le cronache riportate dal Nihonshoki, Ojin avrebbe voluto che fosse Uji-no-Waki-Iratsuko a succedergli, ma egli si suicidò per permettere a Nintoku di prendere il potere perché lo riteneva più adatto e perché trovava sconveniente che un primogenito finisse agli ordini del fratello minore. Se la regia mi fa partire la sigla di Biujiful, grazie.
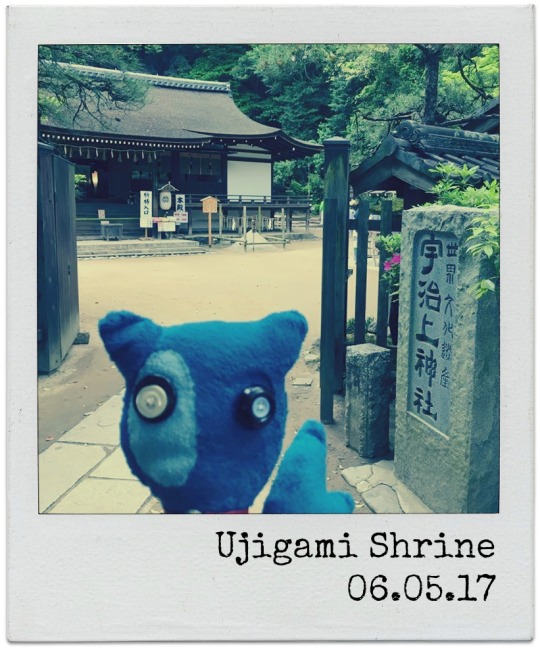
Già che ci eravamo spinti leggermente oltre Kyoto andando a Uji, il giorno dopo abbiamo deciso di andarcene ancora più fuori dalle balle e ci siamo detti: sai che c’è? C’è che prendiamo un treno speciale (nel senso di costosissimo e con lo stesso tempo di percorrenza che lo Shinkansen impiega per andare da Tokyo a Kyoto) che va ad Amanohashidate, il Ponte per il Paradiso, Paradiso città.
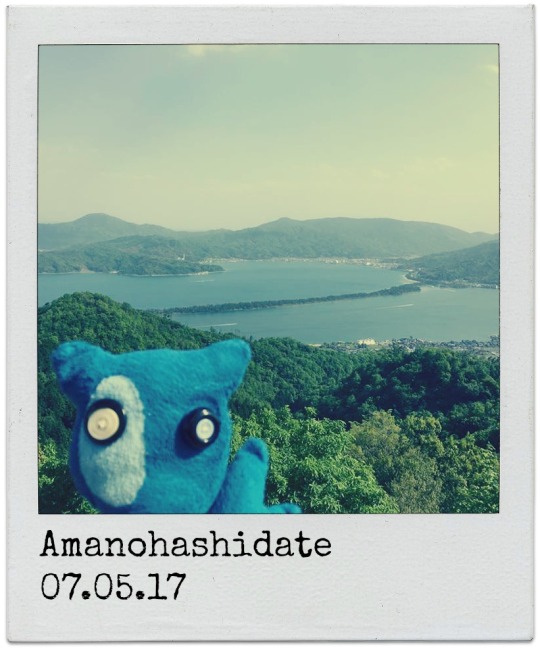
Amanohashidate è un istmo di sabbia ricoperto di alberi che si estende per quasi tre chilometri e mezzo lungo la baia di Miyazu, a nordissimo di Kyoto, ed è considerato a pieno diritto uno dei tre panorami più suggestivi del Giappone (gli altri due sono Miyajima con il suo torii galleggiante e Matsushima con le sue isole di pini, l’ultimo che mi manca, ma non preoccupatevi, gotta catch ‘em all!). La leggenda vuole che Izanagi, divinità maschile primigenia della mitologia giapponese, usasse una scala per scendere dal cielo alla terra dove risiedeva la sua amata Izanami. Un giorno, addormentatosi, dimenticò di ritornare in cielo prima che calasse la notte e la scala cadde, formando l’istmo che oggi vediamo. Sarebbe proprio qui, tra l’altro, che le due divinità avrebbero dato vita alle terre emerse che poi avrebbero costituito il Giappone.

Le tre vedute del Giappone (日本三景, Nihon Sankei) secondo Utagawa Hiroshige.
Una volta arrivati ad Amanohashidate, noleggiamo le biciclette per percorrere l’istmo e ci inoltriamo nella pineta che profuma di salmastro, immersi nello spirto silvestre, d'arborea vita viventi. Credo che mi rimarrà per sempre impressa la sensazione della brezza marina che mi veniva incontro e mi scorreva tra le dita mentre pedalavo con una mano tesa verso le fronde dei pini, molti dei quali, tra l’altro, hanno un nome: qui sotto, per esempio, da sinistra potete vedere i pini coniugi, che crescono biforcandosi dallo stesso tronco; il massiccio pino da mille kan; e il pino della saggezza, diviso in tre tronchi principali così come tre sono le persone che dovrebbero consultarsi per elaborare un buon piano.

「はし立や松は月日の こぼれ種」与謝蕪村 “Hashidate, i tuoi pini del tempo sono i figli spontanei” (Yosa Buson)

「潮騒の声を聞いた、影法師見つめてる。手を引いた足跡に砂の音残るようです。ああ、そうだ、君の、君の風景が写ってる、小さな波を見て。ああ、そうだ、僕の、僕の風景も優しく小さな日々と重ねて」
“Ho sentito il rumore delle onde, osservo il profilo delle ombre. Nelle orme che mi hanno condotto per mano pare rimanere il suono della sabbia. Ebbene sì, guardando i piccoli flutti appare il tuo paesaggio. Ebbene sì, anche il mio paesaggio si sovrappone dolcemente a queste piccole giornate”
Tra tutti questi pini, tra l’altro, mi ha fatto abbastanza ridere che ci fosse una lastra con un haiku di Bashō a cazzo a fianco del quale si leggeva: “vabbè probabilmente Bashō non è mai stato qui e non ha mai scritto haiku riguardo ad Amanohashidate, ma cazzomene noi volevamo dedicargli questo monumento lo stesso perché sì”. Lol, okay? Ad ogni buon conto, una volta attraversato tutto l’istmo e sbucati fuori dalla pineta, ci dirigiamo verso il vicino Kono-jinja (籠神社、あの神社じゃなくて).

Questo santuario, all’interno del quale non è permesso fare fotografie per non si capisce bene esattamente quale motivo, originariamente ospitava la più importante divinità del pantheon scintoista, la dea del Sole Amaterasu, e la dea dell’Agricoltura Toyoukehime. A entrambe è stato poi dedicato l’Ise-jingū, ma è ancora possibile venerarle qui.
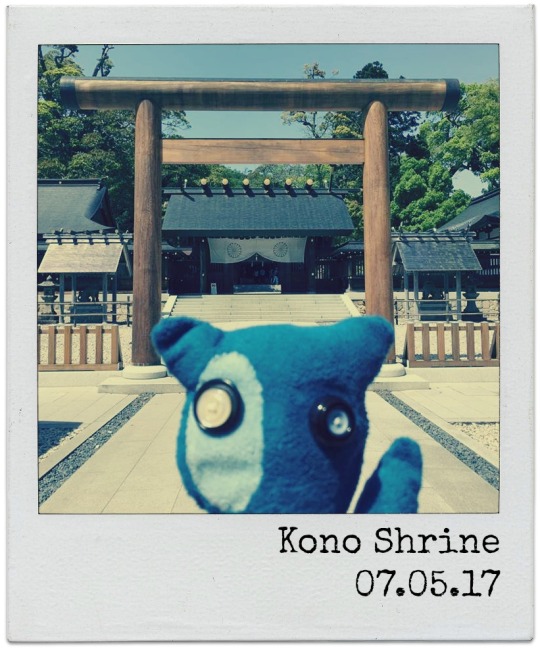
Proseguendo oltre il Kono-jinja, si arriva a una seggiovia (di fianco scorre anche la funivia, ma vuoi mettere il brivido di salire su una sedia appesa a mezz’aria senza sbarre di sicurezza, che si vede è prassi in Giappone perché non è la prima volta che ne registro la mancanza) che in sei minuti porta in cima al Kasamatsu Park, un belvedere da cui finalmente si può godere la vista mozzafiato della baia di Miyazu tagliata a metà dalla sottile lingua di sabbia di Amanohashidate. Pare sia tradizione consolidata fare una foto ricordo mentre si osserva il panorama attraverso le proprie gambe (股のぞき, matanozoki), perché si dice che così facendo l’istmo appaia galleggiare. Non so, a me è andato il sangue alla testa e mi pareva che mi venisse da vomitare, quindi credo che sia la sensazione di nausea diffusa che fa sembrare che effettivamente tutto galleggi, ma non vorrei rovinare la poesia di questa pratica.

A sette minuti di autobus da Kasamatsu Park si può poi arrivare al Nariaiji, tempio buddhista dedicato a Kannon che si dice possa realizzare qualsiasi desiderio. La leggenda vuole infatti che un monaco di questo tempio avesse pregato il bodhisattva di salvare il villaggio dalla fame garantendo un pasto a tutti; prontamente, la statua di Kannon qui venerata si trasformò in un cervo offrendogli parte delle sue carni.
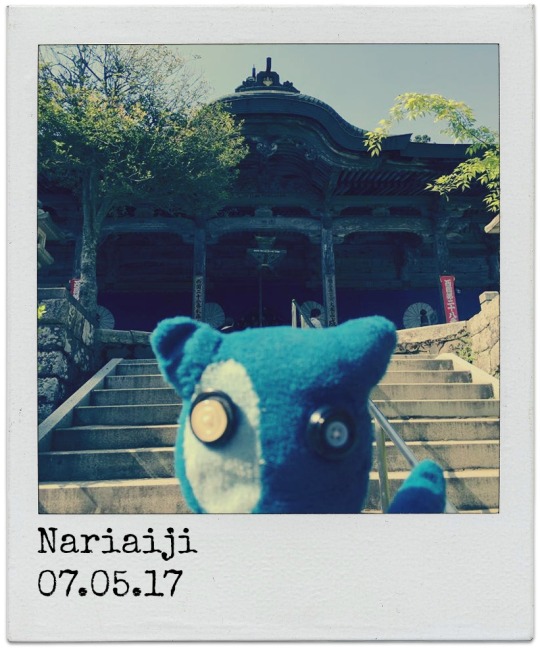
Altre attrazioni interessanti dei tempio sono il Jizō che realizza tutti i desideri; la campana che non suona, per realizzare la quale furono raccolte donazioni da tutti i fedeli tranne una ricca signora, che, venuta a vedere l’opera finita con l’ultimo nato, fece cadere il bambino nella torre campanaria, tragico evento in memoria del quale la campana non fu più suonata; e il belvedere di Bentenzan da cui si gode una splendida vista della baia e della pagoda a cinque piani del tempio stesso.

Sulla strada del ritorno, correndo contro il tempo per cercare di non perdere il treno che ci avrebbe riportati a Kyoto, abbiamo fatto giusto in tempo a dare una rapida occhiata ad Isoshimizu, una fonte di acqua stranamente dolce nonostante si trovi nel bel mezzo dell’istmo, selezionata come una delle cento acque più pure del Giappone, e il Chionji, un tempio dedicato al bodhisattva della saggezza Monju.
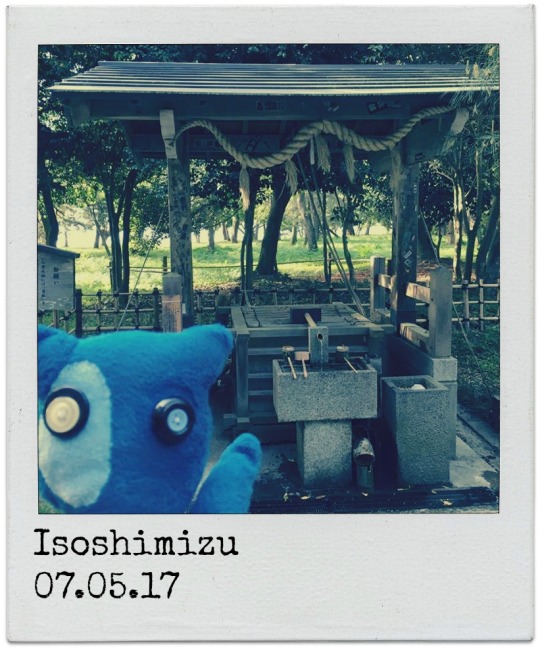
「橋立の松の下なる磯 清水都なりせば君も汲ままし」和泉式部 “As if found in the capital, you too, could cup in your hands the fresh water of Iso-Shimizu that tumbles from the Ama-no-hashidate pines.” (Izumi Shikibu)

Concludo questo interminabile resoconto di viaggio con un ringraziamento a F., che è stata la ragione per la quale ho voluto tornare a Kyoto per la Golden Week in modo da farle visitare la città - inutile che ve lo ripeta perché l’ho scritto anche troppe volte ormai, Kyoto è e spero rimarrà sempre per me un posto unico e speciale, dove, come dice Banana Yoshimoto in ‘Sweet Hereafter’, “qui e là si mescola il mondo dei sogni”; un luogo dove ogni volta che torno sento che anche se non sembra cambiato niente nulla potrà più tornare come prima, perché nel frattempo sono cambiato io; una città dove se un incontro è destino capiterà, come quello con C. che avrei voluto contattare ma non ero sicuro che avrei avuto il tempo di andare a trovare, e che invece ha trovato me per puro caso nei pressi dello Yasaka-jinja.
Grazie F. per essere stata la molla che ha fatto scattare l’interesse che mi ha poi molti anni dopo portato qui. Mi sono ritrovato a riflettere spesso durante i nostri giorni a Kyoto a quanto diversamente avremmo vissuto questo viaggio se l’avessimo fatto anni fa, quando il Giappone ci sembrava lontanissimo, letteralmente dall’altra parte del mondo, poco più che un sogno che, come il poliziotto di Paprika, non potevo sapere che un giorno sarebbe diventato così reale e “normale”, tra le mille virgolette del caso.

"Tu non hai fatto niente di male. Hai soltanto vissuto il nostro film nella realtà. Ecco perché sei diventato un poliziotto. È una verità nata dalla tua fantasia... non dimenticarlo mai." "...Già. Dalla mia fantasia."
Grazie F. perché se è vero che siamo cambiati rispetto ai due adolescenti fomentatissimi per tutto quello che di giapponese potevano reperire nella loro piccola provincia, nonostante il tempo passi, le distanze siano aumentate e la nostra quotidianità sia così diversa, mi è sembrato di riprendere esattamente da dove avevamo lasciato l’ultima volta che ci siamo visti, e sì che da allora ne sono successe di cose. Non sono tantissime le amicizie che durano così tanto e che sopravvivono a cambiamenti così drastici, per cui mi sento molto fortunato di aver avuto la riprova che questo è il nostro caso.
Grazie per la biciclettata notturna fino al karaoke, per i discorsi seri in italiano, per le battutacce in qualsiasi lingua, per la promessa di tornare, possibilmente prima che caccino pure me lol. Arigatō kudasai.

“Buppanase like a dangan liner!” [cit.]
0 notes
Text
Cose che stanno diludendo
Sta arrivando la primavera anche a Tokyo. Lo si capisce perché Starbucks ha cominciato a vendere il sakura latte e perché i giapponesi si lamentano del kafunshō (花粉症, allergia al polline? “scusate, febbre da fieno” [cit.]).
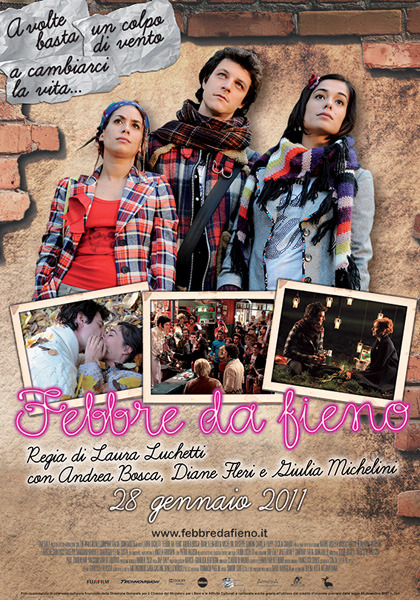
Ma poi sto film? Tre anni di pubblicità nei cinema e poi? L’hanno proiettato davvero alla fine?
Sta arrivando la primavera, ma boh, sta arrivando davvero? Sarà un mese che si alternano giornate decisamente tiepide e ricadute nel gelo totale (i più sensibili me lo scrivono pure nelle mail di lavoro, sì sto parlando di te Cynthia-san che ti struggi perché non sai mai che cappotto metterti). Insomma, primavera tokyoita, stai diludendo. Ma non sei l'unica.

In un comune pomeriggio festivo sono andato a visitare un santuario il cui nome, o meglio, quello dell'omonima stazione visto qualche mese fa sulla mappa della metropolitana di Tokyo, mi aveva incuriosito: il Suitengū. Fondato nel 1818 e dedicato a Suiten, divinità buddhista legata all'acqua che è la trasposizione giapponese del deva indiano Varuna, quando cinquant'anni dopo, durante la restaurazione Meiji, avverrà la scissione tra culti buddhisti e scintoisti (prima sincreticamente amalgamati) a causa delle misure prese per innalzare lo Shintō a religione di stato in linea con il crescente spirito patriottico, avverrà un'ulteriore trasposizione da Suiten ad Amenominakanushi, una delle divinità primigenie della mitologia giapponese e collegata alla Stella Polare. I visitatori che si recano al Suitengū lo fanno principalmente per pregare affinché avvenga presto il concepimento di un figlio o perché il loro bambino nasca sano. Non è un caso che questo santuario sia consacrato allo spirito dell'imperatore Antoku, lo sfigatissimo imperatore bambino buttato in mare durante la battaglia di Dan-no-ura che nel 1185 determinò la sconfitta del clan Taira per mano dei Minamoto e la fine del periodo Heian.
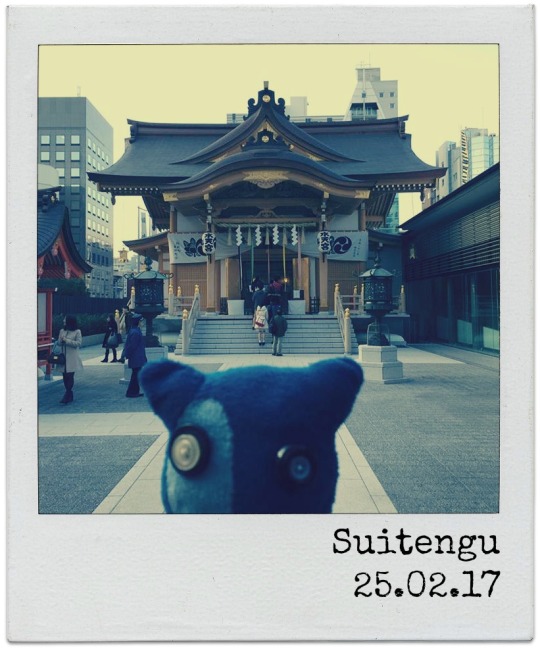
Bello, no? Invece no, è uno dei santuari più brutti che io abbia mai visto perché si erge su una specie di piattaforma antisismica in cemento armato ed è situato in una nicchia scavata tra i palazzoni a cui cerca timidamente di rubare il permesso di esistere. Non c'è un albero a pagarlo, macché albero, non c'è manco una siepe, o un'aiuola, neppure dei gerani di plastica.

A parte due statue, una sorta di Madonna dei Kappa, con un kappa (mostro acquatico vagamente simile a una tartaruga che nel folklore giapponese è responsabile di molti annegamenti, soprattutto di bambini) che tiene stretto a sé la prole, e un'altra effigie di un cane con il proprio cucciolo che è raffigurato in molti souvenir del santuario, direi che non vale proprio la pena.
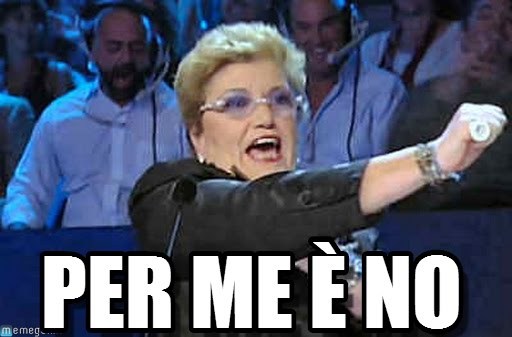
Un'altra cosa che avevo probabilmente sopravvalutato era l'asta dei tonni di Tsukiji. Ero già stato in passato al famoso mercato del pesce di Tokyo, ma non avevo mai avuto occasione di assistere alla famosa e antelucana asta che si tiene tra le cinque e le sei del mattino in uno stabile dove credo che per il resto del tempo stuprino la gente, e per accedere al quale bisogna mettersi in fila tra le 2.15 e le 3 del mattino. In condizioni normali diciamo che l'unica ragione per cui potrei essere sveglio a quell'ora è che mi trovi al karaoke o che abbia mangiato del cibo avariato la sera prima, ma siccome stavolta la mia capa mi ha invitato a unirmi al gruppo di amici che aveva organizzato di andarci, mi è sembrata quantomeno un'occasione di team building lol Gli accordi erano che venerdì notte ci si ritrovasse tutti verso mezzanotte alla stazione di Tsukiji per poi aspettare le due in qualche catena di ristoranti aperti 24/7. Tornato da lavoro ho cenato e mi sono detto: "Dai riesco anche a dormire due ore prima di andare a prendere il treno, adesso mi metto le mie solite venticinque sveglie così sono sicuro di sentirle".
Little did I know.
So che sembra incredibile visto che le premesse erano davvero ottime (*sarcasm alert*), ma morale della favola le mie venticinque sveglie coprivano il lasso temporale tra le dieci e le dieci e mezza e io mi sono svegliato tutto bello riposato a mezzanotte e mezza, ritrovandomi il telefono tempestato di messaggi della mia capa che chiedeva se doveva mandare i San Bernardo in mio soccorso o chiamare Chi l'ha visto, e sentendomi un completo idiota (uno pensa che sia una sensazione familiare ormai, e invece) per aver ormai inesorabilmente perso l'ultimo treno. Solo che io a sta asta dei tonni ci volevo andare e mi seccava davvero tanto paccare così all'ultimo dopo che erano stati così gentili ad invitarmi e convalidare il pregiudizio degli svizzeri nei confronti degli italiani lol, per cui mi sono detto: "sai che faccio? Mo' prendo un taxi così sperimento quanto costa andare da una parte all'altra di Tokyo".
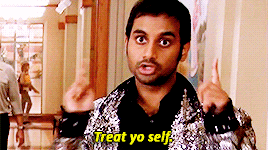
E la risposta è: 50 euro. Vabbè ma tanto avevo già deciso che avrei smesso presto di fare tre pasti al giorno, food? Gross! I was just bored!

[🎉/💸]
A parte che ho beccato il tassista più loquace di tutta Tokyo credo, simpatico eh ma GGGGGGGGH è l'una di notte non parlarmi lasciami morire nei sedili posteriori non ce la faccio a reggere una conversazione a quest'ora, diciamo che almeno sono riuscito ad arrivare in tempo per mettermi in fila con gli altri davanti a sto casermone dove verso le tre del mattino ci hanno fatto entrare consegnandoci dei discutibili giubbini catarifrangenti, disponibili in due colorazioni per dividere i convenuti in due gruppi che avrebbero poi assistito all'asta in momenti diversi. Dopo aver indossato i giubbotti ci siamo accasciati per terra in perfetto stile terremotati in questa stanza dove avremmo dovuto aspettare le cinque del mattino, intrattenuti prima da Kōhei-san, un carinissimo pescatore giapponese che ci ha iniziati ai misteri della pesca del tonno in un inglese sorprendentemente fluido per un uomo della sua età, e poi dal solito americano coglione che non ha fatto altro che urlare per due ore e menarsi col suo degno compare facendo casino e andando addosso alla gente, Madonna oh per fortuna ci sono gli americani in giro per il mondo che fanno sembrare educati e silenziosi gli italiani.

Guarda, Kōhei-san ha appena finito di spiegarci che i tonni vengono conservati in freezer a - 60 gradi, fai una roba: chiuditici dentro.
Sopravvissuti alle due ore di attesa con l'americano imbecille che grazie a Dio almeno non era nel nostro gruppo, ci hanno finalmente fatti spostare nel casermone dove avviene l'asta. Entrati, lo spettacolo è davvero impressionante: decine e decine di tonni surgelati con la coda mozzata, una sezione della quale viene appoggiata sopra il corpo, in modo tale da far vedere il colore della carne, e i compratori girano con taccuino, torcia e un bastoncino ricurvo e appuntito per esaminare i tonni su cui è dipinto un numero che verrà poi annotato da chi è interessato ad acquistarlo.

Kōhei-san ci aveva spiegato che durante l'asta tutto deve avvenire con una certa velocità e dunque il battitore si limita ad annunciare il numero cui corrisponde ogni tonno e il prezzo in migliaia di yen a cui sale l'offerta, però mi aspettavo che il tutto avvenisse in un'atmosfera vivace e sovreccitata, non pretendevo che i partecipanti si prendessero a sberle per aggiudicarsi il tonno migliore ma insomma che trasparisse un po' di combattività. Invece, tutto si svolge in un piattume molto monoto(n)no, e se è vero che la cantilena del battitore che non pare neanche una lingua umana ma piuttosto una giaculatoria buddhista (se siete interessati potete ascoltarla su iTuna lol) è interessante nella sua particolarità, non è che l'asta di per sé sia sto spettacolo emozionante come mi immaginavo, e a me ha dato tremendamente l'impressione che tutto succedesse senza che io ci capissi un'emerita sega, sensazione a cui dovrei essere abituato tra l'altro, e invece. Boh, non so, mi ero figurato una competizione serrata e invece mi è parso che tutto scorresse con lo stesso entusiasmo con cui i cassieri ti passano i codici a barre della roba al supermercato, mi ha lasciato un po' atton(n)ito.

Mettiamola così: quantomeno per colazione abbiamo potuto mangiare del pesce freschissimo che in effetti non mangiavo dall'ultima volta che ero stato a Tsukiji appunto lol.

#飯テロ
Visto che è il post delle delusioni, giusto per rovinarmi l'unica consolazione che mi era rimasta ho poi scoperto che si sta discutendo il progetto di spostare il mercato del pesce da Tsukiji a Toyosu per svariate ragioni, tra cui il fatto che gli edifici di Tsukiji risalgono in gran parte all'anteguerra e sono in buona misura fatiscenti, e in vista anche della limitata capacità del mercato attuale in termini di volume di prodotti commerciati. Peccato solo che si siano poi accorti nel 2008 che Toyosu è inquinata da morire perché la zona dove dovrebbe sorgere il nuovo mercato ittico ospitava uno stabilimento della Tokyo Gas, e i livelli di inquinamento ambientale restano serie preoccupazioni circa la sicurezza alimentare. "Però vabbè, ormai abbiamo costruito gli edifici per il mercato, toccherà spostarlo". Devo commentare? Spostiamolo a Fukushima già che ci siamo.
Dopo questa parentesi di mordente denuncia sociale, un'ultima delusione più frivola nel campo dell'arte: sono andato a vedere la mostra di Kusama Yayoi, l'anziana designer coi capelli fucsia fissata coi pois, originaria di Matsumoto e che avevo conosciuto recandomi a Naoshima dove sono esposte due delle sue creazioni più famose, le due zucche, una delle quali è diventata anche il mio portachiavi. Vabbè, non quella vera, una riproduzione in miniatura.
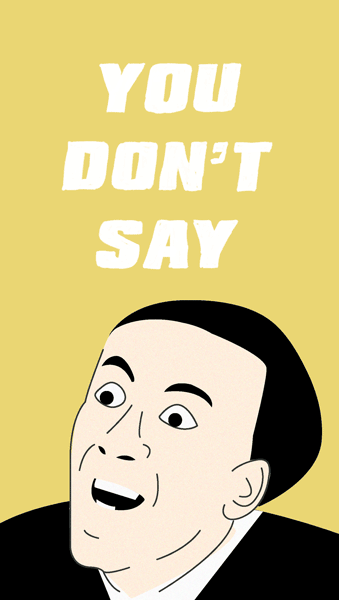
Beh, la mostra non male, un sovraffollamento di opere che spaziano dal naïf alla pop art all’astrattismo e che tappezzano le pareti del National Art Center di Tokyo, celebrando la vita con colori vivaci e chiassosi che rappresentano la salvezza per un’artista mentalmente fragile perché la tengono attaccata all’esistenza.
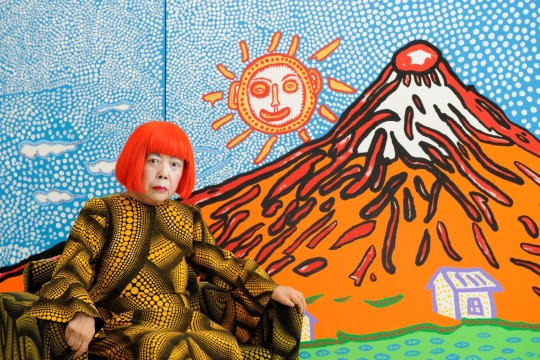
Per quanto sia stato emozionante riedere una riproduzione della zucca di Naoshima nel cuore di Roppongi a Tokyo, viene da sé che la cornice sia molto meno suggestiva, circondata solo da palazzoni (toh, come il Suitengū, ma vedi un po’ che bel finale circolare sto post lol).

Ma non è questa la delusione di cui volevo parlarvi: la vera delusione è stata andare a vedere la mostra indossando appositamente la maglietta di Yayoi Kusama, scoprire che era esposto il quadro da cui è tratta la fantasia della maglietta stessa, volerci fare una foto davanti in perfetto stile Garden State E NON POTERE PERCHÉ È VIETATO FARE FOTOGRAFIE.
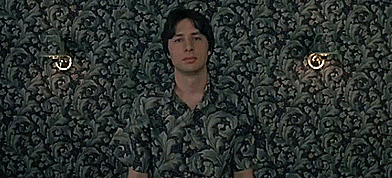
Non dovevate farmi questo, organizzatori della mostra, davvero non dovevate.

2 notes
·
View notes
Text
Cose con cui sentirsi accolti e integ(r)at(t)i
C'è quella barzelletta che racconta del tizio che muore e lo portano a vedere il paradiso e l'inferno, e il secondo gli sembra molto meglio del primo, salvo poi scoprire, una volta fatta la sua irreversibile scelta, che era tutta campagna pubblicitaria dato che nella realtà dei fatti è un posto orrendo e sentirsi dire: "mai confondere turismo e immigrazione".

Onestamente, non so se è in che misura io abbia mai fatto questo errore. Certo, nella mia brevissima esperienza sono intervenuti anche altri fattori: credo che una stessa situazione vissuta da studente e da lavoratore sia percepita a prescindere in modo molto diverso, quindi nel giudizio influisce senz'altro questo filtro, però è vero che quando si comincia a entrare nell'ottica di fermarsi in un altro paese un po' più a lungo termine si iniziano pure a osservare le cose da un punto di vista più disilluso forse.
La mia relatrice dei tempi della triennale raccontava, pur prendendone le distanze, di come ci sia anche chi scherzando ma non troppo ritiene che l'approccio dei giapponesi con gli stranieri sia tranquillamente assimilabile al meccanismo di venerazione dei marebito 稀人/客人, creature divine o soprannaturali estranee che entrano per un certo periodo limitato in contatto con gli umani e a cui si fanno delle offerte perché si crede che la loro benevolenza porti fortuna ma che poi una volta pacificati vengono rispediti da dove sono venuti. Tenendo a mente questo processo di assimilazione e respingimento del divino, mi fa sorridere paragonarlo ai giapponesi che riempiono di regali i visitatori stranieri per poi accertarsi che se ne tornino al loro paese, anche perché mi pare abbastanza presuntuoso considerarsi al pari delle divinità, però insomma capisco cosa possa aver fatto nascere una teoria del genere lol.
L'accoglienza è un tema abbastanza spinoso in qualsiasi paese credo, e se Geppi Cucciari racconta che se è vero che i sardi devono bussare con la testa perché hanno sempre le mani impegnate da un dono al contempo hanno la memoria lunga e si ricordano bene di ciò che viene fatto loro nel bene e nel male, in un'altra isola dall'altra parte del mondo si spendono porzioni considerevoli di stipendio per comprare souvenir da portare a tutti quelli che sanno che siete andati da qualche parte (il mio consiglio: viaggiate ma non ditelo mai a nessuno, non mettete foto su facebook, non fare trapelare la notizia MAI NELLA VITA lol), ma tuttora non mi è chiaro se sia per abitudine, per inerzia, per dovere o per piacere, per gentilezza o per obbligo oppure per tutte queste cose insieme (d'altronde stiamo parlando del paese dove i cioccolatini che si regalano a San Valentino si dividono in honmei-choko 本命チョコ, regalati alla persona amata, giri-choko 義理チョコ, donati per obbligo, tomo-choko 友チョコ, offerti agli amici, fami-choko ファミチョコ per la famiglia e mai-choko マイチョコ per se stessi, quindi insomma fare confusione è un attimo e te lo credo). Da una parte trovo assurda quest'ansia che ogni tanto mi prende di non farmi trovare senza un regalino, soprattutto dai giapponesi perché molto probabilmente loro stessi ne avranno uno per me, ma dall'altra mi ha fatto riflettere su come sia subdolo il meccanismo del dono e come impegni poi le due parti in una catena mai più spezzata di scambi di gentilezze che se porti avanti perché ti fa piacere è un conto, ma se lo fai perché costretto poi capisco perché la gente obbligata a essere sempre formalmente gentile poi in metro è sempre incazzata lol.
Può essere difficile sentirsi accolti a Tokyo, una metropoli dove tredici milioni di persone strisciano, consumano, spendono, si ignorano, covano rancore e mal sopportano il prossimo. Una città dove ognuno cerca rifugio dal mare di persone che vengono rigurgitate ogni giorno fuori da appartamenti minuscoli e da vagoni straripanti, dove una volta che saluti qualcuno questo finisce inghiottito dalla marea di estranei e scompare nel nulla. Ma è anche una città dove le persone si cercano, si danno appuntamento e a volte si trovano anche senza cercarsi. Una stanza affollata dove ci si sente gli unici, una somma di solitudini dove l'unica possibilità di non venire schiacciati dal contatto umano imposto è scegliere i rapporti giusti. In un paese dove di quando in quando mi chiedo se la gentilezza sia genuina e disinteressata o semplicemente un codice sociale strategico (non che non ci si possa fare la stessa domanda in Italia, semplicemente nel proprio Paese è più facile leggere i segni che conducono alla risposta), la fortuna più grande è poter contare su delle relazioni franche che vadano oltre il formalismo.
È già da mo' che non ci credo più ai giapponesi che ti fanno i complimenti per come parli la loro lingua, anche perché chissà come mai te lo dice sempre gente che ti vuole vendere qualcosa lol, ma se poi il sales manager dell'hotel dove stai organizzando un evento a cui porti del cioccolato per ringraziarlo di essere sempre flessibile nonostante tutti i cambiamenti dell'ultimo secondo dopo una decina di minuti ti chiama da parte e ti dice mezzo imbarazzato: "già che mi avete portato il cioccolato, ho lasciato una borsa sotto il tavolo della reception con una tortina, portatela a casa quando finisce l'evento", io un po' mi commuovo. A prescindere dai giri-choko, dalla possibilità che la cortesia mi sia tornata indietro magari solo per formalità, dal fatto che ci credo che sei gentile con tutti i soldi che ti devo pagare lol, potevi non farlo e l'hai fatto.
Sentirsi accolti da una metropoli dispersiva come Tokyo può essere difficile, dicevo, ma capita dove meno te l'aspetti e per motivi anche futili. Per esempio, tutte le mattine quando mi dirigo verso la stazione di Nakano e incrocio questo tizio che viene dalla direzione opposta e siccome credo sia abbastanza puntuale a seconda di a che altezza lo incontro ho un termine di paragone per capire quanto sono in ritardo e che treno riuscirò a prendere senza neanche guardare l'orario; o quando poco prima delle strisce pedonali sento il suono del campanello di un negozio che è uguale identico a quello della cartolibreria del mio paesino in Italia; o quando incontro per caso i miei ex-compagni di università che adesso vivono nella mia stessa zona in giro per qualche commissione; o quando ancora mi fermo ad accarezzare Rikimaru-kun, il cane beniamino del quartiere battezzato così in onore di Ricky Martin, che spesso è legato fuori dalla casa del suo padrone e passa in rassegna la gente con lo sguardo. C'è un tale senso di familiarità insito in tutto questo che io un po' mi sento a casa.
E per un vicentino provinciale cosa c’è di meglio per sentirsi accolto che visitare il Gōtokuji 豪徳寺, un tempio buddhista di scuola Sōtō infrattato in una zona un po’ fuorimano del quartiere di Setagaya, considerato il luogo d’origine del maneki-neko 招き猫 (o come viene scritto nei cartelli del tempio 招福猫児, just because), il gatto con la zampa alzata emblema stesso dell’accoglienza. Esposto soprattutto dagli esercizi commerciali perché si ritiene che attiri i clienti, vi sono diverse leggende circa la sua origine, ma una di queste riguarda proprio il Gōtokuji.
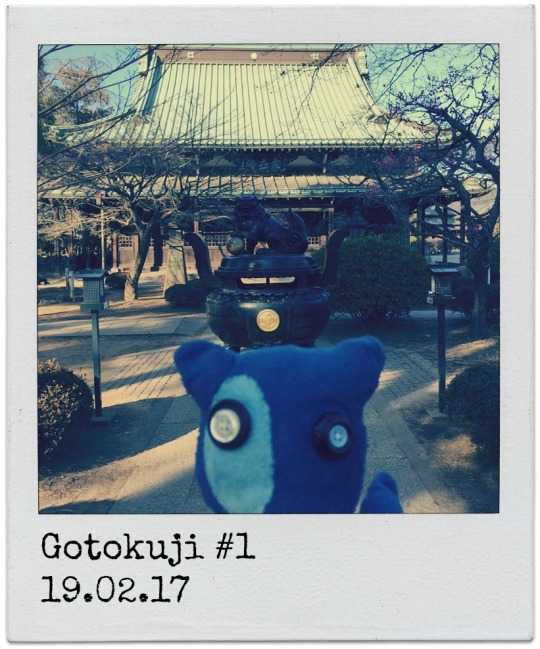
Si racconta infatti che in periodo Edo (1603-1867) vi fosse in questo tempio un monaco con una grande passione per i gatti e che ne avesse uno con il quale divideva persino il proprio cibo e che trattava come un figlio. Un giorno gli si rivolse pregandolo, se le cure che gli aveva dimostrato gli erano gradite, di ricambiare l’amore con cui lo aveva cresciuto, e non passò troppo tempo prima che al tempio arrivasse in visita un gruppo di guerrieri a cavallo che, di ritorno da una battuta di caccia, dissero di essere stati attirati da un gatto che sembrava invitarli ad entrare. Accolti dal monaco, i guerrieri fecero appena in tempo ad accettare la sua ospitalità che fuori dal tempio si scatenò un temporale con tanto di tuoni e saette (secondo alcune versioni, un fulmine colpì addirittura l’albero sotto il quale avevano precedentemente sostato prima di accorgersi del gatto; secondo altre, l’intervento del gatto fu vitale per permettere loro di evitare una trappola che era stata tesa loro poco più avanti lungo la loro strada). Il gruppo capì che l’animale li aveva salvati e presentandosi come i vassalli del signore di Hikone, Ii Naotaka (secondo altre versioni addirittura il protagonista stesso della vicenda), che in segno di riconoscenza rese prospero il tempio. Dopo la morte del gatto, in sua memoria il monaco costruì una piccola statuetta che ne ricordava le sembianze e da allora si crede che esporla porti fortuna e ricchezza.

In realtà, nonostante fin dalla stazione omonima, la stazione di Gotokuji appunto, ci sia un maneki-neko che vi dà il benvenuto, quando si arriva al tempio non è proprio subito chiarissimo e lampante che sia questo il luogo di un culto così particolare: appena entrati, sembra un tempio come un altro, con un viottolo che vi conduce davanti a un enorme incensiere con un leone cinese simile a quello dello Zenkōji, superato il quale si può procedere fino a un padiglione abbastanza anonimo fatta scorrere la cui porta d’entrata, però, vi si parano davanti statuine del maneki-neko di tutte le dimensioni che si possono comprare per poi portarle in un’altra zona non proprio evidentissima che è il pezzo forte del tempio, dove andrebbero appoggiate e non portate a casa come ho fatto io con la mia (cioè ma 500 yen di statuetta secondo te glieli lasciavo lì? adesso è posata sulla scarpiera in entrata che mi guarda, ma scherzi). Anche se o forse proprio perché la zona dove tutte le statuette vengono appoggiate non è palesissima, quando la si raggiunge e si vede l’accumulo di maneki-neko non si può non rimanerne colpiti.

Gatti...

... gatti ...

... e ancora gatti! Adesso sì che è un post molto Tumblr. Ah no, manca qualche gif di gatti a caso. Provvediamo subito.
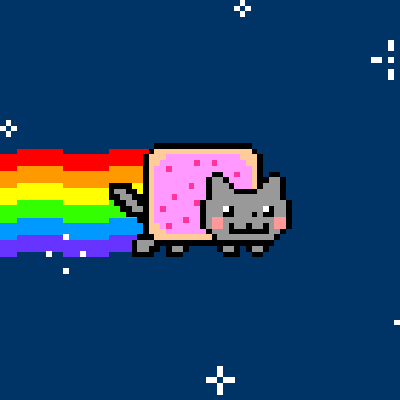
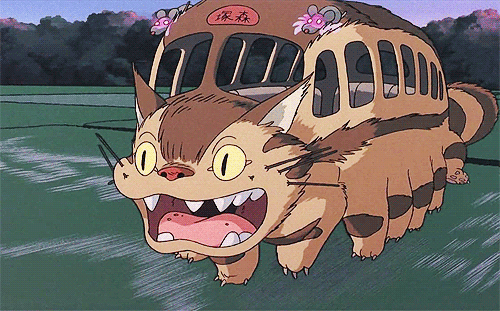
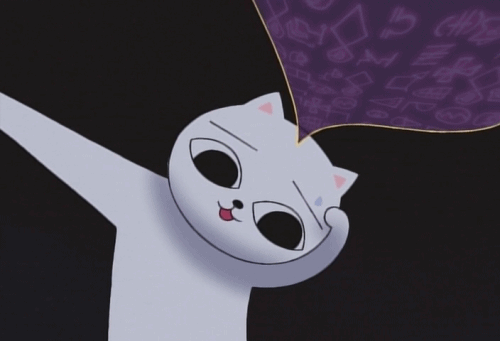

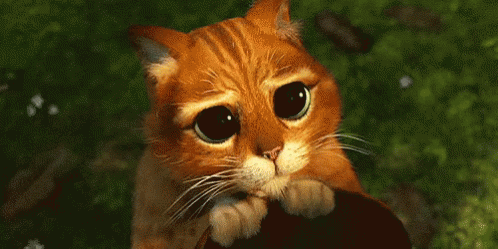
Abbastanza a posto adesso, sì?
Rallegrandomi della coincidenza che ha voluto che finissi di scrivere questo post decisamente molto nekobakakawaii quando in Italia è ancora il 22 febbraio, considerato in Giappone il Giorno del Gatto (Neko no hi, 猫の日) perché 22.2 può essere letto “ni-ni-ni” ricordando il miagolio del gatto che in giapponese è “nyan-nyan-nyan” (stupidi giapponesi, li amo), credo mi dedicherò ora all’attività che più ho in comune con questi animali.
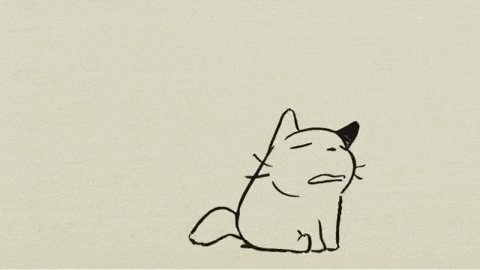
[P.S.: qualcuno si è fatto degli amici al Gotokuji.]

1 note
·
View note
Text
Cose ritrovate sepolte nella neve di Nagano
La motivazione necessaria per riprendere ad aggiornare il blog. Non ho nemmeno aspettato di tornare a casa e inizio a scrivere questo post nel trenino sgangherato ma coi sedili riscaldati che sferragliando mi porterà da Hakuba a Matsumoto (ciao Lucilla, ti penzo 💙).

(Il paesaggio fuori dal finestrino del treno now).
Cosa mi abbia portato qui è presto detto: long story short, da fine novembre dell'anno scorso ho un nuovo capo a lavoro (la giapponese di prima dopo un anno di mobbing ha deciso che si era divertita a sufficienza ed è andata a tormentare qualcun altro lasciando posto a Lilo, una ragazza svizzera di un anno più grande di me che probabilmente a breve inizierà ad odiarmi pure lei lol, ma che per il momento posso dire essere stata un dono dal cielo per farmi ritrovare la motivazione per andare in ufficio ogni mattina senza meditare di buttarmi sotto i binari già in stazione). Il weekend del 28-29 gennaio era in programma una gara di sci intercamerale tra le Camere di Commercio austriaca, tedesca e svizzera, giunta quest'anno alla seconda edizione, e fosse stato per il mio capo di prima col cazzo proprio che avremmo partecipato, ma Lilo ha deciso che non essendoci tra l'altro troppi partecipanti sarebbe stato meglio andare quantomeno per fare numero lol
Così il 27 di gennaio siamo partiti in anticipo dall'ufficio e ci siamo diretti in Shinkansen verso la prefettura di Nagano, che ancora mi mancava, in compagnia del presidente (che immaginando che non avremmo avuto tempo di cenare ci porta gli hamburger, ma che stellina T_T) e di un'amica norvegese di Lilo.

Business trip (s)now! ❄
La prefettura di Nagano è nota anche col nome storico di Shinshū (信州) o Shinano-no-kuni (信濃国), una lettura totalmente a cazzo che sembra derivare in realtà dalla più antica e sensata grafia 科野国, che è stata interpretata da studiosi diversi o come “il paese (che prende il nome dalle) distese di tigli” o come “il paese delle distese di dislivelli (=montagne)”. “Shinano-no-kuni” è anche il titolo dell’inno della regione, una canzone LUNGHISSIMA e abbastanza teribbile che però è stata eseguita pure durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali che proprio Nagano ha ospitato nel 1998. Le montagne che insieme alle mele rendono famosa questa zona sono definite le Alpi giapponesi e in effetti devo ammettere che per certi versi visitandole mi è sembrato in parte di rivedere alcuni paesaggi dell'Alto Adige, dove da piccolo mi portavano a trascorrere le vacanze invernali.
L'evento che ci vedeva coinvolti in quanto staff si teneva a Hakuba, un paesino infrattato tra i monti dal romantico nome di "cavallo bianco" e collegato a Nagano da una corriera su cui sono collassato in parte anche per sfuggire allo sguardo tagliente e risentito della bambina che mi sedeva affianco che non poteva perdonarmi il fatto di aver ingurgitato caramelle senza offrirgliele (bambina non te l'hanno insegnato? Non si accettano le caramelle dagli sconosciuti, soprattutto quando gli sconosciuti ti odiano perché c'hai meno di dieci anni e già parli fluentemente francese e inglese essendo un qualche strano misto e fiera di questo guardi sprezzante negli occhi la gente più grande di te).
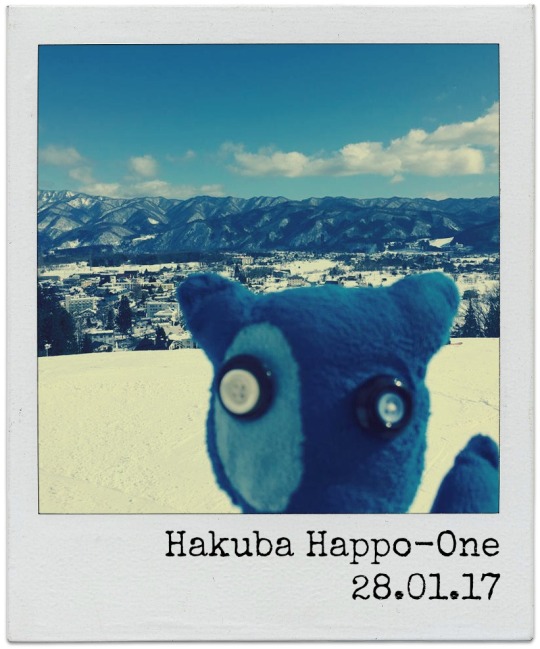
Dalla stazione di Hakuba (una di quelle vecchie stazioni di montagna dove c’è ancora il tabellone con il risicato numero di treni che passano ogni ora e dove la Pasmo, la tessera elettronica ricaricabile che in teoria si può usare in tutto il Paese non è accettata perché non ci sono circuiti che la leggano, non so se capite l’arretratezza) chiamiamo un taxi che ci porta fino al nostro hotel, passando davanti a quelli che credo fossero i due trampolini per il salto da sci di Hakuba costruiti per le Olimpiadi, entrambi illuminati come fari nella notte.

Nagano scelta per ospitare le Olimpiadi invernali nel 1998 e se la tira ancora da allora!
L’hotel, una struttura onesta col legno a vista e discutibili poster dal sapore mitteleuropeo, le pastiglie di zucchero di canna di benvenuto vecchie di secoli, la sala comune dove mangiare la colazione che viene preparata e servita rigorosamente dalle 7:30 alle 8:30 e se non ti presenti ti telefonano in camera alle 8:00 per dirti che è pronto quindi fai il favore di venire a tavola, e poi l’andare in giro con la calzamaglia e tutti quei vestiti orrendi e scomodi che si rendono necessari per difendersi dal freddo montano mi hanno proprio risvegliato le sensazioni che provavo da piccolo quando mi portavano in vacanza in Alta Pusteria, e mi hanno fatto pensare che forse il modo in cui si vive in montagna non cambia poi così tanto da paese a paese, forse perché in effetti le insidie che si devono affrontare sono simili ovunque (quante insidie!).

In montagna ci si rompe il c***o

C’erano davvero i discutibili poster dal sapore mitteleuropeo, non stavo scherzando! © Courtesy of Lilo
È stato bello ritrovare la naturalezza dei movimenti una volta sugli sci nonostante non li mettessi ai piedi da anni. Movimenti totalmente innaturali per un essere umano in condizioni normali, appresi anni e anni fa da maestri dall’accento austriaco (beh, ‘movimenti’... spazzaneve, principalmente lol). I giapponesi si confondono in continuazione tra austriaci ed australiani perché in giapponese i due Paesi suonano ancora più simili, Ōsutoria e Ōsutoraria; non sono aiutati dal fatto che a Tokyo le due ambasciate siano a meno di un chilometro di distanza, e ho rischiato di fare confusione anch’io stavolta perché mentre mi tornava in mente l’accento austriaco dei miei maestri di sci sentivo intorno a me l’accento delle tonnellate di australiani che durante la stagione sciistica popolano Hakuba. Australiana era persino la commessa del negozio dove abbiamo noleggiato sci e scarponi con Norah Jones che cantava in sottofondo. Non ce l’hanno fatta però a farmi sbroccare, neanche quando il signor Tanaka, il tassista che mi ha riportato in stazione dall’hotel al ritorno, mi ha chiesto: “Com’è che si chiama quel Paese vicino all’Italia?” “L’Austria?” “Sì, sì, l’Austria. È pieno di australiani qui a Hakuba” “Ah, sì, però quelli vengono dall’Australia, non dall’Austria, e l’Australia non è vicina all’Italia”, inutile sfoggio di saccenza che ha fatto cadere un silenzio imbarazzato e che mi è costato 400 yen perché nonostante il tragitto fatto fosse lo stesso dell’andata stavolta l’ho pagato di più lol.
Ho riprovato anche quelle sensazioni di sgradevole fatica nel camminare con gli scarponi, trascinandosi dietro gli sci, arrancando verso le piste; di frustrazione nel cercare di risalire un lievissimo pendio con gli sci che però tirano verso il basso; di ansia quando dietro di te incombe la seggiovia e non sai bene se riuscirai a sedirtici senza prendere un colpo alla colonna vertebrale che ti immobilizzerà per il resto della vita (ma di preciso, ma perché andiamo a sciare? sento che si potrebbe fare un discorso sull’amare lo sci ma odiare tutto quello che ci sta intorno del tutto simile a quello sul nuoto in ‘Medianeras’ lol). Tra l’altro, mi sono molto sorpreso nel constatare che la seggiovia che abbiamo preso, per quanto di certo non esemplificativa di tutte le seggiovie del Giappone, nel suo piccolo non aveva la sbarra di sicurezza, e la cosa mi ha un po’ stupito in un Paese che si fa un sacco di fisime sulla sicurezza appunto. Avrei potuto tornare a casa fiero di non essere nemmeno caduto dagli sci se non fosse stato che la norvegese, che sorprendentemente metteva su un paio di sci per la prima volta, dopo aver imparato a curvare ma evidentemente non proprio del tutto mi ha tagliato la strada falciandomi di prepotenza in un incidente quasi diplomatico tra Italia e Norvegia che dev’essere stato coreograficamente pirotecnico per gli spettatori ma che abbiamo trattato con la nonchalance che l’educazione impone a due persone che si conoscono da meno di ventiquattr’ore e già si sono prese a sforbiciate.
Dopo la parte vespertina dell’evento, in un hotel che doveva essere comodamente raggiungibile andando sempre dritti secondo Google Maps, salvo poi alzare gli occhi dal telefono e trovarsi vestito da ufficio in mezzo a una pista da sci con la gente che mi sfrecciava di fianco e io in scarpette di pelle che a momenti vengo falciato per la seconda volta in una giornata, dopo aver vinto alla lotteria del vino austriaco sospetto e dopo aver ascoltato il discorso di Mutai-san, che ho scoperto essere il tizio che ha inventato lo “Yama no Hi”, il nuovo giorno di vacanza che dall’anno scorso ci fa restare a casa l’11 agosto (grazie Mutai-san!), il giorno dopo parto di buon’ora dall’hotel e mi do al turismo selvaggio, cercando di vedere il più possibile sfidando le distanze e soprattutto la non troppa frequenza dei treni per riuscire a vedere il castello di Matsumoto e lo Zenkōji di Nagano prima del treno di ritorno per Tokyo nel tardo pomeriggio.
Separata da Hakuba da un’ora e mezza abbondante di treno (senza cambi però, proprio a prova di stupidi come me lol), Matsumoto è una cittadina abbracciata dai monti dove appena arrivo la gioia che sempre mi regala viaggiare per il Giappone viene completamente liberata dalla morsa del freddo. Qualcosa delle sue strade mi ricorda vagamente Okayama - sarà che entrambe le città hanno una statua davanti alla stazione (l’eroe mitologico Momotarō nel caso di Okayama e il leggendario monaco-alpinista Banryū Shōnin nel caso di Matsumoto), o che entrambe sono famose per il loro castello che, casualmente, per il colore nero è noto in ambedue i casi come “Castello del Corvo” (con la sola disambiguazione permessa da una perversione del linguaggio che, in giapponese, permette a entrambe le diciture di venire scritte 烏城 in caratteri ma pronunciate ‘Ujō’ nel caso del castello di Okayama e ‘Karasujō’ nel caso del castello di Matsumoto). Per altri versi invece mi ricorda Sapporo e l’Hokkaidō, principalmente per il clima (da cui mi difendo andando in giro con i miei amatissimi kairo, i cerotti autoriscaldanti salvavita, applicati addosso) e per quella strana atmosfera che forse è ciò che cerca di comunicare la Lonely Planet descrivendola col termine ‘cosmopolita’, quella sorta di bizzara sensazione che a dispetto di quanto possa sembrare in realtà Matsumoto sia un mondo, forse a sé stante ma un mondo, pieno di contaminazioni e nuovi stimoli da scoprire.

Il monaco Banryū Shōnin (1782-1840), che per primo ascese allo Yari-ga-take nel 1828; ultimo grande rappresentante della tradizione dei monaci alpinisti, del cui pantheon fa parte insieme ad altri sei mistici che contribuirono ad aprire nuovi sentieri conquistando le vette (En-no-gyōja, che avrebbe scalato il Fuji nel VII secolo; Taichō, pioniere dello Hakusan nell’VIII secolo; il suo quasi contemporaneo Jikō di Tateyama; Shōdō, che per primo scalo il Nantai tra l’VIII e il IX secolo; Hasegawa Kakugyō, fondatore tra il XVI e il XVII secolo di una setta che aveva il suo centro sul Fuji; e Fukan, che fece la stessa cosa tra XVIII e XIX secolo sull’Ontake).
Non me ne voglia la mia nuova capa che a quanto pare ha un pallino per i castelli giapponesi e quando ho fatto questa osservazione a momenti mi licenziava, però sono dell’idea che un po’ sia vero che visto uno visti un po’ tutti. O almeno, lo ero, fino a quando non ho visto il castello di Matsumoto che, per quanto di unico non abbia neanche il soprannome che come vi dicevo divide con quello di Okayama, vanta un panorama intorno a sé più unico che raro, con le Alpi giapponesi che lo circondano e si estendono a perdita d’occhio. Viste in inverno, con la neve, poi, sono uno spettacolo mozzafiato. Tra l’altro, osservandole mi è tornato in mente il profilo delle montagne che si vedono dalla finestra di casa mia in Italia, una cosa che mi manca molto perché prima di venire in Giappone ero stupidamente convinto che essendo i monti molto alti in qualsiasi posto del mondo fosse possibile vederli in lontananza, e invece l’unica cosa che si vede all’orizzonte a Tokyo sono grattacieli, grattacieli e ancora grattacieli / o \
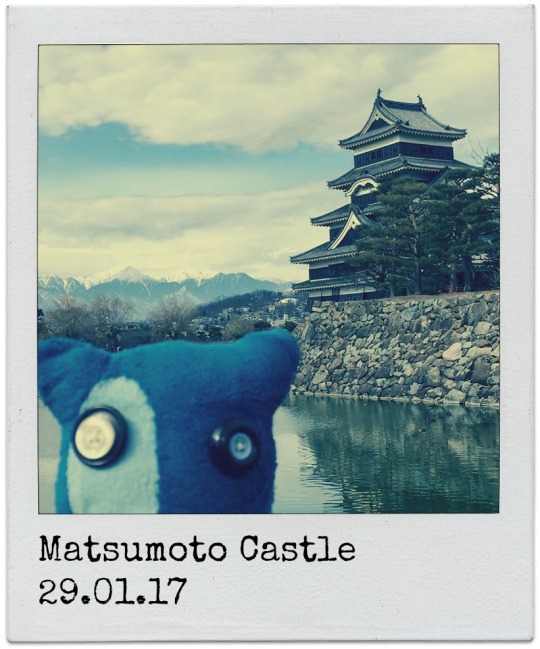
Il castello di Matsumoto deriva da un castello edificato nel XVI col nome di castello di Fukashi, costruito per volere del clan Ogasawara poco distante da un’importante fortificazione della zona, il castello di Hayashi, di cui oggi non restano che poche rovine. Nel 1549 il castello di Fukashi fu assediato e conquistato dal clan rivale dei Takeda, e solo nel 1582 Sadayoshi Ogasawara se ne riapproprierà cambiando il nome in castello di Matsumoto. Come molti altri castelli giapponesi, anche quello di Matsumoto presenta uno sfalsamento tra i piani visibili all’esterno e quelli effettivi: sembrano infatti cinque ma sono in realtà sei perché è presente un terzo piano senza finestre, una sorta di mezzanino, che veniva spesso inserito per ingannare i nemici e dove venivano immagazzinate provviste, polvere da sparo ed armi (alcune delle quali sono esposte all’interno del castello, soprattutto i famosi archibugi importati dai portoghesi nel XVI secolo), e dove dormivano i samurai. Ritroviamo anche i doccioni a forma di shachi, già presenti in cima al castello di Nagoya.

Ve ne avevo già parlato in quell’occasione, ma adesso ho nuove fresche informazioni circa queste creature: dunque, il termine adesso significa ‘orca’, ma indicava delle creature marine con la testa di tigre e il corpo di pesce (il carattere con cui si scrive, 鯱, è composto da due parti che significano appunto ‘pesce’ e ‘tigre’, e non a caso sembra essere un kokuji 国字, caratteri cinesi nati però in Giappone, la nuova frontiera del tarocco insomma). L’esistenza di queste creature immaginarie era stata in effetti ipotizzata osservando proprio gli spruzzi lanciati dagli sfiatatoi delle orche, tanto che la pinna dorsale di questi animali è effettivamente presente anche negli shachi che hanno il dorso ornato di spine aguzze, e proprio dal getto d’acqua caratteristico deriva la capacità mitologica a loro attribuita di evocare l’acqua, che è il motivo per cui vengono posti in cima ai castelli come auspicio per scongiurare gli incendi. Insomma con la visita al castello di Matsumoto ho potuto completare la collezione dei quattro castelli giapponesi patrimonio UNESCO (Matsumoto, Hikone, Himeji e Inuyama) e arrivare un passo più vicino ad aver visto tutti i 5 dichiarati patrimonio nazionale (si aggiunge a questa lista quello di Matsue che se mai visiterò sarà solo per amore di completezza lol).
Mi rifiondo in stazione (facendo una triste ma obbligatoria tappa da Starbucks per ricaricare il telefono) e lì dopo tanto tempo ho di nuovo modo di scontrarmi con l’ottusa inflessibilità che i giapponesi ogni tanto tirano fuori. Sebbene sia riuscito a entrare in stazione dai tornelli passando la Pasmo (che qui funziona, vi dicevo che Matsumoto era cosmopolita, qui addirittura i pass elettronici vanno lol), mi viene il dubbio che il treno che mi porterà a Nagano, dal romantico nome “Wide View”, richieda un biglietto a parte. Mancano dieci minuti al suo arrivo e per puro scrupolo vado a chiedere all’omino dello sportello dei biglietti: “Scusi, devo prendere il Wide View, mi serve un biglietto a parte o basta la Pasmo?” “Ah no deve comprare un biglietto a parte”. “Pensa anche di vendermelo magari?” “No deve uscire dai tornelli e comprarlo alle macchinette”. Ora, sei l’omino dello sportello dei biglietti, posso chiedere per cosa precisamente percepisci uno stipendio? Faccio per uscire dai tornelli ma ovviamente siccome sto provando a uscire dalla stessa stazione in cui sono appena entrato la carta mi segna errore e non mi lascia uscire, così mi rivolgo a un altro omino che è lì che mi guarda dall’ufficio affianco all’omino dei biglietti: “Scusi mi dà errore, può annullare l’operazione?” chiedo come da prassi quando queste cose succedono a Tokyo. “Ah ma come mai le dà errore?” “Ero entrato con la Pasmo ma mi hanno detto che per il treno che devo prendere devo comprare il biglietto alle macchinette...” “Ah, ha fatto vedere la carta al mio collega dell’ufficio biglietti?” Sto cominciando decisamente a spazientirmi perché tra un po’ passa l’unico treno che mi permetterà di arrivare in tempo per visitare lo Zenkōji, per cui visto che tra l’altro se non mi aiuta lui ad annullare l’operazione dalla carta non capisco esattamente cosa l’abbiano messo lì a fare gli chiedo se non può andare lui a bussare all’ufficio del suo dirimpettaio da cui è diviso solo da una porta visto che non avrei intenzione di rifare la fila, ma questo non si schioda e mi tocca mettermi di nuovo in coda per tornare dallo stronzo di prima che annulla l’operazione e mi lascia libero. Mentre esco vedo con la coda dell’occhio l’altro omino che solo ora apre la porta per chiedere all’omino dei biglietti se era tutto a posto con la mia carta.
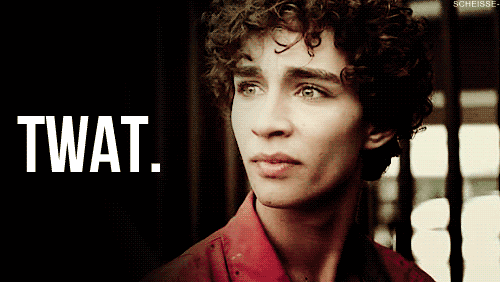
Nonostante l’elasticità mentale degli omini della JR di Matsumoto riesco comunque a prendere il Wide View che in un’oretta scarsa mi porta alla stazione di Nagano, dove in una corsa contro il tempo visto che sono ormai le tre e il tempio alle quattro chiude baracca e burattini mi scaravento in metropolitana e raggiungo finalmente lo Zenkōji.
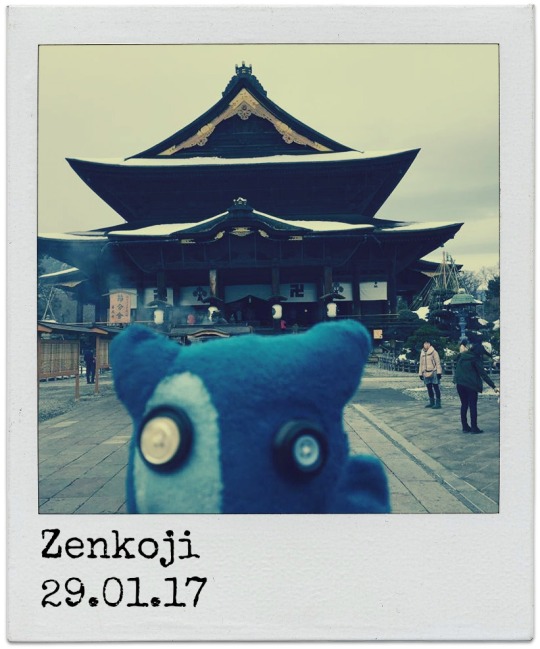
Fondato nel VII secolo, custodisce la prima statua buddhista giunta in Giappone dalla Corea nel 552, una triade del Buddha Amida di cui è esposta soltanto una copia periodicamente, e chiaramente non quando ci sono andato io. Il simulacro, divenuto oggetto di una disputa tra due clan di feudatari, venne gettato in un canale e tratto in salvo da Honda Yoshimitsu che la portò a Nagano, sua terra di origine, donandola al tempio, che prese da lui il nome (Zenkōji 善光寺 è infatti la lettura alla cinese dei caratteri del nome di Yoshimitsu 本田善光 con l’aggiunta del carattere che indica ‘tempio’).
Pezzo forte di questo tempio è una sorta di tunnel che si snoda sotto l’altare principale, una galleria completamente buia dove ho avuto una delle esperienze più mistiche della mia vita in Giappone. Si dice che all’interno di questo tunnel si trovi la Chiave del Paradiso, una chiave di metallo appesa a una parete, e toccarla garantirebbe la salvezza e l'accesso alla Terra Pura. Questa cosa si dice ma io non la sapevo quando ci sono entrato seguendo semplicemente la comitiva di turisti davanti a me perché ho accuratamente evitato di leggere il cartello che lo spiegava. Così sono entrato in questa tenebrosa galleria dalle pareti di legno massiccio che vi giuro, era completamente buia oltre ad essere molto bassa, e la totale oscurità che mi ha avvolto mi ha atterrito e gettato in uno stato di angoscia profonda quasi atavica.
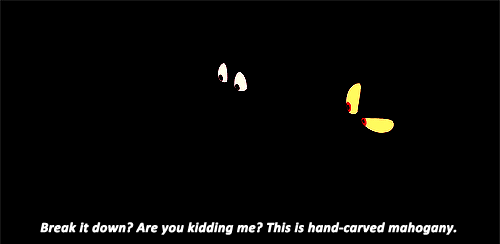
Oscurità, legno massiccio... cosa mi ricorda?
Per muoversi occorre andare a tentoni tenendo la mano destra accostata alla parete (il trucco per toccare la chiave è tenerla all’altezza dei fianchi), ma in un punto in cui bisognava girare a destra ho totalmente perso l’orientamento e sono tornato indietro da dove ero venuto. Perplesso, sono tornato sui miei passi e ho finalmente beccato la curva. Continuavo ad avanzare irretito da un’inspiegabile paura ancestrale e disturbato ma al contempo rassicurato ogni qualvolta finivo addosso al cappuccio col pelo della tipa davanti a me, e a un certo punto mi sono reso conto che avrebbe dovuto esserci qualcosa perché tutti si fermavano e sentivo il rumore di qualcosa di metallico che veniva spostato e la gente che sussurrava: “hai toccato?”, ma non avendo letto la storia della chiave non capivo a cosa si riferissero e non ero sicuro di volerlo sapere, così me ne sono uscito a riveder le stelle così com’ero entrato.

Siccome ero profondamente infastidito dall’aver fatto tutto quel giro senza raccapezzarmi, finalmente butto l’occhio sul famoso cartello e capisco qual era il senso, per cui mi ributto dentro al labirinto e finalmente riesco a toccare la famosa chiave. Da questa esperienza posso dire di aver capito svariate cose:
・fare le cose perché le fanno tutti si riconferma poco consigliabile ・ho un problema col leggere le consegne, devo stare attento a fare le cose se non ho prima capito quale sia l’obiettivo o mi tocca farle due volte ・probabilmente dovrò reincarnarmi un’altra volta prima di raggiungere la salvezza visto che ho beccato la chiave solo al secondo tentativo lol
Però insomma, adesso che mi sono garantito un posto nella Terra Pura sto più tranquillo dai. Anche perché con la tosse convulsa che mi ha preso da un paio di settimane a questa parte, potrebbe pure essere che ci finisco presto lol

2 notes
·
View notes
Text
Cose che a momenti mi dimenticavo
・Di avere un blog. No dai, a dire il vero è sempre rimasto in un angolino della mia testa durante tutti questi mesi in cui non l’ho aggiornato (è davvero tantissimo che non scrivo, so che a voi per niente ma a me è mancato molto).
・Quanto a portata di mano possano essere le oasi di pace persino nel caos metropolitano di una città come Tokyo. Una di queste l’ho sempre avuta vicino casa e ci sono passato davanti (o meglio, sotto) per mesi ogni mattina in metro, ma evidentemente dovevo aspettare un invito di V. per scoprirla un assolato pomeriggio di luglio: si tratta del parco di Shinjuku Gyoen, uno dei più grandi di Tokyo, dove frotte di coppiette impunite si sbaciucchiano all’aperto manco avessero dimenticato di essere giapponesi e dove un’altrettanto numerosa orda di svergognati accetta di pagare i 200 yen dell’entrata perché gira voce che i giardini siano una buona location per catturare Pikachu con Pokémon Go. Nel vasto parco, notevole il padiglione taiwanese o Kyūgoryōtei (旧御涼亭, Vecchio padiglione dell’onorevole frescura lol), dono dei volontari giapponesi residenti a Taiwan nel 1927 per commemorare il matrimonio dell’Imperatore Shōwa. Progettato dall’architetto Matsunosuke Moriyama, venne miracolosamente risparmiato dai raid aerei che colpirono Tokyo nel 1935 e danneggiarono gravemente gran parte del parco.
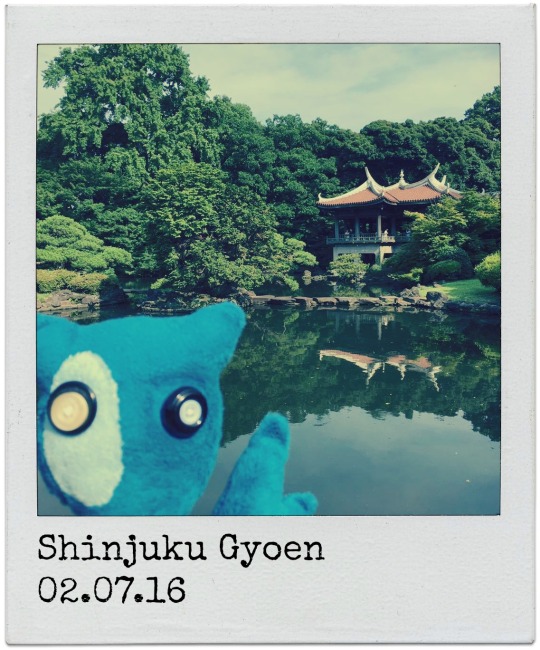
・Quanto fosse difficile organizzare le vacanze all’ultimo minuto in Giappone. Il 17 luglio era l’Umi-no-Hi (海の日, giorno del mare), e con Eva progettavamo di approfittare dell’insperato giorno di vacanza dal lavoro per evadere dalla canicola tokyoita e recarci a Niijima, isola non troppo sperduta al largo della costa di Tokyo dall’atmosfera quasi caraibica che volevo visitare da un anno, ma che a quanto pare o è gettonatissima o ha davvero pochissime infrastrutture perché non c’è stato verso di trovare posto. Complice anche il fatto che le previsioni davano tre giorni di pioggia per il nostro agognato week-end lungo, abbiamo infine optato per una gita fuori porta meno impegnativa (okay tutto ma farsi lo sbatti in traghetto per andare a prendere acqua tre giorni di fila in mezzo all’oceano ci sembrava un po’ eccessivo) e abbiamo virato verso i Cinque Laghi del Monte Fuji, in particolare il Kawaguchi-ko. Dopo un viaggio di quasi tre ore su treni via via più improbabili che fermano in posti mai sentiti prima, arriviamo alla stazione di Kawaguchi-ko, che emana un’inconfondibile atmosfera da villeggiatura: c’è proprio tutto quello che ci si aspetta da una località di turismo lacuale (miii che ignorante, si scrive la quale), persino i gruppi di turisti svizzero/tedeschi vestiti da trekking con gli occhiali da sole e la faccia incremata. Inutile a dirsi, la zona è rinomata come punto panoramico da cui ammirare il Monte Fuji, che compare spammato tipo OVUNQUE vi giriate.

Dopo aver porconato per trovare l’appartamentino di Air B&B che siamo riusciti a prenotare proprio all’ultimo e che è tipo sperso in mezzo ai campi, iniziamo a perlustrare la zona, che vedremo meglio il giorno successivo data l’ora ormai tarda.

I musicanti di Brema? Ma anche qui? Ma che è, tipo un classicone dei paesini abbandonati dal Signore?
Kawaguchi-ko dà l’impressione di una tranquilla e amena località lacustre dove il tempo scorre lento come le acque del suo lago e lambisce indolente le case, i supermercati, i ristoranti, gli alberghi e le stazioni di servizio dei benzinai, erodendone le superifici e depositando una patina opaca che rende tutto uniformemente dimesso. Per adattarsi a questa cornice è sufficiente dimenticare la fretta e i ritmi della capitale e magari mettersi in spalla una chitarra, come in effetti Eva si è premurata di fare, ponendosi in quella serena disposizione d’animo che ti impedisce di rimanere turbato persino quando camminando verso il lago ti accorgi che per il paesino si aggira pacifico un gruppo di scimmie.

Ci son le scimmie, che belle scimmie [cit.]
La prima impressione che abbiamo del lago di Kawaguchi sa tantissimo di diludendo perché col tempaccio di cui in effetti le previsioni ci avevano avvisato il panorama da cartolina che la Lonely Planet ci aveva promesso (ma perché mi fido ancora?) non se vede proprio e soprattutto con tutta quella foschia non se vede nemmeno il Monte Fuji, che boh fosse la prima volta ma a sto punto si vede che non è proprio destino.

Ma qual è? Ma ‘ndo sta? MA OH!

La statua simbolo del lago Kawaguchi, 源泉 (‘Gensen’, ‘Sorgente’), realizzata dal fu scultore Seibo Kitamura alla tenera età di 101 anni e raffigurante due figure femminili, il polo positivo e il polo negativo, che si incontrano e armonizzano intorno al vaso che rappresenta la fonte del lago stesso.
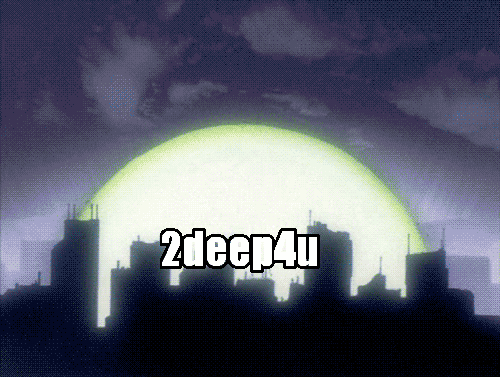
Too deep for me for sure!
Fortunatamente, l’indomani veniamo ripagati da un inaspettato bel tempo (e quando dico inaspettato intendo dire che l’applicazione del meteo dice che in questo preciso momento sta piovendo, alzi lo sguardo e ti devi scansare perché c’è Icaro con la cera delle ali sciolte che te sta a cadè addosso), che per carità meno male ma non avevo messo in conto che avrei finito la giornata a spalmarmi gel all’aloe addosso per guarire dalle ustioni.
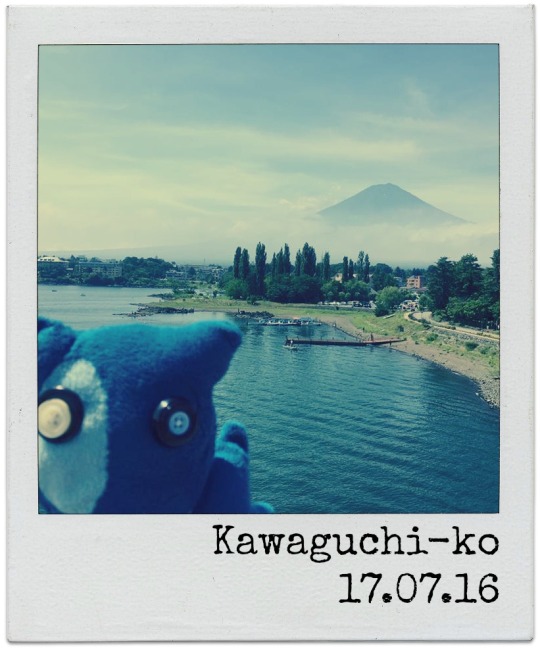
I panorami che il sereno ci regala mentre circumnavighiamo il lago sono spettacolari e finalmente individuiamo il Monte Fuji, che si erge maestoso stagliandosi contro il cielo azzurro, accarezzato dal fluire di languide nuvole che quasi quasi lo migliorano.

Tre(ntasei) vedute del Monte Fuji.
Mentre in testa mi risuona “Lakehouse” degli Of Monsters and Men, ci dirigiamo un po’ alla cazzo verso la sponda settentrionale del lago, con l’intenzione di visitare l’Oishi Park, uno dei punti panoramici raccomandati, fermandoci di tanto in tanto ad ammirare il Monte Fuji da varie angolazioni.


So close!
Caratteristiche dell’Oishi Park sono le distese di lavanda, un fiore con cui ho un legame particolare per il ruolo che ha in una delle mie opere di riferimento, “La ragazza che saltava nel tempo” di Tsutsui Yasutaka, in cui appunto è l’ingrediente fondamentale per produrre un intruglio che permette di acquisire la capacità di viaggiare nel tempo. Durante la stagione della fioritura è anche possibile raccoglierne qualche mazzo da portare a casa, che io però credevo fosse QUALCHE RAMETTO e non il massiccio lavoro di disboscamento che vediamo in atto davanti ai nostri occhi. Dopo aver fatto un giretto per il negozio di souvenir dove TUTTO ha la forma del monte Fuji, ma proprio qualsiasi cosa, dalle borse ai post-it alle bottiglie d’acqua ai biscotti (i biscotti di ‘Fujiisan’ ふじいさん, gioco di parole tra ‘Fuji-san’ = ‘Monte Fuji’ e ‘ji-san’ = ‘nonnetto’, che se la tira perché ha raggiunto la veneranda altezza di 3776 metri mi sono rimasti nel cuore ammetto) e un’inutile coda per salire sul bus che ci avrebbe riportati al punto di partenza (l’autista, il cui bus era già pieno al capolinea dove siamo saliti, ha fatto tutte le fermate scusandosi di non poter caricare nessuno. ti prego tira dritto stellina che non ce la faccio a vederti contrirti ogni venti metri), ci dirigiamo verso un altro dei cinque laghi, il Saiko. Ora, già eravamo incazzati che non ci fossero collegamenti dall’Oishi Park che pure è il punto più vicino al Saiko ma no, dobbiamo fare il giro manco avessero chiuso il cancello dall’interno [cit. nec.]; avessimo almeno avuto le biciclette ma non le abbiamo noleggiate perché DOVEVA PIOVERE TUTTO IL GIORNO, ma pazienza, abbiamo fatto il pass per gli autobus, usiamolo; però le cartine con le fermate che non si capisce dove siano e gli orari puramente indicativi, facciamo che no? Non sono più abituato a quest’approssimazione all’italiana D: Quando finalmente riusciamo a raccapezzarci un minimo, un bus pieno di cinesi ci porta intorno al Saiko fino a un posto che riguardando a distanza di mesi la mappa credo si chiamasse Nenba, ma non ne ho la certezza perché appunto dei percorsi dei dannati bus in due non siamo riusciti a venirne a capo, e okay che io abbasso molto la media ma Eva è in gamba, e non ne sono venuti a capo nemmeno i cinesi del bus che secondo me erano lì perché si erano persi (loro e una compagnia molto internazionale in stile ‘L’appartamento spagnolo’, la cui componente italiana ci ha immediatamente spinti a comunicare in giapponese per evitare ogni possibile contatto, ma è un tratto degli italiani all’estero evitarsi come la peste o siamo solo noi che siamo stronzi? tra l’altro mega antisgamo, non si accorgeranno MAI che non stiamo parlando la nostra lingua madre lol). In questo misterioso posto dimenticato da Dio ci rifocilliamo e compatendo i bambini che fanno la campestre intorno al vicino campo da gioco aspettiamo di riprendere un altro autobus che ci porterà a una delle destinazioni raccomandate della zona: la Grotta del Ghiaccio Narusawa, una grotta di origine vulcanica creata dalla lava del Fuji durante un’eruzione in epoca preistorica.
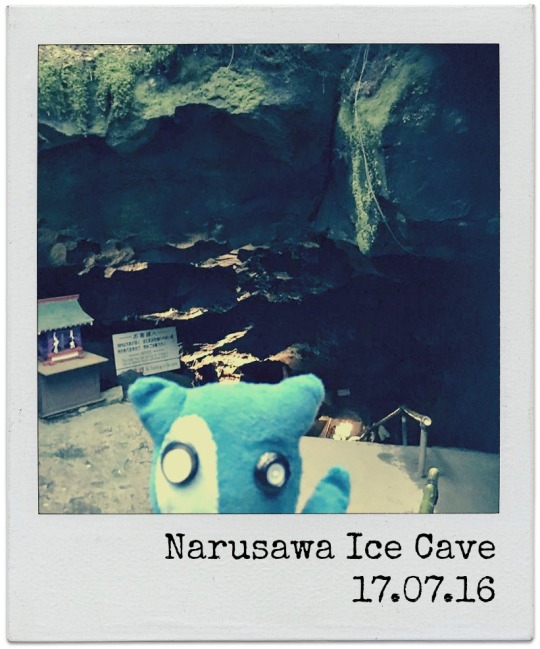
Come suggerisce il nome, la Grotta del Ghiaccio Narusawa è un vero e proprio frigorifero naturale, tanto che fino all’epoca Shōwa (1926-1945) veniva usata per conservare le uova dei bachi da seta in modo tale da evitare che si schiudessero; così facendo, era possibile produrre seta tutto l’anno tirando fuori all’occorrenza le uova dalla grotta la cui temperatura aveva bloccato lo sviluppo dei bachi.

“Rifugiatosi nella malefica grotta del ghiaccio Narusawa, fa prigionieri i bachi e li tiene reclusi in un sarcofago magico.”
Quando ne usciamo, piacevolmente rinfrescati, vorremmo tanto andare a visitare anche la vicina ma non troppo Grotta del Vento Fūgaku, ma manca poco alla chiusura e il nostro tentativo di lotta contro il tempo viene comunque completamente vanificato dall’ennesima insubordinazione dell’autobus che dovrebbe portarci davanti all’ingresso della grotta e invece prende e va da tutt’altra parte (in altre circostanze non avrei problemi ad ammettere di aver preso l’autobus che andava nella direzione opposta, ma mi dispiace, questa volta no, noi eravamo alla fermata giusta, è l’autobus che si è sbagliato). Con mia enorme delusione, per motivi di tempo non solo non riusciamo a vedere la Grotta del Vento ma anche un’altra grotta che aveva colpito il mio interesse quando, passandoci davanti in autobus, ne avevo visto il nome indicato sui cartelli: THE BAT CAVE!
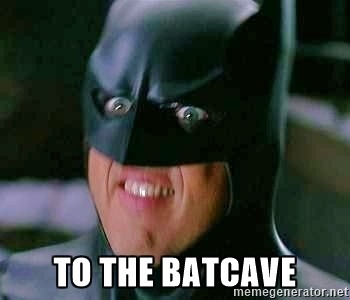
NANANANANANANANA七七七七! Non mi perdonerò mai questa mancanza.
・Cosa si provasse a viaggiare in famiglia. Ci avevo spesso fantasticato, ma non credevo che sarebbe mai arrivato il giorno in cui madre e sorella sarebbero venute a trovarmi a Tokyo, e invece il 29 luglio finito di lavorare me le sono ritrovate davanti all’uscita nord della stazione di Nakano. È stata una sensazione molto strana, devo ammettere, come scoprire che due persone che hai sempre frequentato separatamente in realtà si conoscono. Per lungo tempo ho pensato che, anche semplicemente a causa della notevole distanza geografica, avrebbe sempre regnato l’incomunicabilità tra il mio mondo italiano e quello giapponese. Un po’ come i due livelli di realtà di Aomame e Tengo in 1Q84: due mondi che coesistono e sanno l’uno dell’altro ma non riescono a incontrarsi. Ero sempre stato io a fare la spola dall’uno all’altro, con quello spostamento che mi è già successo di definire non solo geografico ma anche semantico, in cui io in quanto significante rimanevo immutato, ma il mio significato cambiava contestualmente. Il fatto che invece per la prima volta a mettere in comunicazione queste due realtà siano state loro mi ha piacevolissimamente destabilizzato e vedere i loro profili stagliarsi contro panorami giapponesi a me familiari ma a loro inediti è stato molto emozionante. Ricordo la sensazione di attesa di quel venerdì in ufficio lanciando occhiate al telefono perché sapevo che sarebbero atterrate, i magheggi per ingegnarci a comunicare in qualche modo pur avendo l’handicap del wi-fi (grazie signora Nakagawa per averle intercettate prestando loro un telefono e grazie Starbucks di Nakano per la connessione gratuita), l’ansia da oddio non posso andarle a prendere in aeroporto chissà se si raccapezzano con i trasporti pubblici che tra parentesi non so se capirei neppure io, NON CI SONO MAI STATO ALL’AEROPORTO DI HANEDA OKAY T___T, e poi l’intensa emozione di vederle fuori dai tornelli in mezzo alla folla di giappini, robe che manco la Vecchia Romagna.

E poi. Il terrore nel non riuscire ad aprire il cofanetto che conteneva le chiavi dell’appartamento prenotato per loro con Airbnb perché la scaltrissima cinese (OH MA TRA L’ALTRO, ma il mercato immobiliare di Tokyo completamente in mano ai cinesi? Ne vogliamo parlare? D:) non mi ha comunicato il codice. Ma niente paura perché TANTO LA PORTA FINESTRA ERA APERTA, quindi a entrare siam riusciti lo stesso, anche se abbiamo subito sperato di aver sbagliato casa (ma l’appartamento sul sito era bello, lo giuro D: dite che ho fatto male a fidarmi di quella ripresa in fisheye?).
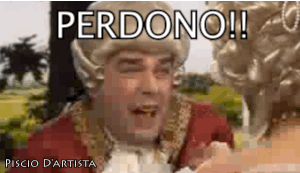
Le prime due settimane che madre e sorella erano qui purtroppo ho potuto accompagnarle in giro solo i weekend perché stavo ancora lavorando, ma ho cercato di approfittarne il più possibile per mostrare loro i posti che più mi sono rimasti nel cuore di Tokyo. E cioè non Tokyo, ma Kamakura e Nikkō lol

Family portrait feat. immancabile maglietta d’ordinanza col Buddha per andare a Kamakura, since 2013. Tra l’altro notevole la scala cromostilistica giallo > giallo+jeans > jeans, che fashion killerz lol

Family portrait 2 feat. l’ancora più immancabile Daibutsuyaki, anche quello fiera tradizione di ogni gita a Kamakura che si rispetti.
In più, con l’occasione stavolta sono riuscito anche a vedere due posti che mi mancavano di Kamakura, lo Hase-dera e la punta estrema di Enoshima, Chigogafuchi.
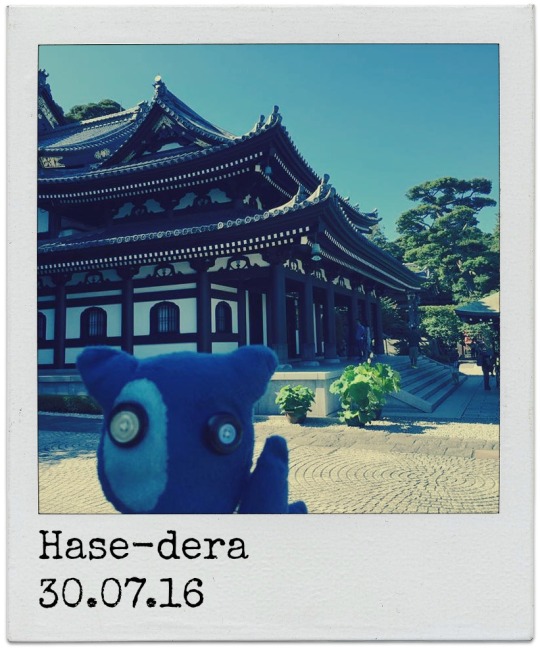
Tempio di scuola Jōdō su più piani risalente al 736, custodisce una statua del bodhisattva della misericordia Kannon in legno intagliato alta 9 metri, ma tanto noi lo ricordiamo per il terrazzamento che dava sulla baia di Kamakura e soprattutto sugli strategici distributori automatici di bevande fresche salvavita lol
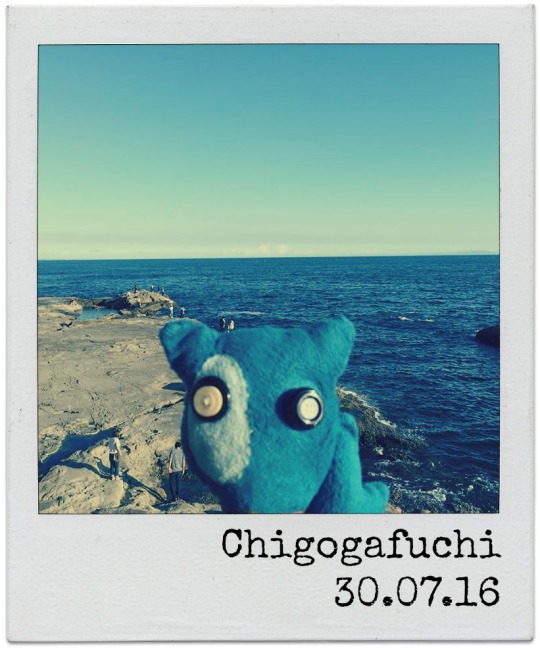
Chigogafuchi, che con un’ignobile ma efficace estensione culturale potremmo rendere con “l’abisso del chierichetto”, è la punta occidentale di Enoshima, e deve il suo nome alla tragica vicenda che vide Shiragiku, giovine fanciullo in servizio presso il tempio Sojo-in, buttarsi da questa scogliera perché divenuto oggetto dell’amore di Jikyū, monaco del tempio Kencho-ji, che alla notizia del suicidio di Shiragiku non esitò a seguirlo tra i flutti. Vedi però che codice deontologico che c’hanno in Giappone pure i preti pedofili.
Per arrivare a Chigogafuchi si percorre un irto sentiero che si snoda attraverso café, negozietti e i vari padiglioni del santuario di Enoshima, di cui per esempio non avevo ancora mai visto il Wadatsunomiya (龍宮, mi rifiuto di leggere questa cosa in altri modi che Ryūgū), dedicato a Wadatsumi (il cui nome compare già nel Kojiki e curiosamente si può trascrivere sia foneticamente con 綿津見 che semanticamente con 海神, ‘divinità del mare’, the more you know), divinità marina dalle sembianze di drago figlia delle divinità creatrici Izanami e Izanagi, o l’Okutsunomiya con il suo dipinto di una tartaruga che come la Gioconda dovrebbe avere uno sguardo in grado di fissarti da qualunque direzione. Cosa che tra l’altro ci siamo cagati solo noi perché tutti gli altri intorno stavano percorrendo il sentiero con Pokémon Go alla ricerca di Pokémon rari, facendoci sentire sfigati e fuori moda.
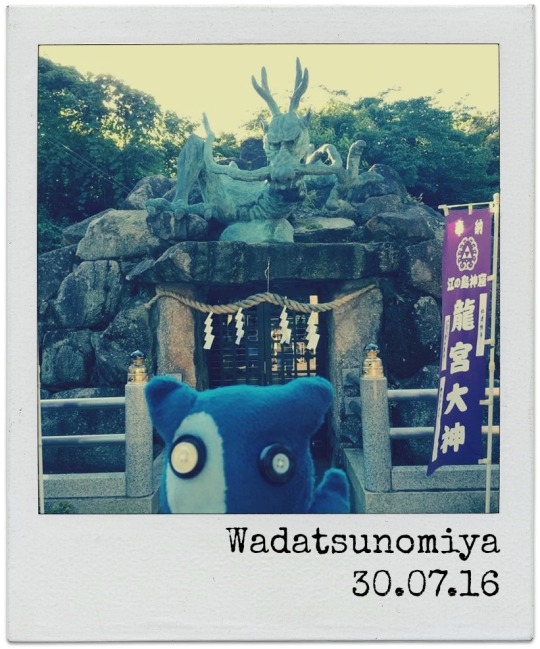
Sè vabbè tutte ste letture pretenziose e poi è una cinesata, pfft.
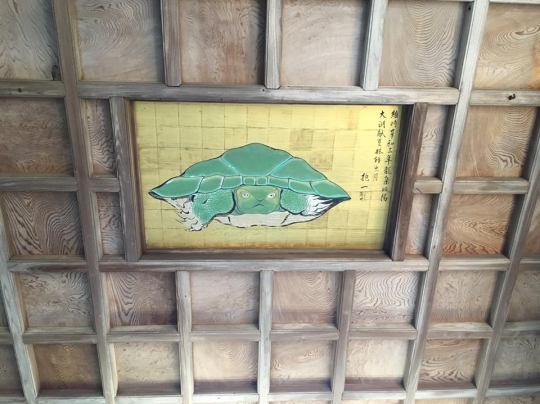
Happō Nirami no Kame (八方睨みの亀, “La tartaruga che fissa tutte le direzioni”), opera di Sakai Hōitsu, 1803. Tartaruga jinja.
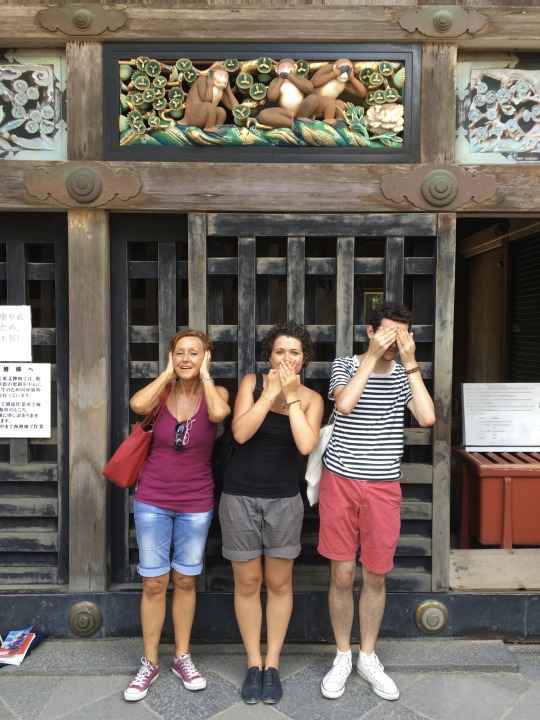
Family portrait 3 @ Nikkō: sono sorda, dico cacate, siccomechesonociecato 🙉🙊🙈 Un sentito ringraziamento alla signora francese che per fare la foto a momenti sfracellava l’iPad a terra, va bene non ridarci la Gioconda ma spaccarci pure gli iPad adesso... e sì che ero quasi vestito da bandiera francese, non capisco questo inasprimento dei rapporti internazionali lol
A parte le zone limitrofe di Tokyo, a onor del vero anche la città ci ha riservato delle piacevoli sorprese. In particolare, un tempio fattomi scoprire da un’amica che è subito diventato uno dei miei preferiti di Tokyo: il Fukagawa Fudōdō.
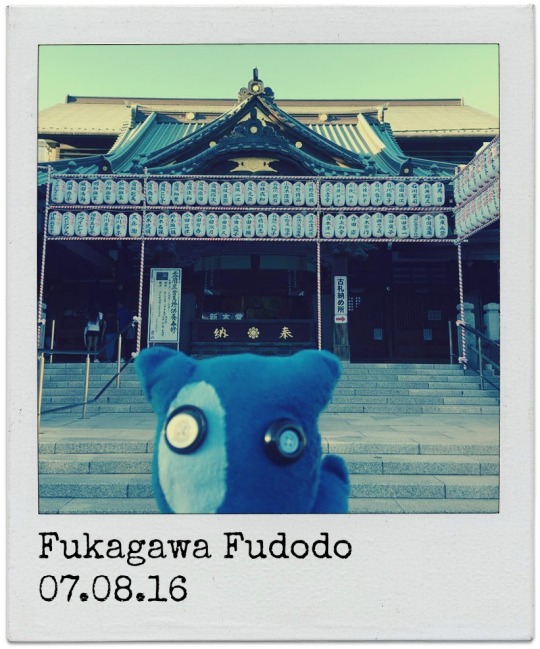
Tempio buddhista della setta esoterica Shingon risalente al 1703, credo si classifichi a buon diritto tra i posti più suggestivi di Tokyo. Preceduto da un vicoletto su cui si affacciano diversi negozietti molto caratteristici e un café che fa dei panini caldi che levati, è dedicato al culto di Fudōmyōō, l’Irremovibile, una delle manifestazioni più intimidatorie del Buddha, ed è qui che tutt’oggi si tiene a orari regolari una delle più suggestive cerimonie a cui mi sia capitato di partecipare finora: il goma 護摩. La prima volta che l’ho sentito mi sono domandato cosa c’entrasse il sesamo (che si dice goma uguale), ma scritto con due caratteri diversi indica una cerimonia di purificazione in cui vengono bruciate delle tavolette di legno su cui sono scritti i desideri dei fedeli, così da estirpare con il fuoco la radice della sofferenza degli stessi. È una cerimonia che oserei definire quasi violenta, perché mentre le fiamme ardono i monaci intonano a voce alta una giaculatoria in quella che dovrebbe essere una versione nipponizzata del sanscrito percuotendo con veemenza dei tamburi taiko che scandiscono il tempo. La cerimonia culmina con la benedizione delle borse dei fedeli, che si mettono in fila e consegnano la propria a un monaco il quale la solleva al di sopra del fumo che esala dalla pira di desideri. Per quanto duri all’incirca una mezz’oretta, si perde totalmente la nozione del tempo e non si può che rimanere turbati dall’incalzare del ritmo dei taiko e dal senso di ieraticità e timore reverenziale che la cerimonia trasmette. Dopo aver assistito a un tale dispiego della potenza del buddhismo, tuttavia, si esce stranamente rinfrancati, come se l’ultimo colpo di tamburo scacciasse via il demone della paura e lasciasse posto, insieme al silenzio, a una ferma imperturbabilità. Ci sono entrato rimuginando sul prezzo della casa in cui stavo valutando di trasferirmi (SPOILER ALERT) che mi sembrava troppo alto, e ne sono uscito pensando “mbè vabbè ma perché, tutto sommato è ragionevole”. Da allora ci sono tornato più di una volta, un po’ per i panini del café lì vicino e un po’ perché devo semplicemente andare poco più oltre il percorso coperto dal mio abbonamento per raggiungere la fermata da cui si accede al tempio, Monzen Nakachō, che nella mia testa rimarrà sempre Monzen Nakatachō perché continuo a confornderla con la zona dov’era il vecchio ufficio della Camera di Commercio Svizzera (SPOILER ALERT), Nagatachō.
Finiti i nostri giretti nel Kantō, sono stato molto contento di essere riuscito a portare madre e sorella anche a Kyōto dall’8 al 14 di agosto (con una deviazione anche a Nara e Uji). Ci tenevo molto un po’ perché credo che sia una tappa imprescindibile per chiunque visiti il Giappone, ma soprattutto perché avendoci vissuto per sei mesi volevo che anche loro potessero vedere i posti che erano stati teatro del periodo forse più bello della mia vita. Mi rendo conto che suoni un po’ eccessivo, anche perché si spera sempre che il periodo più bello della propria vita debba sempre ancora arrivare lol, però per quanto io non mi lamenti per nulla adesso di vivere a Tōkyō e mi ci trovi benone, il periodo passato a Kyōto rimarrà forse per sempre a buon diritto uno dei più felici che io ricordi, probabilmente anche perché ha rappresentato il culmine della mia vita universitaria, che credo per molti resti una nostalgica parentesi dorata che brilla nella memoria indipendentemente da come la vita si sviluppi oltre. Tornare a Kyōto mi ha fatto capire cosa questa città rappresenti per me: un rifugio, un porto sicuro dove attraccare, un luogo dove ritrovare il proprio mabui.
[Il mabui (魂 ‘anima’, ‘spirito’) è un concetto tipico del folklore di Okinawa, di cui sono venuto a conoscenza tramite “Sweet Hereafter”, uno degli ultimi romanzi di Banana Yoshimoto, che forse un giorno dovrei anche leggere lol. Se ho ben capito è la parte più intima, l’essenza di una persona ed è possibile perderla in seguito a diverse circostanze: se non si porta rispetto agli antenati, se si riporta una brutta ferita, se si rimane vittime di un grave shock, eccetera. Chi perde il proprio mabui inizia ad avvertire dolori fisici, ad avere problemi di salute e a non sentirsi bene nemmeno psichicamente. La protagonista del romanzo lo perde in seguito a un incidente d’auto nel quale rimane coinvolta col fidanzato a Kurama, una zona di Kyōto (un posto a caso lol). Lui muore, lei sopravvive anche se ferita gravemente e in seguito all’incidente acquista la capacità di vedere gli spiriti. Il romanzo racconta il lungo processo di guarigione a cui la protagonista va incontro per riacquistare il proprio mabui, appunto. Per me Kyōto è questo: una città che ha senz’altro trattenuto una parte di me, qualcosa di essenziale e quasi originale forse, che ritrovo quando ci metto piede, a cui mi ricongiungo riuscendo a ritrovare una serenità che pochi altri luoghi mi regalano.]
Devo premettere delle scuse: ero così in ansia di mostrare a madre e sorella tutto quello che Kyōto mi aveva donato nel periodo in cui ci avevo abitato che ho cercato di concentrare in 5 giorni quello che avevo vissuto in sei mesi, cosa che per definizione è abbastanza sciocco fare e che mi ha portato quasi a ucciderle trascinandole in bicicletta con 40 gradi da una parte all’altra della città.
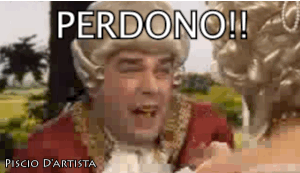
Detto questo, Kyōto è sempre bellissima e sono contento di essere riuscito a trasmettere loro l’amore per questa città, tanto che madre ha detto che in effetti mi ci vedrebbe meglio che non a Tōkyō. Visto che abbiamo visitato i luoghi di interesse principali di cui ho già parlato in passato ed immagino fosse stato noioso già allora per voi leggerne non mi ripeterò e mi limiterò a una carrellata di foto ignoranti lol

「Postcards from distant cities - Kitano Tenmangu」

「Postcards from distant cities - Shimogamo Shrine」

「Postcards from distant cities - Kinkakuji」

「Postcards from distant cities - Ginkakuji」

「Postcards from distant cities - Kiyomizu Temple」

「Postcards from distant cities - Heian Shrine」

「Postcards from distant cities - Nijo Castle」

「Postcards from distant cities - Nara, Tōdaiji」

「Postcards from distant cities - Uji, Byōdōin」
Oltre a rivedere posti meravigliosi che mi erano mancati molto a Tōkyō, si è aggiunta anche una tappa che mi era ancora sconosciuta: Kibune, una località inculatissima che è uno sbatti assurdo raggiungere a nord di Kyōto che si sviluppa intorno al Kifune-jinja, un santuario dedicato al dio dell’acqua e della pioggia, costruito nel punto dove la leggenda vuole che sia terminato il viaggio in barca di una dea dalle sembianze di serpe. Nel caso vi steste chiedendo perché la località si chiami Kibune e il santuario Kifune, la ragione è che nel sistema di scrittura giapponese il simbolo che graficamente trasforma il suono fu in bu è detto “nigori”, cioè letteralmente “impurità”, ed essendo il santuario dedicato al dio dell’acqua si evita di includere un suono impuro come auspicio affinché non venga intaccata la purezza dell’acqua stessa. Vero che prima non ci dormivate la notte e adesso invece sì? lol
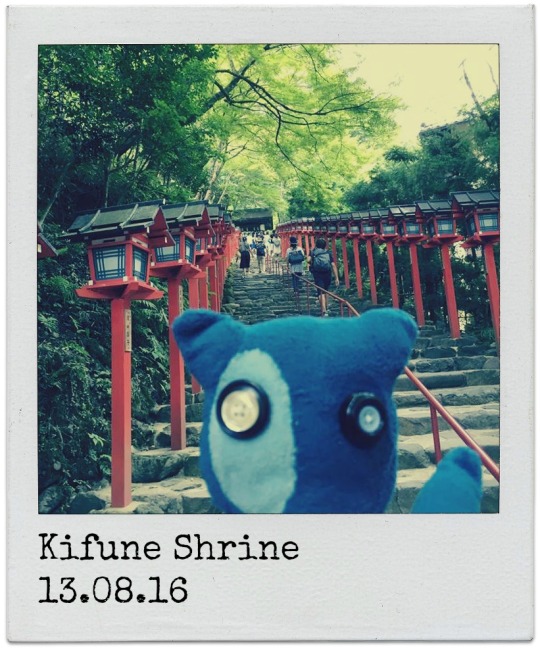
La Lonely Planet, preziosissima come al solito, riguardo questo santuario metteva solo in guardia circa l’orrenda statua equeste in plasticozza all’ingresso, che in effetti c’era...

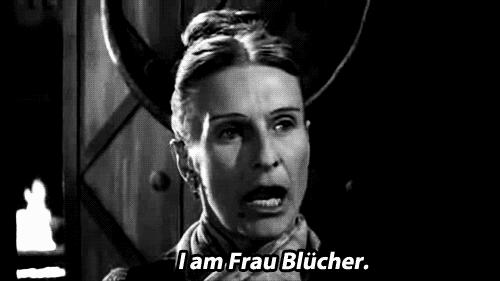
...ma non citava uno dei principali motivi per cui è famoso, i mizuura-mikuji 水占みくじ, foglietti contenenti oracoli che compaiono una volta poggiati sul pelo dell’acqua. Tipo l’inchiostro arcobaleno di quegli album da colorare terribilmente anni Novanta che penso tutti da bambini abbiamo avuto (Fra, se stai leggendo, sappiamo tutti e due a chi legittimamente apparteneva il pennarello arcobaleno).
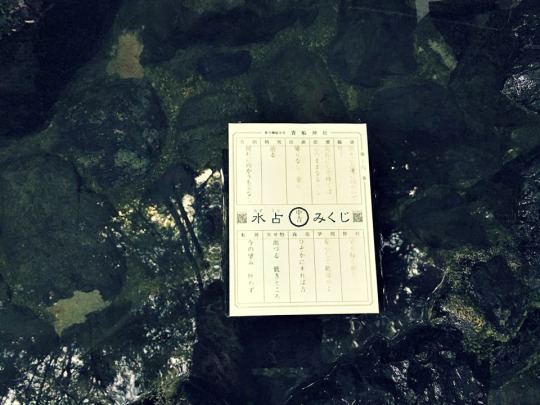
Il mio oracolo diceva “media fortuna”, e se non ricordo male riguardo i traslochi diceva qualcosa tipo ‘bene anche se non come vorresti’, che in effetti ci ha proprio preso lol #benemanonbenissimo
Alla fine di questi giorni a Kyōto, che segnavano anche la fine del viaggio di madre e sorella in Giappone, mi sono ritrovato di sera al Kitano Tenmangu a pensare a tante cose: a cosa avesse significato accompagnarle in quella che è e/o che era stata la mia quotidianità all’estero, a cosa mi aveva portato lì dov’ero, a quante cose erano cambiate nel frattempo e quante invece erano rimaste le stesse. In questo viaggio abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato di cose che non avevamo mai affrontato prima, di valori in cui fermamente crediamo e con i quali siamo cresciuti, di caratteristiche in cui ci riconosciamo da qualsiasi parte del mondo, del passato e del futuro; abbiamo anche litigato ovviamente, perché nelle famiglie normali si litiga anche, indipendentemente da dove ci si trova, ci siamo commossi (ma ai giardini dell’Imperatore, mica come i poracci inzomma) e ci siamo fatti un numero imbarazzante di foto anch’esse imbarazzanti che adesso sono incorniciate sulla credenza in salotto a casa in Italia. Siccome non so bene che sigillo apporre alle sensazioni di quei giorni, chiuderei con le parole che proprio sorella e madre hanno scritto durante il loro viaggio perché credo che lascino in parte trasparire cosa questo viaggio sia stato per loro:

“The reasons why I’ve loved Japan are not so different from the reasons why I didn’t like it. What I think I’ve learnt from this journey is: there are no nationalities but people. Different people have different cultures and to discover them is a good way to come back home and understand ourselves and our way of thinking and communicating, even loving much better, fiving them a different value, maybe. But above all, the biggest teaching after this troubled journey in Japan is: sushi is good, trains on time too, kombinis 24/7 open are awesome, but if you-almond-eyes say “arigato gozaimasu” again I swear I’m gonna kill you”.

“Famiglia a cena: affetti ripresi, abitudini riconosciute, tanto bene ♥”
・Avevo anche COMPLETAMENTE dimenticato che enorme sbatti fossero i traslochi. Complice il fatto che a fine agosto la Camera di Commercio Svizzera ha cambiato ufficio, ho deciso di traslocare a mia volta per essere più comodo con gli spostamenti e anche perché mentre mi dicevo che il mio appartamentino di 14 ㎡ era solo provvisorio e che ne avrei trovato un altro con più calma, prima che me ne accorgessi era già passato UN ANNO / o \ Mettiamola così: se il mio intento era spostarmi in un posto un po’ più grande e pagare meno ho totalmente fallito (l’omikuji ci aveva visto giusto), però non sono insoddisfatto perché ho finito per trovare un posto dove pago uguale ma ho tipo quattro volte lo spazio che avevo prima, il che non è male. Mi è dispiaciuto perché ho dovuto dedicarmi alla ricerca di case e agenzie immobiliari mentre madre e sorella erano qui, ma d’altronde agosto sembrava essere un buon periodo per il mercato immobiliare perché sembra ci siano molti spostamenti, case che si liberano e via dicendo. Mentre prima ero con un’agenzia internazionale che si occupa di fornire case già arredate a prezzi disonesti, questa volta mi sono rivolto a un’agenzia giapponese, comunque disonesta lol, che mi ha messo una pressione addosso che sembrava che si sarebbero trovati senza tetto loro se non avessi preso casa io, e alla fine mi sono ritrovato con un contratto biennale per un appartamento a Koenji sud con un loft che in realtà è un secondo piano a tutti gli effetti visto che ci sto comodamente anche in piedi e ha finalmente realizzato il mio sogno di separare la zona dove mangio da quella in cui dormo, arredata in parte con mobilia che mi portavo ancora dietro dai tempi di Kyōto e per il resto con mobili Ikea tra cui il mio sogno proibito, UN DIVANO ♥ (no non potete capire, il divano è quello spazio liminale tra dover stare seduti su una sedia o per terra e quindi non riuscire a rilassarsi e collassare a letto e quindi non avere chance di rimanere svegli, mi sono sentito privato di una parte fondamentale della mia vita per tutto il tempo che non ne ho avuto uno). Sta cosa che i contratti per le case giapponesi durano minimo due anni è un po’ una rottura di palle, ammettiamolo, ed era la prima volta che avevo a che fare in prima persona con un’agenzia giapponese perché a Kyōto, pur avendoci dovuto avere a che fare, c’era stato il tramite dell’università che aveva aiutato; sono stato comunque felice di notare che sotto vari aspetti rispetto a quell’esperienza stavolta abbia trovato meno difficile l’approccio anche linguistico, mi ha fatto quasi pensare che in tutto sto tempo qualcosa ho imparato, non è stato del tutto buttato lol Un consiglio spassionato: se volete fare sport a fine agosto sceglietevi di meglio che trasportare avanti e indietro per tre chilometri andata e ritorno valigioni pieni dei vostri averi, ma proprio col cuore in mano ve lo dico. Anche se ne è valsa decisamente la pena perché adesso abito vicino a Eva, Anna e Davide e mi fa sempre sorridere pensare che dato che veniamo da città diverse in Italia difficilmente ci saremmo trovati ad essere vicini di casa, mentre qui Little Italy proprio lol Quindi insomma da inizio settembre 2016 sono passato dalla Pacific Nakano Sakaue #301 a una pretenziosa Maison de Koenji #202, una casa su due piani un filino infrattata che solo i corrieri più coraggiosi e intrepidi trovano (loro e le bollette, che quelle non si sa come una via per arrivare a te la trovano sempre), a una decina di dolorosissimi minuti dalla stazione JR di Nakano, da cui si sente passare il treno in lontananza proprio come dalla mia casa in Italia, cosa che ho scoperto tranquillizarmi tantissimo, quasi come il protagonista di questo racconto di Murakami. Al solito l’isolamento termico e acustico sono tremendi, oserei dire ai minimi storici, tanto che me sembra d’avere gente in casa ogni tanto, ma è stata pensata benino perché nonostante abbia dirimpettai da tutti i lati è costruita in modo tale da essere di mezzo piano rialzata rispetto alle abitazioni circostanti, sicché anche se è piena di finestre nessuno ti vede dentro casa. Tipo i castelli giapponesi che da fuori sembrano di un tot piani ma poi all’interno sono di mezzo piano sfalsati in modo da trollare i nemici lol
・E a proposito di castelli, avevo dimenticato la tendenza di ogni città munita di castello di tirarsela per avere quello più antico di tutto il Giappone. Succede questo: per il weekend lungo della Silver Week, dal 17 al 19 di settembre, decido di andare con Y. a Nagoya per la Triennale di Aichi, un festival d’arte internazionale che si tiene ogni tre anni nella prefettura di Aichi, dove ancora non ero stato. Per la sua terza edizione, era stato scelto il titolo “Homo Faber: A Rainbow Caravan”, un titolo molto elegante per giustificare una colorata accozzaglia di varie opere (alcune non le ho capite, però ho trovato molto evocativo l’uso delle figure retoriche - cit.) sparse in diverse location di tre principali aree: Nagoya, Toyohashi e Okazaki.
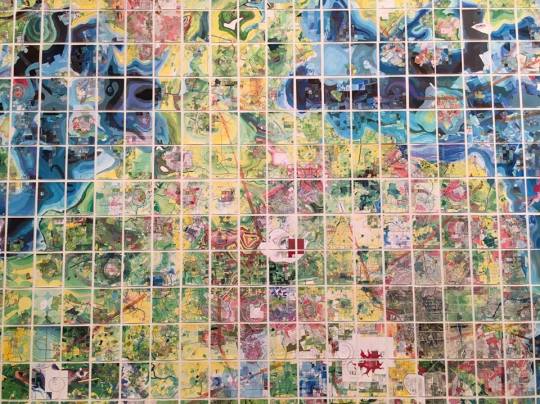
「Jerry’s Map」 © Jerry Gretzinger Collage di 3200 tasselli che compongono una mappa di una città immaginaria, realizzata tra il 1963 e il 1983 con acrilici, evidenziatori, matite colorate, inchiostro.
Come vi dicevo, non ero mai stato a Nagoya, che la Lonely Planet descrive così: “si potrebbe dire che Kyōto è una geisha dalle movenze aggraziate, Tokyo una teenager sicura di sé all’eterna ricerca delle novità più trendy e Nagoya la loro leale sostenitrice. Magari non sarà la più attraente della famiglia, ma con intelligenza, perseveranza e senso del dovere fornisce alle altre due la ricchezza che permette loro di vivere il tipo di vita che hanno scelto.”
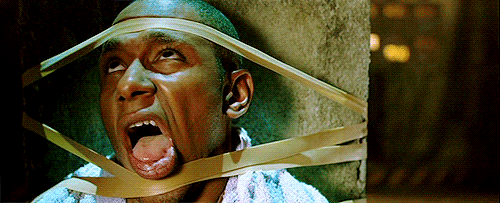
Boh guardate io sinceramente non saprei dirvi di che sostanze abusino quelli della Lonely Planet, però se qualcosa vogliamo salvare di questa loro sparata è questo: se per diversi aspetti, dal piano urbanistico al tipo di attrazioni che offre, si può dire che Nagoya ricordi più Tokyo, d’altra parte è innegabile che si respiri un’atmosfera più tranquilla, rilassata e leggera, che mi ha ricordato per varie ragioni le città del Kansai. Un’atmosfera che perfino in metropolitana è riscaldata da familiari caldi timbri latini perché, credo unico caso in tutta la nazione, gli annunci non sono solo in giapponese, inglese, cinese e coreano ma pure in PORTOGHESE, che la prima volta che l’ho sentito vi giuro mi è quasi preso un colpo, WTF?? Però pare che sia pieno così di brasiliani, ma proprio a grappoli, che lavorano per la Toyota a Nagoya, e che quindi sia stato deciso di integrare anche il portoghese nelle lingue degli annunci sui mezzi pubblici.

In quanto città turisticamente non proprio esaltante non poteva mancare la Torre della Televisione elevata a sito turistico anche qui come a Sapporo, con la variante che stavolta pure questa come i castelli che vedremo nei giorni successivi si autoproclama la più vecchia di tutto il Giappone, completata nel 1954 e distrutta da Godzilla dieci anni dopo.
Visto che once a LICAO always a LICAO, uno dei motivi per i quali mi incuriosiva andare a Nagoya era visitare l’Atsuta-jingū, un santuario dove si dice sia custodita la kusanagi-no-tsurugi (草薙の剣, ‘la spada che falcia l’erba’), una delle tre insegne imperiali insieme allo specchio di Amaterasu (custodito a Ise, been there done that) e alla gemma ricurva (custodita nel Palazzo Imperiale di Tokyo, dove però ancora non mi hanno invitato lol). La leggenda rintracciabile nel Kojiki vuole che il dio Susanoo l’avesse trovata in una delle code del drago a otto teste Yamata no Orochi da lui ucciso. Passò poi per diverse mani fino ad arrivare a Yamato Takeru, leggendario eroe che, trovatosi intrappolato in un cerchio di fuoco appiccato da un nemico che gli aveva teso un agguato in un pascolo, scoprì che la spada poteva controllare il vento e la usò per estinguere le fiamme fendendo l’aria tra l’erba, da cui appunto il nome.

La spada Kita Kita?? La danza Kita Kita!!
Insomma vabbè tutta sta storia e poi tanto comunque non la potete vedere, però vabbè willing suspension of disbelief e te passa la paura.
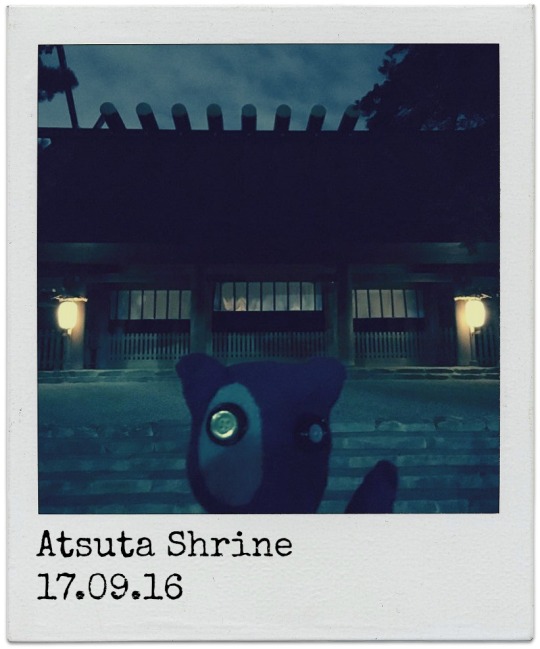
Tappa imprescindibile durante una gita a Nagoya è chiaramente il castello, uno dei simboli della città, fatto costruire dal terzo unificatore del Giappone Tokugawa Ieyasu tra il 1610 e il 1614 e ricostruito poi nel 1959 dopo che era stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, anche lui da Godzilla.
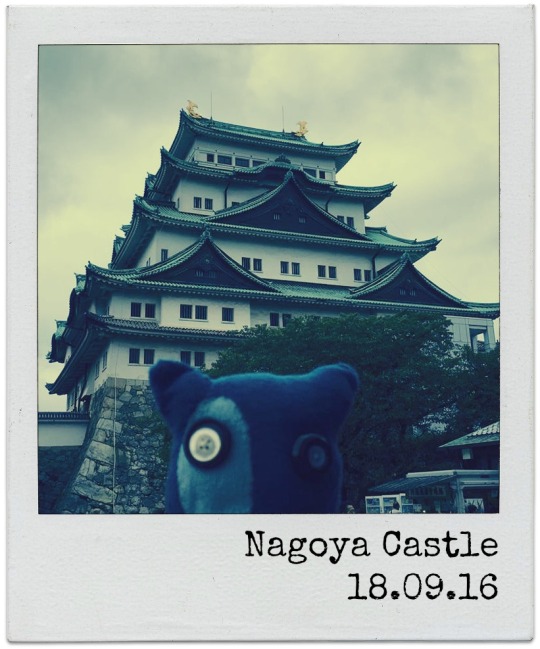

E adesso non c’è più il castellobbello.
Caratteristiche del castello di Nagoya sono le decorazioni poste alle estremità del tetto che raffigurano degli shachi (鯱), animali marini che si credeva avessero il potere di evocare l’acqua così da proteggere dal fuoco (quello appiccato dai nemici tanto per fare un esempio) e che letteralmente dovrebbero essere delle... orche? O_ò

Free Willy, ti ricordavo un filino diverso...
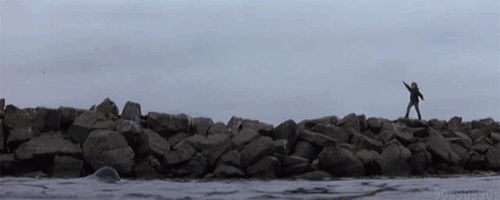

Gli shachi sono talmente tipici che ve li ritroverete in tutte le salse nei negozi di souvenir e persino nei cartelli della metropolitana.
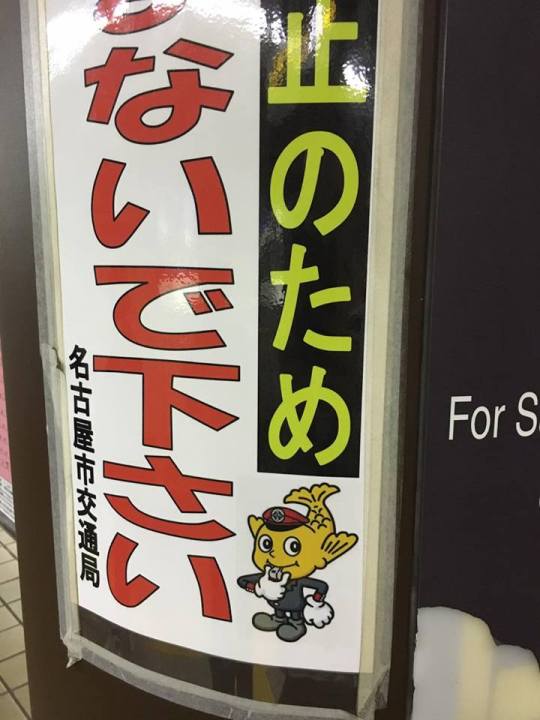
Ora, io non faccio il graphic designer, ma... non è profondamente sbagliato che quello che dovrebbe essere il corpo sia parte della faccia e che abbia un altro corpo umanoide? È mostruoso D:
A una mezz’oretta di treno da Nagoya si trova la tranquilla cittadina di Inuyama. Attraversata dalle placide acque del Kisogawa, considerato il Reno giapponese, lungo le cui acque si pratica ancora la famosa attività dell’ukai (鵜飼い ‘pesca col cormorano’), ospita anch’essa un castello, uno dei cinque nominati patrimonio nazionale insieme a quelli di Himeji, Hikone, Matsumoto e Matsue. Beh dai, me ne mancano solo due da vedere, siamo a buon punto lol
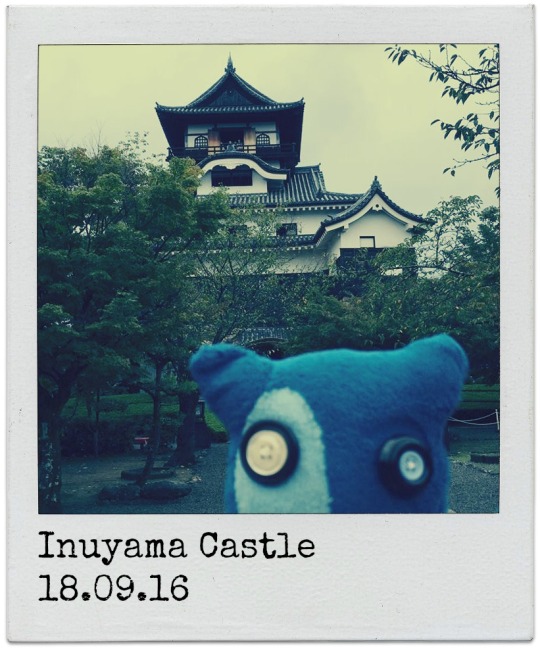
Il maschio è datato 1537 ma si è sviluppato da un forte difensivo risalente addirittura al 1440, e questo dovrebbe fare del castello di Inuyama il castello più antico del Giappone.
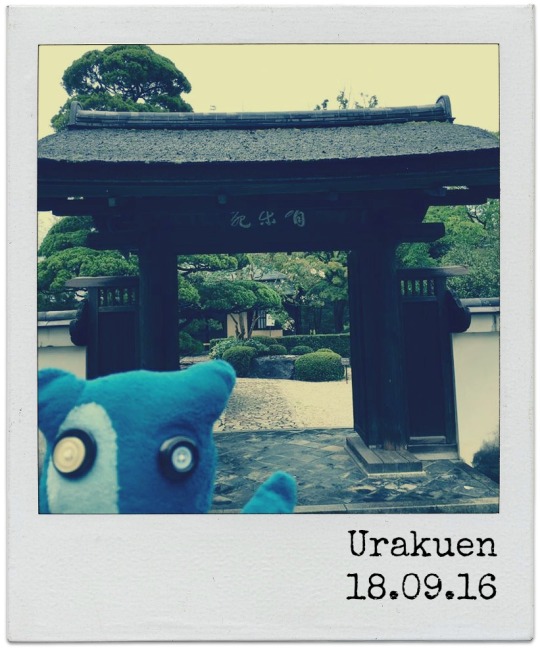
Poco distante, si trova poi un bel giardino, l’Urakuen 有楽苑, che prende il nome da uno dei fratelli minori di Oda Nobunaga, primo grande unificatore del Giappone, Oda Urakusai, che abbandonata la carriera militare in tarda età si fece monaco presso il Kenninji di Kyōto, dove si dedicò all’arte della cerimonia del tè e fece costruire una casa da tè che venne poi trasferita nel suo villaggio natìo, Inuyama, proprio all’interno dell’Urakuen. Il nome di questa casa da tè, Joan (如庵), sembra sia un gioco di parole: riprenderebbe infatti il nome cristiano che Oda Urakusai scelse per se stesso dopo essersi convertito al Cristianesimo nel 1588, Johan appunto.
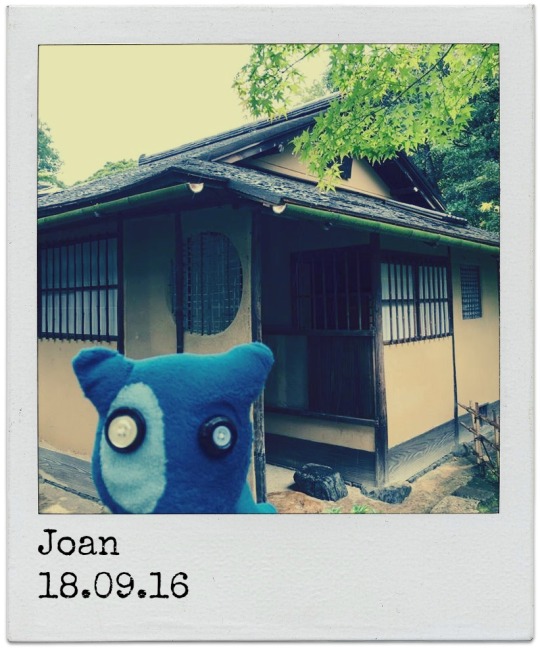
Considerata una delle tre più belle case da tè insieme alla Mittan del Daitokuji e alla Taian del Myokian, entrambi a Kyōto, non so perché ma quando leggo che “è stata trasferita a Inuyama” me lo vedo proprio Oda Urakusai che la caccia in borsa tipo mago Merlino quando trasloca.

Hockety Pockety Wockety Wack, Abra Cabra Dabra Da, se ciascun si stringerà il posto a Joan si troverà ♪

On our way back from Inuyama... dopo Shimonita, un’altra imperdibile tappa per viaggiatori maliziosi.
Ora, permettetemi di aprire una parentesi Instagram dato che, viaggiando con un giapponese, ovviamente non potevamo non passare ore a discutere principalmente di cosa e dove avremmo mangiato. Questa è una cosa che mi lascia sempre abbastanza sconcertato: nonostante da italiano mi ritenga parte di un popolo che dà importanza alla buona tavola, trovo comunque sempre un filino disarmante che per i giapponesi la priorità in ogni viaggio sia il cibo, ma a livelli che quando raccontate a qualcuno che andate da qualche parte, nella maggior parte dei casi la prima domanda non sarà “cosa vai a vedere?” ma molto più verosimilmente “cosa si mangia di buono da quelle parti?”, e molti dei commenti e/o dei suggerimenti riguarderanno molto più spesso cose da mangiare che non da visitare. Ad ogni buon conto, sono stato ben felice di assaporare quello che la cucina di Nagoya aveva da offrire: in particolare, lo hitsumabushi 櫃まぶし, una scodella di riso con anguilla grigliata in cima che andrebbe mangiata facendone tre diverse porzioni in una ciotola a parte, la prima volta gustandola così com’é, la seconda aggiungendo wasabi e cipolla, e la terza versandoci sopra tè o brodo di pesce; e il morning, questa sorta di colazione/brunch che come abitudine è tipica di Nagoya e che prevede un pasto a base di caffé e toast (tipicamente l’ogura toast, pane tostato con crema di fagioli rossi). Con Y. abbiamo ordinato il morning al Komeda Café, una catena nata proprio a Nagoya e famosa per il suo Shiro no Whirl, una sorta di pasta dolce con gelato alla vaniglia sopra e sciroppo. Per carità, un negozio di questa catena c’è anche vicino a casa mia per cui non è che servisse andare fino a Nagoya, però nel luogo d’origine fa sempre un effetto più autentico lol

#instafood #instagood #foodporn #foodie
Dai, per risollevarmi da questo scivolone gustoso ma di cattivo gusto e ridarmi un tono vi lascio con degli scatti dell’opera che forse mi è piaciuta di più all’Aichi Triennale, “Art & Breakfast”, un progetto di Mitamura Midori che consiste in una serie di installazioni che combinano oggetti quotidiani o comunque di facile reperibilità e citazioni per creare uno spazio che l’osservatore possa avvertire come familiare e in cui ritrovarsi, che adesso che ci penso è un po’ quello che anche a me piacerebbe che questo blog potesse essere sia per me che lo scrivo che per quei due che lo leggono (ciao mamma, ciao papà lol). Motivo per cui, anche se come è successo mi ricapiterà sicuramente di non riuscire ad aggiornarlo per lungo tempo, cercherò di trovare il tempo per continuare a scriverlo.

“My grandma said: ‘Your failures that happened in a world will be settled in that world as well’.” 「私のおばあちゃんは言いました『世の中で起きたことは世の中の方でおさまる』と」
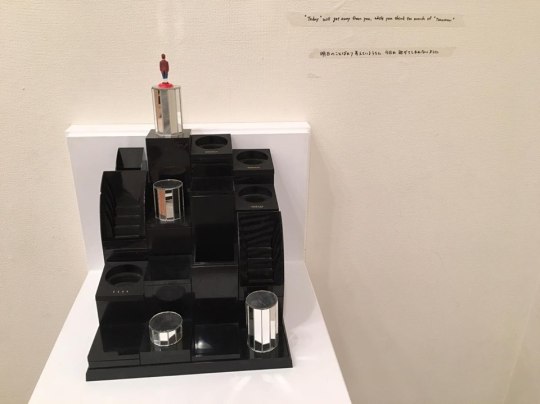
“‘Today’ will get away from you, while you think too much of ‘tomorrow’.” 「明日のことばかり考えているうちに今日が逃げてしまわないように」
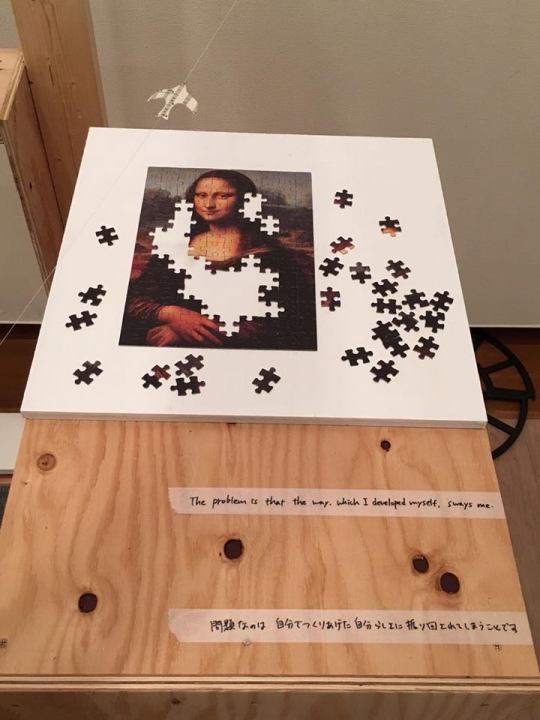
“The problem is that the way, which I developed myself, sways me.” 「問題なのは自分でつくりあげた自分らしさに振り回されてしまうことです」
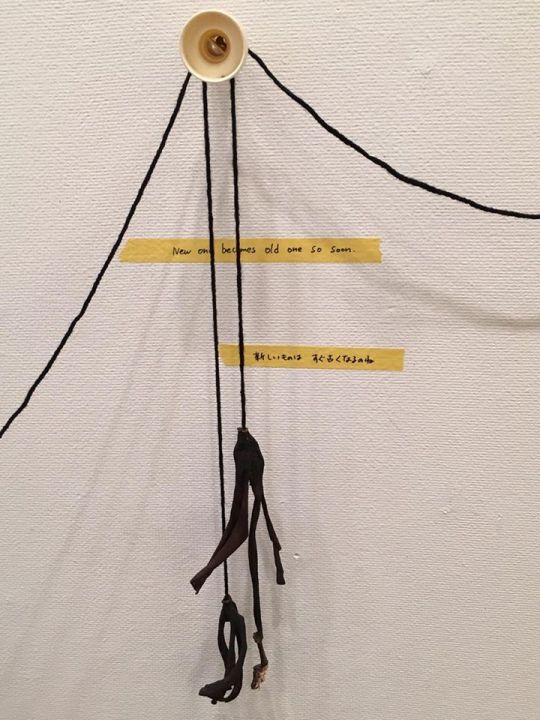
“New one becomes old one so soon.” 「新しいものはすぐ古くなるのね」
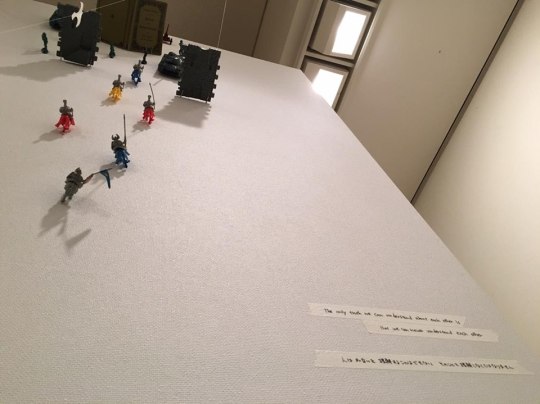
“The only truth we can understand about each other is that we can never understand each other” 「人はお互いと理解することはできないとのことを理解しなくてはなりません」
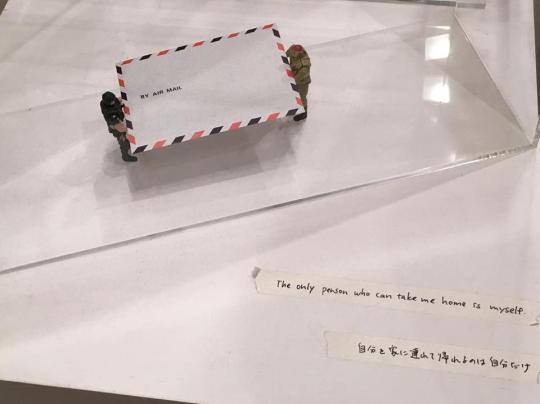
“The only person who can take me home is myself” 「自分を家に連れて帰れるのは自分だけ」
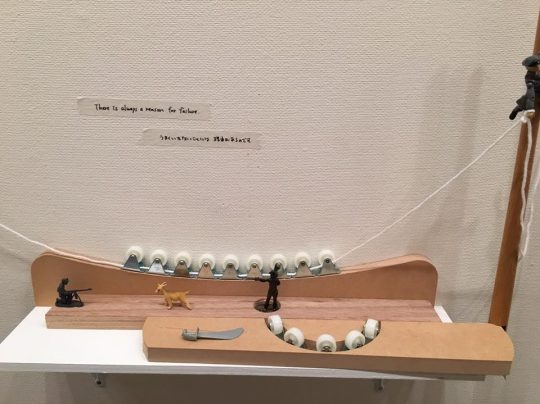
“There is always a reason for failure” 「うまくいかないことには理由があるのです」
1 note
·
View note
Text
Cose che animano l’arrivo della bella stagione
Come una guerra è tornata la primavera e sebbene avanzi a grandi passi verso l’estate la sera c’è ancora quel bel frescolino che ti permette di dormire con le finestre aperte senza dover ancora ricorrere all’aria condizionata. Il passaggio dal piumone alla coperta è stato traumatico a causa dell’innegabile valore affettivo che immagino chiunque di voi riconosca a un simile oggetto e ho cercato di rimandarlo il più possibile, ma alla fine la settimana scorsa mi sono proprio dovuto arrendere - anche se non rinuncio ancora alla seconda coperta un po’ felpatina che forse si chiama copriletto in italiano, ma che nel dubbio chiameremo Ugo.
Il passaggio stagionale da piumone a Ugo poteva essere lo highlight più intenso di queste ultime settimane e sarebbe comunque già stato sufficientemente emozionante per i miei standard, e invece non ne sono mancati anche degli altri. Per esempio:
☀ Sono stato vittima di un disservizio!1!!!111!!!!!1! No okay lo sto volutamente esagerando, diciamo che per gli standard di apparente subordinazione a mio parere non necessaria di chi lavora nei servizi ho beccato ‘na stronza, STRANAMENTE IN COMUNE, oh ma tutti lì eh. Background: è stato anche il tema di un talk-event della camera svizzera ma in pratica da quest’anno la burocrazia giapponese si dà una risistemata e manda a tutti un codice numerico identificativo unico, MyNumber, che dovrebbe facilitare i processi amministrativi o boh, io quella volta mica ho ascoltato, forse ero in bagno. Dopo aver ricevuto le pratiche e una scheda provvisoria con suddetto codice via posta, potevi spedire al comune fototessere e altro materiale necessario affinché preparassero la card effettiva che saresti poi potuto passare a ritirare una volta giuntati sempre via posta la notifica dal comune stesso. Beh, mando tutto a fine gennaio e ancora nulla, non che abbia fretta ma già che ho spedito quasi quasi vorrei averla sta card, ma leggo che te la tengono in custodia solo fino al 31 maggio - vuoi che non abbia capito come funziona o che abbia frainteso qualcosa e che questi siano lì che aspettano che io vada a ritirarla? Decido di passare e chiedo a sta vecchia dove distribuiscono i numeri per lo sportello corrispondente, ma lei vuole saperne di più circa i motivi che mi spingono a visitare il suo luogo di lavoro: “È per la card di MyNumber, ho spedito tutto tempo fa e mi domandavo se si poteva già passare a ritirare...” “Quando ha spedito?” “Tipo a fine gennaio” “E non le è arrivato niente dal comune da allora?” “No, per quello sono passato, mi chiedevo se avevo sbagliato a fare qualcosa...” La vecchia mi guarda con sufficienza e fa: “Beh deve capire che siete tanti e stiamo procedendo con ordine”, e poi attacca un “moooooo” che per abitudine penso sia il prodromo di “mōshiwake arimasen” (“sono mortificata”) e invece è l’inizio di “mō sukoshi omachi kudasai” (“aspetti ancora un po’”). Al ché il mio tentativo di difendermi dalle sue scuse con un “ma no ma no si figuri” perdono improvvisamente di senso nel contesto di tale dialogo, ma d’altra parte sono troppo avvezzo ai giapponesi che si scusano per averti chiesto se hai la tessera del supermercato per non trovare inaccettabile che questa non l’abbia fatto lol Cioè guarda che sono venuto apposta perché so’ quattro mesi che non ve fate sentire, se proprio non vuoi scusarti almeno non mi tratti da ritardato, ma che è oh.
☀ Con il bel tempo sarebbe bella qualsiasi zona di Tokyo, anche la più grigia e piena di palazzoni, ma è ancora più piacevole approfittare di giornate del genere per spostarsi anche solo appena fuori dalla metropoli dove c’è più verde e la vita scorre più tranquilla. In particolare Motosumiyoshi, piccola cittadina tra Tokyo e Yokohama, dove non sarei probabilmente mai capitato se non mi ci avessero invitato la Vale ed Ema e dove ho effettivamente rischiato di non capitare mai perché sono salito sul treno sbagliato e me ne sono accorto quando ormai ero praticamente a Yokohama, ma che problemi ho. Situata insieme alla vicina Hiyoshi tra i fiumi Tama e Tsurumi tipo la Mezzaluna Fertile tra il Tigri e l’Eufrate, Motosumiyoshi è una deliziosa cittadina proprio da scampagnata domenicale che ruota principalmente intorno a una strada di negozietti (tra cui Kaldi, il mio beneamato fornitore di prodotti alimentari d’importazione con caffé gratuito all’entrata, e una bancarella che vende ciambelline con la faccia di animaletti chiedendoti che faccia vuoi mangiare) INSPIEGABILMENTE e INACCETTABILMENTE intitolata ai Musicanti di Brema, ma perché?

Ci sono, esistono davvero, vi giuro. Allego primo piano frontale e profilo, come nelle foto segnaletiche.
☀Ho scoperto casualmente sfogliando una rivista che a Nakano Broadway, nella via di negozi vicina a dove abito e dove vado sempre a comprarmi da vestire, c’è il Bar Zingaro, il bar dell’artista Takashi Murakami, cioè è sempre stato qui a un tiro di schioppo e non lo sapevo? Emozionatissimo vado in esplorazione, messo in guardia però da Anna che dice che fa schifo. Beh, faceva proprio schifo - oddio il caffé non era neanche male, ma insomma c’eran due quadri di Murakami in croce attaccati alle pareti di un asettico e severo locale in legno abbastanza impersonale, Takashi sbattiti un attimo va’ là.

Bar Zingaro: coffee, drinks, art e baristi che ti guardano con disprezzo quando entri e ti si rivolgono come se avessi fatto loro un dispetto a entrare. Ma fate un doppio lavoro in comune a Nakano per caso?
☀ A marzo avevo partecipato a un festival di cinema post-Fukushima e mi ero innamorato del film “Umi Yama Aida - Ise Jingu no Mori kara Hibiku Message” (うみやまあひだ ~伊勢神宮の森から響くメッセージ~, “Tra mare e montagna - Un messaggio che risuona dalla foresta del Santuario di Ise”) del fotografo Miyazawa Masaaki, e avevo scoperto che per una settimana a maggio ci sarebbe stata un’esposizione gratuita delle foto tratte dal film in un grande magazzino a Nihonbashi.
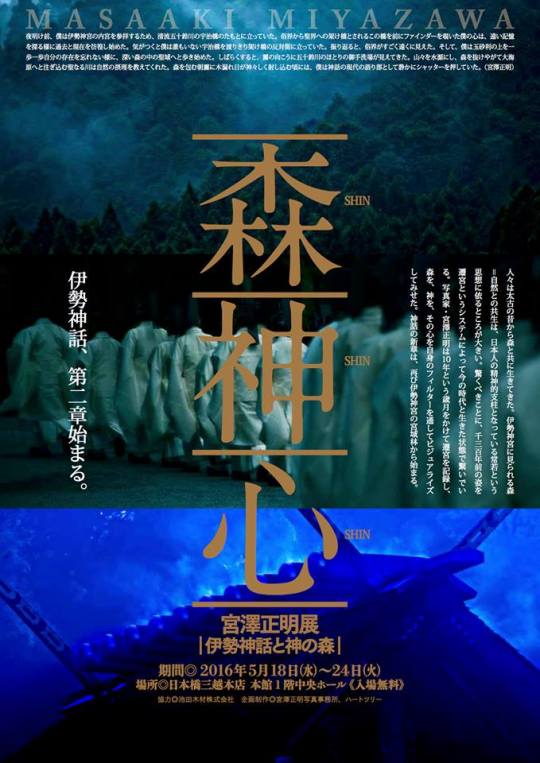
ShinShinShin. Oddio che nome derpino ♥
Beh, ci vado e c’è sto tizio che sta distribuendo dei volantini e dando un po’ di informazioni sulle opere. Guardo il volantino e c’è la foto di questo Miyazawa, inquietantemente somigliante al signore dei volantini. Temporeggio un po’ ed eccolo che si fa avanti per chiedermi se sono mai stato all’Ise Jingu. Gli rispondo di sì e poi gli chiedo timidamente se è proprio lui il signor Miyazawa, e sì, è proprio lui, in carne ed ossa. Mi si fonde completamente il cervello e inizio a balbettare complimenti sul suo film, lui si scusa (SI SCUSA, mica come la vecchia stronza in comune), mi dice di guardarmi pure intorno con calma, io cerco intanto di recuperare la mia già scarsissima proprietà di linguaggio, ma eccolo che torna per portarmi del materiale informativo in inglese, io lo ringrazio e gli chiedo se è sempre lì alla sua mostra, lui mi dice che dipende dai suoi impegni, poi gli arriva una telefonata, io mi riprometto che appena avrà finito di parlare al telefono gli chiederò se possiamo farci una foto insieme ma la telefonata, presumibilmente di lavoro, se lo porta via e non ci rivedremo mai più. Ho già iniziato a dimenticare il suo volto e la sua voce, tutto quello che mi resta di lui è del materiale informativo in inglese. Grazie vita di prenderti sempre gioco di me in questo modo.
☀ Quest’anno ricorrevano i 150 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, motivo per cui la Camera di Commercio Italiana stava preparando un eventone a tema da ormai quasi un anno (è stato l’ultimo progetto sul quale avevo lavorato ancora da stagista, pazzesco). Anche solo per quest’ultimo motivo mi sarebbe piaciuto contribuire e l’occasione si è presentata quando ho saputo che c’era bisogno di interpreti per gli stand delle varie aziende che sarebbero state presenti. Mi sono ritrovato così per due giorni insieme a due ragazzi giapponesi che parlavano italiano almeno tremila volte meglio di come io parli giapponese (usavano correntemente il congiuntivo, mi sono commosso) allo stand di Mirabilia, il progetto europeo di siti UNESCO, per quello che avrebbe dovuto essere un servizio di interpretariato per preparare il quale adesso so dire cose improponibili tipo ‘schiniere’, ‘armilla’, ‘tufo’, ‘rada’, ‘pietra sedimentaria’ e svarie altre parole che non sapevo nemmeno cosa significassero in italiano, e invece alla fine purtroppo/per fortuna si è trasformato in una semplice spiegazione delle brochure che distribuivamo visto che i nostri espositori sono stati i primi a disertare il nostro stand per girarsi l’evento, lol?

E poi scopri che sono venuti a trovarti al tuo stand da SCHIO. Vicentini di tutta Tokyo unitevi! © Courtesy of C.N. [Con il guerriero di Capestrano, dolorosa ragione per la quale ho dovuto sbattere la testa contro il lessico militare giapponese senza nemmeno conoscerlo in italiano lol Ho provato a convincere la gente che passava al nostro stand a farcisi una foto insieme nel tentativo di rendere la visita più interattiva, ma credo di essere stato l’unico a cadere nella sua stessa trappola D:]
L’evento è stata una cosa colossale a Roppongi Hills, nella zona soldi di Tokyo, con più di 50.000 visitatori e tantissimi ospiti che si sono susseguiti sul palco di Roppongi Arena intorno al quale erano distribuiti i numerosi stand e sul quale tra gli altri si è esibito ZUCCHERO, ma che fine aveva fatto?

Il momento in cui sotto il cielo di Tokyo senti cantare “baila morena sotto questa luna piena” e non ti tornano tutti i conti lol © ICCJ
È stato buffo tra l’altro perché tra i 50.000 visitatori c’erano anche persone che avevo conosciuto tramite la Camera di Commercio Svizzera, che a vedermi lì sono andate un attimo in confusione quasi quanto me con Zucchero, ma d’altra parte aveva forse più senso che fosse lì in realtà lol Mi mancava davvero un sacco lavorare con lo staff di ICCJ, e sebbene il mio contributo sia stato veramente infinitesimale in confronto al lavoraccio disumano che si sono sciroppati loro, essere lì durante l’evento, correre avanti e indietro scaricando e caricando roba, violando con carrellini stracarichi i pavimenti della Tokyo bene, è stato proprio emozionante. 皆さん、お疲れ様でした。
0 notes
Text
Cose con cui riscoprirsi viaggiatori
Mentre inizio a scrivere questo post mi sento come il tizio della pubblicità di Costa Crociere, la vacanza che ti manca. Dopo appena due giorni in ufficio di ritorno dalla Golden Week, probabilmente il periodo più lungo di ferie durante l’anno lavorativo giapponese (e che, giusto perché non fraintendiate, quest’anno è constato di 3 + 3 giorni di riposo intervallati da un comodo giorno lavorativo in mezzo alle palle, giapponesi ma prendetevela una settimana intera per stare a casa, Madonna oh), mentre fuori piove l’unica cosa che vorrei fare è piantarmi in vasca da bagno a piangere.
Durante questa Golden Week ho riscoperto il significato della parola ‘viaggiare’, cosa che, mi sono reso conto con mia stessa sopresa, non mi capitava da un po’ di tempo. Sebbene nel giro di appena quattro mesi abbia fatto due volte avanti e indietro tra Giappone e Italia, era un po’ che non facevo i bagagli per andare in un posto sconosciuto a riempirmi gli occhi di paesaggi mai visti prima. Stando in Giappone per un tempo limitato dal periodo di validità del mio visto mi sembra sempre di essere ‘in viaggio’ - impressione rafforzata dal fatto che per mancanza di spazio ho le valigie appoggiate in casa e di conseguenza non riesco mai davvero ad allontanare il pensiero che arriverà il momento di riempirle di nuovo. Sarà per questo che avevo dimenticato cosa volesse dire invece andare effettivamente alla scoperta di qualche luogo di cui non si è ancora mai messo piede, animati da quel fremito di eccitazione che accompagna sempre ogni partenza. Meta designata la prefettura di Okayama, nel profondo sud dello Honshū, la cui omonima città è in realtà servita da base per esplorare poi anche alcune zone limitrofe, più precisamente Himeji, Kurashiki, Naoshima e Takamatsu.
A spingermi così a sud non solo il desiderio di cambiare completamente aria rispetto a Tōkyō, ma anche il tentativo di incontrare a metà strada Chiara, ora in stage a Fukuoka, nel Kyūshū, per quello che realizzeremo solo successivamente essere il nostro viaggio di laurea lol. Viaggio che tra l’altro può vantare anche un motto: da qualche settimana prima della partenza, infatti, vediamo spuntare sui treni dei cartelloni pubblicitari riguardanti Okayama che recitano: “春るるる、人うららか、岡山” (‘harurururu, hito uraraka, Okayama’, che tradotto suona vagamente come ‘primaverararara, persone cordiali e spensierate, Okayama’). Ora, sicuramente mi manca il background culturale per cogliere la genialità dello slogan, ma...? Non avendo la certezza che il wi-fi permetterà al telefono di Chiara di collegarsi a internet, decidiamo di darci appuntamento la mattina del 3 maggio all’uscita est della stazione di Himeji, da cui partirà il nostro tour, un po’ in stile “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”.
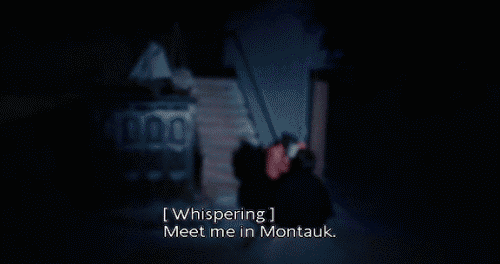
Grazie allo Shinkansen, il treno superveloce, percorro lo Honshū quasi da un capo all’altro in 3 orette e osservo il paesaggio farsi via via più rurale. Mi trema un po’ il cuore quando passiamo per Kyōto, e sbirciando la stazione mando un messaggio al gruppo di amici kyotoiti su Line promettendo che tornerò presto. Insomma, mi sembra doveroso avvertirli del pericolo in modo che siano preparati e non si facciano trovare, ecco. Scendo a Himeji e aspetto Chiara il cui treno arriva con cinque-dieci minuti di scarto rispetto al mio, curiosamente con la stessa identica dinamica di quando ci davamo appuntamento in stazione a Venezia e i miei treni arrivavano costantemente cinque-dieci minuti prima, ma d’altra parte è bello poter avere delle certezze nella vita ovunque ci si trovi lol Himeji in realtà la vedo per la seconda volta, ma durante la mia prima visita nel 2013 il castello che la rende famosa era in ricostruzione, per cui non è che me la fossi goduta proprio tantissimo. Con i lavori conclusisi nel 2014, finalmente il castello si mostra in tutta la sua bellezza e il suo biancore, che probabilmente sarebbe stato accecante se ci fosse stato il sole, ma (fortunatamente?) lo visitiamo sotto un cielo striato da nuvoloni che sembrano quasi dipinti a inchiostro e che grazie al cielo aspettano la fine della visita per alleggerirsi della pioggia di cui paiono minacciosamente carichi.
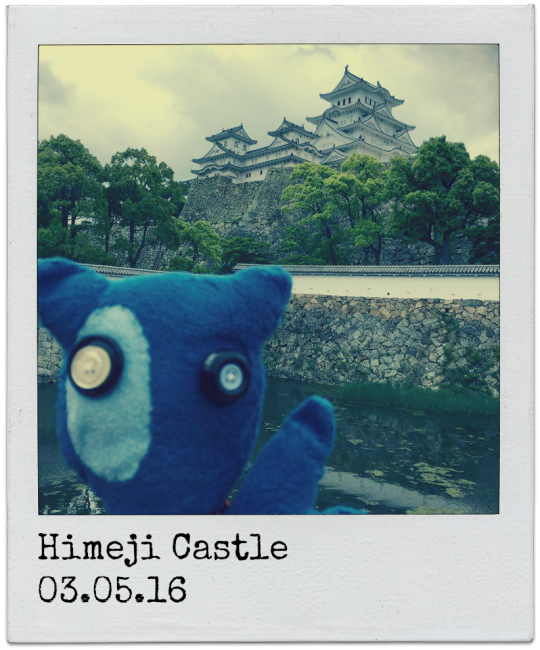
Edificato nel XVI secolo per volere di Toyotomi Hideyoshi e passato poi in mano a Tokugawa Ieyasu, il castello di Himeji è conosciuto anche con l’epiteto di ‘shirasagi’ (白鷺, airone bianco) proprio in virtù della sua candida sagoma appollaiata sugli imponenti bastioni. Tra le misure difensive, oltre a frecce e dardi infuocati, si possono ancora vedere feritoie da cui venivano gettate acqua e olio bollente sui nemici, ma la più efficace rimane la nostra incapacità di capire da dove si entrasse che ci ha portato a girare intorno al castello un buon quarto d’ora prima di realizzare dove fosse effettivamente l’accesso. Una fortuna non essere nati ai tempi dei signori della guerra che spadroneggiavano su una terra in tumulto eh, l’avrei vista malino.

Lasciata Himeji e il suo castello, ci spostiamo verso Kurashiki, un piccolo borgo a una decina di minuti da Okayama che per i suoi canali dovrebbe vagamente ricordare Venezia. O almeno SuZhou. Se la distanza da Okayama è solo di una decina di minuti, purtroppo da Himeji ci vogliono quasi 2 ore con i treni normali JR, per cui optiamo ancora per lo Shinkansen in modo da dimezzare i tempi di spostamento, anche se ne prendiamo uno più scrauso, e il declassamento si nota immediatamente perché in carrozza stavolta hanno anche i bambini che piangono lol
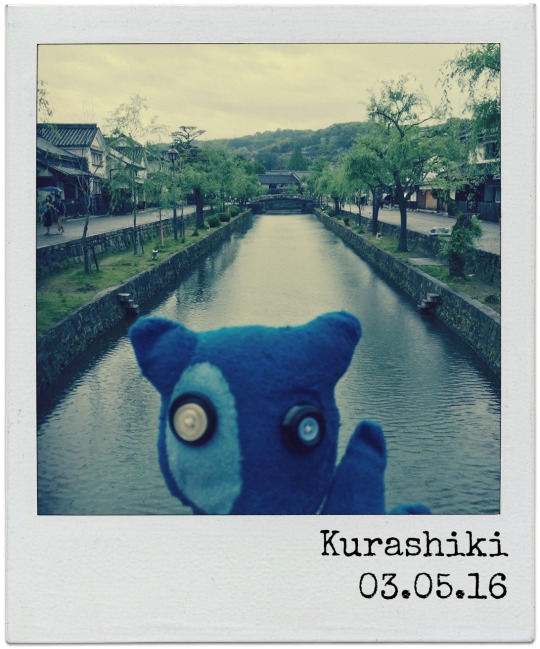
Purtroppo la visita a Kurashiki risente un po’ delle condizioni atmosferiche che ci impediscono di goderne appieno la bellezza, anche se inoltrarsi nel suo verde sotto la pioggerellina primaverile ha un che di pioggia nel pineto. Ironicamente, tra l’altro, la pioggia è tutta l’acqua che riusciamo a trovare per un bel po’ perché la zona del canale è proprio l’ultima a cui arriviamo, costringendoci a eliminare, dopo i signori della guerra, anche i rabdomanti dalla lista delle eventuali professioni per il futuro.
Passeggiando quindi per il quartiere di Bikan ci imbattiamo nell’Achi-jinja, un santuario con più di 1700 anni di storia fondato da un clan probabilmente proveniente dal continente e per questo dedicato alle tre sorelle Halliwell Munakata, divinità protettrici del tratto di mare che separa il Kyūshū dalla penisola coreana. Secondo il Kojiki (古事記 ‘Un racconto di antichi eventi’, 712), una delle prime opere scritte se non proprio la prima di cui si abbia traccia, le tre sorelle sarebbero nate dalla spada del leggendario guerriero Susanoo, lavata in acqua sacra dalla sorella e divinità del sole Amaterasu, che la fece poi a pezzi con i denti e ne respirò fuori una nebbiolina da cui appunto ebbero origine le tre divinità. Sarebbe stato bellissimo sapere tutto questo quando l’abbiamo visitato, e invece l’unica cosa che ha saputo dirci la Lonely Planet è che è un santuario a cui si accede con una ripida scalinata, THAT WAS USEFUL!
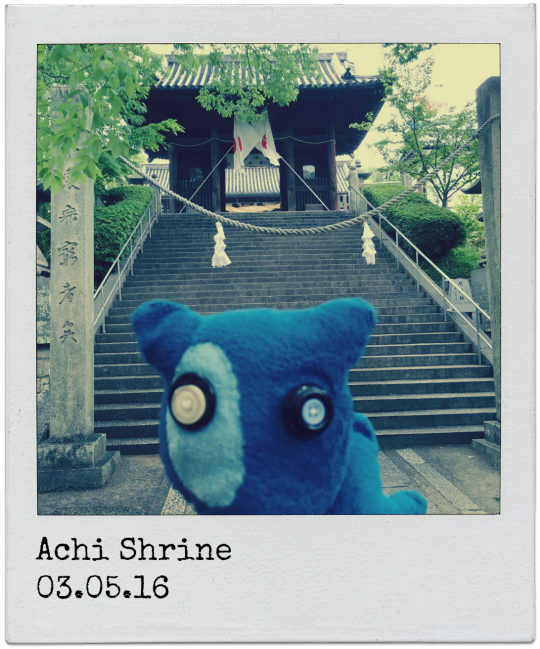
La passeggiata alla ricerca dell’acqua prosegue e ci porta a Ivy Square, una piazza dove alla fine del 1800 sorgevano delle fabbriche tessili di cui oggi rimangono i caratteristici edifici di mattoni rossi che non solo fanno subito nostalgicamente Europa ma mi ricordano non a caso quelli che avevo visto a Tomioka, dove si trova una fabbrica di seta patrimonio Unesco costruita appunto nello stesso periodo.

Dopo aver passeggiato per i deliziosi vicoli di Bikan pieni di negozietti che vendono cosine carine che il turista medio (di cui chiaramente faccio parte lol) non può finire per non comprare, finalmente riusciamo a raggiungere la zona del canale, di cui seguiamo il corso in una piacevole promenade ammirando il rilassante panorama.

「せせらぎの歌に この空の色に 花の香りにいつまでも生きて」 “Vivrai per sempre nel canto di un ruscello, nel colore di questo cielo e nel profumo dei fiori”

E sempre a proposito del Castello Errante di Howl, “questa è una modesta cappelleria di quartiere!” [cit.]
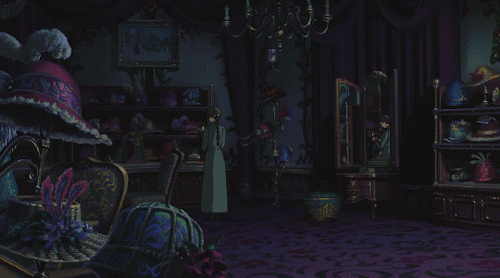
Concluso il giretto a Kurashiki mettiamo finalmente piedi in ostello dove chiacchieriamo un po’ con il nostro compagno di stanza, Yū il taiwanese che non può bere alcolici perché sennò gli si ferma il cuore, cerchiamo un ristorante nella vicina stazione di Okayama e aspettando che ci arrivi da mangiare pianifichiamo la gita del giorno dopo a Naoshima, un’isoletta a metà strada tra le due isole dello Honshū e dello Shikoku che ospita diverse installazioni artistiche e gallerie d’arte che la rendono un inusuale museo naturale. La mattina del 4 maggio prendiamo quindi un treno che ci porta dolorosamente presto al porto di Uno, dove i pescatori pescano due carte se si dimenticano di dirlo, e da lì ci imbarchiamo su un traghetto diretto a Naoshima.

Uno, qualcuno, racimola denaro per la villeggiatura ♪ Non ho nemmeno voluto fare i conti di quanto ho speso in questo viaggio ma non rimpiango un solo centesimo di yen ♥
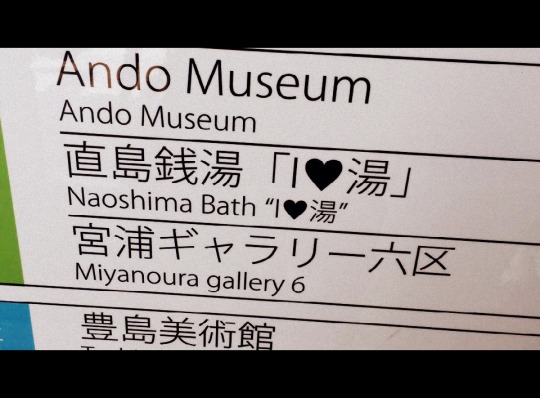
Parlando di giochi di parole scadenti, un applauso a chi ha chiamato uno dei bagni termali per i quali pare essere famosa Naoshima “I♥湯” (‘amo l’acqua termale’, che suona uguale a ‘I love you’). Respect.
Simbolo per eccellenza di Naoshima è la zucca dell’artista Kusama Yayoi, una grossa cucurbitacea gialla a pois neri (in realtà ce n’è anche un’altra rossa ma è quella gialla a essere assurta a emblema principale) che si affaccia sul Mare Interno per contemplare l’orizzonte da un piccolo molo di cemento. E niente è bellissima, immobile nel suo avamposto e inaspettatamente in armonia con il panorama nonostante sia palesemente fuori posto, di una perfezione sconcertante che ci ha mandati in fibrillazione neanche avessimo mangiato troppo zucche(ro).
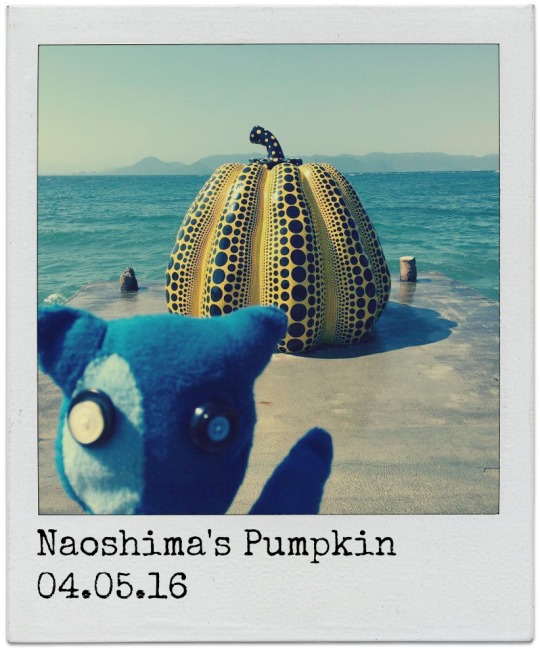
Poco distante dalla zucca di Kusama Yayoi sorge la Benesse House, una galleria d’arte progettata dall’architetto Andō Tadao che mi ricordava vagamente il Mart di Rovereto, imagine that. Prima di arrivarci chiaramente non ci siamo fatti mancare un giretto nel vicino parco giochi per accondiscendere alla voce del fanciullino pascoliano lol

“Two times I thought I heard someone knocking on the glass, I hid my head and prayed that it would pass. A friendly ghost is all I need.” Questa ce la teniamo per la copertina del nostro EP di debutto ♥
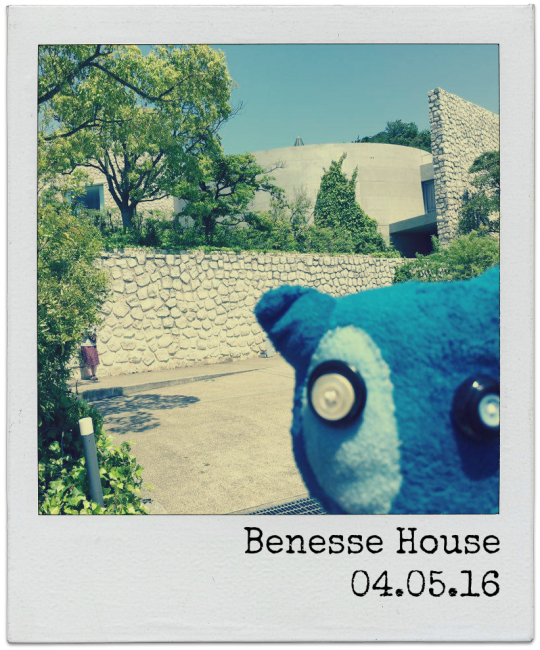
Il museo della Benesse House è stato aperto nel 1992 con l’intenzione di far coesistere natura, arte e architettura in un unico luogo che potesse offrire ai visitatori un momento di relax e di riflessione. Quando si tratta di arte contemporanea si rischia di rimanere sempre un po’ perplessi, cosa che in alcuni casi è successa anche stavolta, ma in generale aggirarsi tra le opere circondati dal panorama mozzafiato di Naoshima e del suo mare è un’esperienza piacevolessima, e poi se uno si stufa può sempre spiaggiarsi al sole sulle sculture a forma di pietra levigata di Yasuda Kan guardando il cielo che si apre sopra le mura di cemento da cui sono circondate e che valgono all’opera il nome di ‘Tenpi’ 天秘, ‘Il segreto del cielo’.
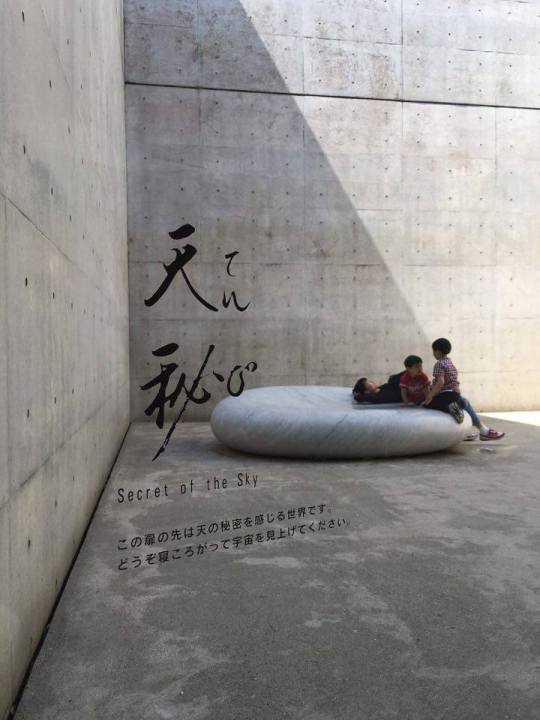
“See you at the other end, up in the sky”

“Don’t let the daytime fool you that you’re not real”
Non troppo distante dalla Benesse House, la zona del villaggio di pescatori di Honmura ospita inoltre una serie di installazioni artistiche insospettabilmente racchiuse nella cornice di case tradizionali non troppo indicate. A essere proprio sinceri, non è che proprio valessero i 1000 yen del biglietto, però mettiamola così: è bello sapere che c’è un’isola nel mar del Giappone dove, aggirandosi per i vicoli di un qualsiasi villaggio di pescatori, ci si può imbattere in opere d’arte celate in vecchie abitazioni che non darebbero altrimenti nell’occhio.
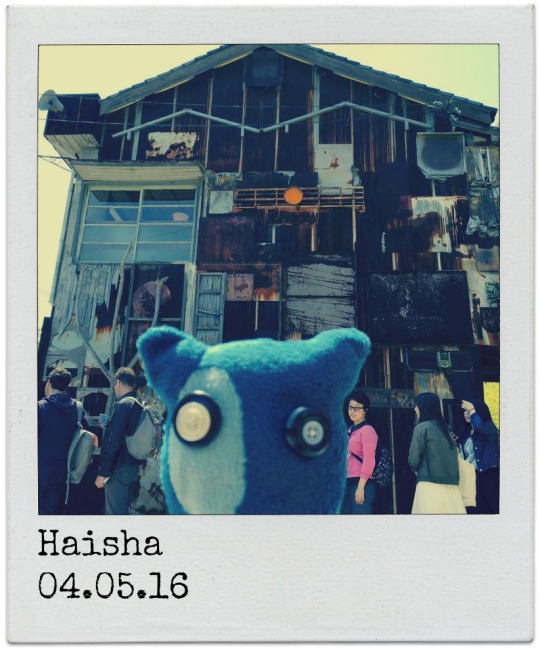
Questo bislacco edificio a metà tra la casa di Baba Yaga e il castello errante di Howl era l’abitazione e l’ufficio di un dentista del luogo. Nel 2006 l’artista Ōtake Shinrō l’ha trasformato in un’opera che dovrebbe rappresentare un panorama onirico realizzato con accumulo di materiali tra cui pezzi di navi, torrette di metallo, dipinti e collage.

Ah, e dentro c’è una riproduzione della Statua della Libertà che trafigge la casa da un piano all’altro perché sì. Neanche fosse la prima che vedo in Giappone, tra l’altro lol
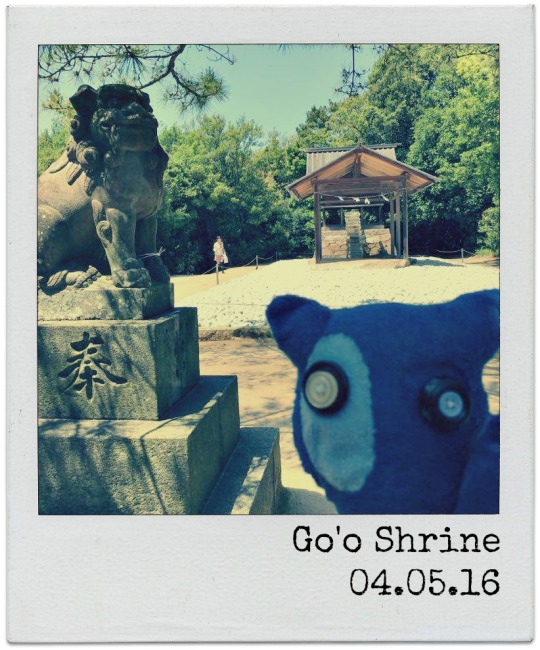
Il santuario di Go’ō era un vecchio santuario di periodo Edo che nel 2002 venne ristrutturato dall’artista Sugimoto Hiroshi e collegato da una scala di vetro alla cosiddetta ‘Sala di Pietra’, una camera sotterranea stretta e buia dove dopo una discreta coda per accedere siamo stati fatti entrare armati solo di una pila elettrica e senza troppi complimenti. Non ho capito ma okay.
Molto a malincuore abbandoniamo Naoshima con la sensazione - anzi, la certezza - che ci sarebbe ancora molto da esplorare e ci lanciamo di nuovo sul traghetto che ci porterà stavolta a Takamatsu, ridente città portuale nel nord dello Shikoku.

L’uso dell’aggettivo ‘ridente’ non è casuale: se a Heidi sorridevano i monti, a Takamatsu a sorriderti sono le stazioni dei treni.
Meta della nostra toccata e fuga il Ritsurin-kōen, uno splendido giardino risalente al XVII secolo e pensato come luogo di svago per il signore feudale locale, tale Ikoma Takatoshi, che lo volle ai piedi del monte Shiun, un’altura che si fonde meravigliosamente con il paesaggio e dietro cui abbiamo visto gradualmente tramontare il sole in un placido crepuscolo.
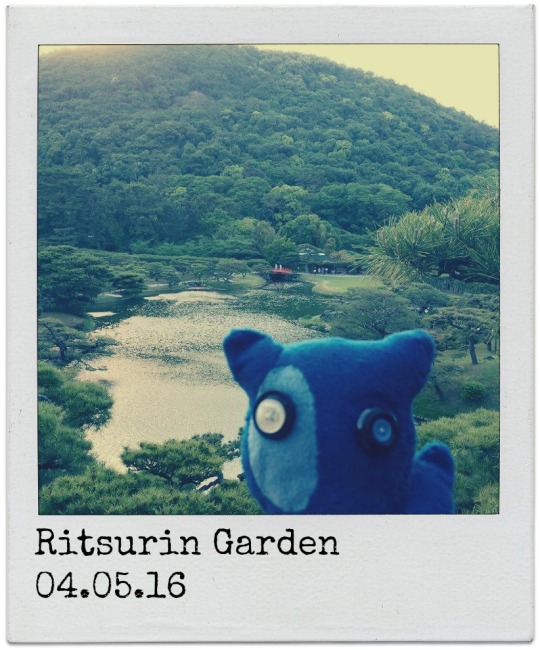
Il giardino di per sé è enorme e girarlo tutto con calma avrebbe richiesto più tempo di quello che avevamo, ma siamo comunque riusciti a goderci una rilassante passeggiata intorno al suo perimetro.
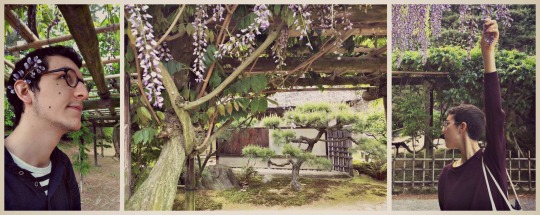
「草臥れて 宿借る頃や 藤の花」松尾芭蕉 “Affaticato: / tempo di trovare un rifugio / fiori di glicine.” [Matsuo Bashō]
Altra attrattiva della città doveva essere il castello di Takamatsu, o meglio, il parco che ne accoglie le vestigia perché del castello sono rimasti giusto le mura e qualche torretta, ma io non leggo mai le guide e non lo sapevo, per cui quando Chiara mi ha annunciato che non c’era proprio nulla da vedere abbiamo deciso che ce lo potevamo pure saltare. Anche perché il giorno dopo ne avremmo visto un altro, la quota tre castelli in tre giorni ci sembrava eccessiva lol

Ao-Oni, o l’Orco Blu. Una favola per bambini scritta da Hamada Hirosuke e che vede per protagonisti due orchi, uno rosso e uno blu, racconta di come l’orco rosso desiderasse ardentemente riuscire a diventare amico degli umani. Per realizzare il suo desiderio, l’orco blu elaborò un piano: avrebbe spaventato gli abitanti di un villaggio e l’orco rosso sarebbe venuto a salvarli dimostrando di essere un orco amichevole. Il piano ebbe successo ma l’orco blu da quel giorno non poté più frequentare l’amico per non rischiare che gli abitanti del villaggio si ricredessero sul suo conto. Partì quindi lasciando una lettera d’addio che mosse l’orco rosso al pianto, da cui il titolo del racconto, ‘L’orco rosso che pianse’. L’orco è diventato la mascotte di Takamatsu perché la vicina isola di Megijima viene tradizionalmente identificata con l’isola degli Orchi visitata da Momotarō, di cui vi parlerò a breve in quanto mascotte a sua volta di Okayama.
Salutata Takamatsu con un piatto di udon, saliamo sul primo treno a due piani che ci sia mai capitato di vedere in Giappone e ci prepariamo ad attraversare il Seto Ōhashi, il grande ponte che collega lo Shikoku allo Honshū passando per le due isolette di Yoshima e Hitsuishi.

Ma è un Minuetto!
Mentre intorno cala il buio, il nostro treno percorre sferragliando intervalli di terra e di mare sopra cui sfreccia sospeso come un funambolo, facendoci sentire vagamente all’interno di uno dei treni della città incantata.
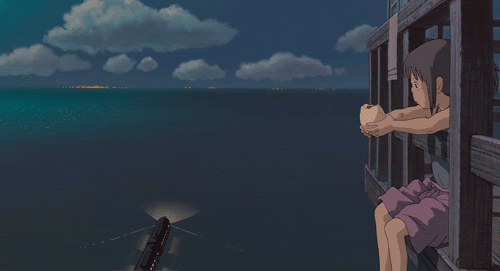
Dopo non essercela praticamente mai cagata se non per tornarci a dormire, finalmente dopo due giorni riusciamo finalmente a visitare Okayama. Come vi accennavo, mascotte indiscussa della città è Momotarō, protagonista di una leggenda che lo vorrebbe nato da una pesca gigante pescata (agghiacciante questa inevitabile allitterazione, eh) da una coppia di anziani senza figli mentre andava alla deriva in un fiume. Chissà, forse era la pesca gigante cresciuta nel giardino delle perfide zie di James.
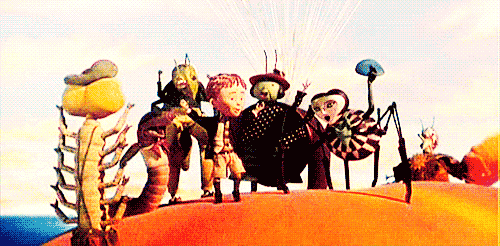
Se lo ricorda qualcuno il film di James e la Pesca Gigante? Di Henry Selick e Tim Burton da un racconto di Roald Dahl tra l’altro, okay che l’ho visto a cinque anni nel 1996 ma come ha potuto passarmi di mente, devo riguardarlo.
Il ragazzo pesca, una volta cresciuto, riuscirà a sconfiggere insieme a tre fedeli compagni - un cane, una scimmia e un fagiano - i temibili orchi di Onigashima, l’odierna Megijima appunto. A imperituro ricordo delle sue eroiche gesta rimane una statua appena fuori dalla stazione di Okayama, proprio all’inizio di un viale a lui dedicato, il Momotarō-dōri.

Seguendo Momotarō-dōri si può arrivare a piedi ai due principali siti di interesse di Okayama: lo splendido Kōrakuen e il Castello di Okayama.
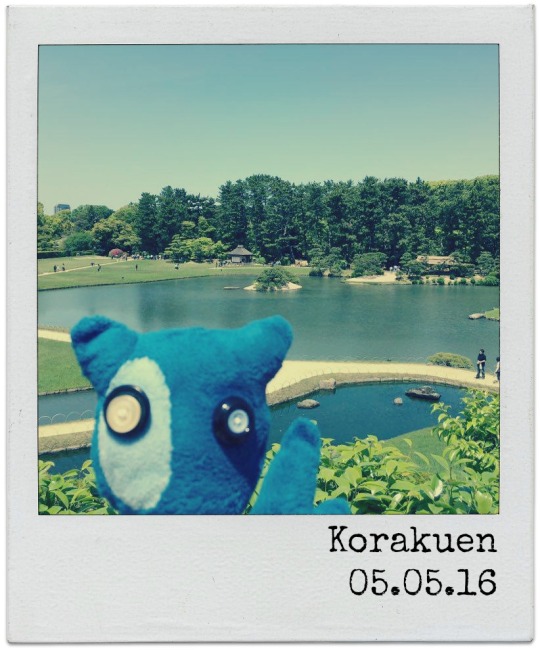
Il Kōrakuen (後楽園) è considerato a ragione uno dei tre più famosi e bei giardini del Giappone, insieme al Kenrokuen di Kanazawa e al Kairakuen di Mito. Il suo nome deriva da un proverbio condensato in quattro caratteri, sen’yū kōraku 先憂後楽, che senza troppo timore di incappare in un’estensione culturale potremmo tranquillamente tradurre con ‘prima il dovere e poi il piacere’, declinato però in questo caso nel contesto degli affari di Stato, ossia: un bravo regnante deve occuparsi prima di tutto dei propri sudditi e solo successivamente pensare al proprio sollazzo. Come riassumere anni di storia politica italiana in quattro caratteri praticamente lol

© Courtesy of Chiara Completato nel 1700 per volere di tale Ikeda Tsunamasa, signore feudale locale, è rimasto praticamente immutato da allora nonostante i gravi danni subiti da un’alluvione nel 1934 e dai bombardamenti nel 1945. Questo perché l’attenta opera di ricostruzione è stata scrupolosamente condotta sulla base di dipinti e diagrammi d’epoca che sono serviti come guida per il restauro, e boh, forse è prassi comune, ma trovo che questo volgersi al passato per trarne un insegnamento pratico immediatamente spendibile nel presente a distanza di due secoli sia proprio una figata.

Koinobori garriscono indolenti @ Kōrakuen per la Festa dei Bambini 🎏 Il fatto che vi possa rimandare a un post di un anno fa per spiegarvi cosa sono mi fa un po’ impressione devo ammettere O_O

In un momento di profondo appagamento contemplativo abbiamo deciso di concederci una pausa in un piccolo chiosco che serviva matcha e kibi-dango, dolcetti di farina di miglio tipici di Okayama che sarebbero i preferiti di Momotarō e che di conseguenza sono pure il souvenir più gettonato acquistabile in città.
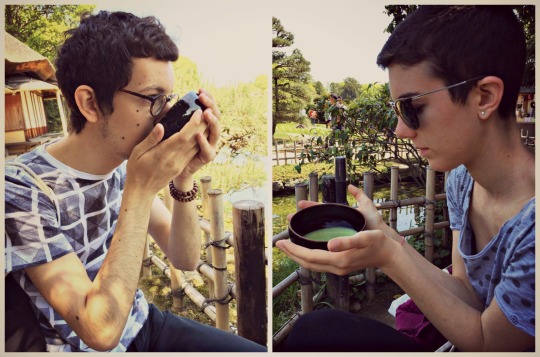
“La cerimonia del tè non è che: far scaldare l'acqua, preparare il tè e berlo come si conviene.” (Sen no Rikyū)
Ci lasciamo a malincuore alle spalle il Kōrakuen e attraversiamo lo Tsukimibashi (月見橋, ‘il ponte da cui si osserva la luna’), un ponte sospeso su un’ansa del fiume Asahi che collega il giardino al Castello di Okayama.

Se il Castello di Himeji è soprannominato ‘l’airone bianco’, il Castello di Okayama è conosciuto anche con il nomignolo di ‘Castello del Corvo’ (烏城, Ujō), per via del suo colore nero. Altra peculiarità sono i doccioni dorati a forma di pesce che guizzano nell’aria.
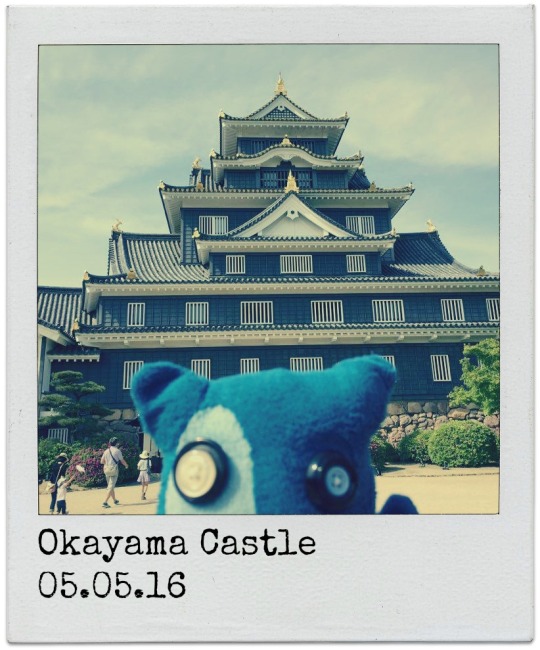
Concluso il tour del castello, ci dirigiamo nuovamente in stazione per assolvere al nostro dovere di turisti e fare incetta di souvenir (kibi-dango per tutti come se piovesse e chissenefrega, di ignoranza proprio). Sono stato davvero contento di essere riuscito a concentrare così tanti bei posti in soli tre giorni e di aver conquistato un altro pezzettino di Giappone dove ancora non ero stato, e che tra l’altro per quanto turistico non sono sicuro sia proprio gettonassimo. Ma soprattutto avevo proprio bisogno di questo durante la Golden Week: esplorare posti nuovi con qualcuno che invece conosci da tempo, qualcuno con cui parlare, parlare a lungo, parlare a fondo, parlare di tutto e aggiornarsi su tutto quello che è successo dall’ultima volta che ci si è visti di persona, e discutere di tante cose, riflettendo su quanto sia bizzarro ritrovarsi a parlarne in una cornice così inedita e imprevista, dove fino a poco tempo fa non credevamo la vita ci avrebbe portati. E se ci ha portati fino a lì, chissà che sorprese avrà in serbo in futuro. Grazie stella, è stata una Golden Week davvero splendida ♥

Metafoto derpine 🙈
2 notes
·
View notes
Text
Cose che la primavera porta con sé
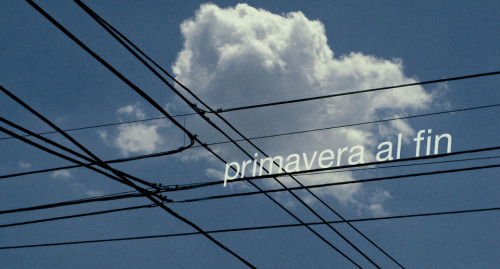
「気付かなかったけれど、春はそこに来ていた。」 “Senza che me ne accorgessi, era arrivata la primavera.”
E, sempre senza che me ne accorgessi, è la seconda volta che mi trova a Tokyo. L’anno scorso l’avevo vista sbocciare a Kyōto e giusto poco prima che i ciliegi fiorissero mi ero trasferito da una capitale all’altra. E sono ancora qui. Non che significhi chissà cosa, però mi fa un certo effetto pensare che è la prima volta che faccio in tempo ad osservare un intero ciclo di stagioni ripetersi in un posto che non è casa. O meglio, che lo è diventato prima che potessi rendermene conto.
Se dovessi descrivere la mia vita a Tokyo da allora credo prenderei in prestito le parole e soprattutto le illustrazioni di Igort, che in “Quaderni Giapponesi”, gradito regalo natalizio di padre, traccia degli spaccati di vita quotidiana di un italiano in Giappone dove ogni tanto mi sembra vagamente di riconoscermi. Non fosse altro perché anche lui racconta: “Abitavo in un piccolo appartamento di 14 metri quadri”, non uno di più non uno di meno di quelli che posso calpestare io lol

Lui però c’aveva la lavatrice in casa, di cosa si lamenta? A proposito di lavatrici, ho trovato una lavanderia a gettoni dove si può lavare con l’acqua calda, credo l’unica in tutto il Giappone dove la maledizione delle lavatrici a freddo non sembra darci tregua, a momenti andavo in fibrillazione. La mia vita è proprio un rollercoaster di emozioni fortissime lol
Sono state proprio le parole e i disegni di Igort a condurmi a Nezu, che nelle vignette sottostanti il fumettista italiano descrive come un luogo che offre “il lusso di curarsi, di regalarsi dei respiri di sollievo, che arrivavano inaspettati”, un luogo dove “il tempo pareva scorrere a un’altra velocità”, nel tentativo di scoprire una sorta di Tokyo metaletteraria (per lo stesso motivo un giorno mi piacerebbe andare alla ricerca dei luoghi murakamiani segnati su questo itinerario, appena ho tempo di organizzarmi giuro che mi ci dedico), e per vedere quanto ancora potessero essere attuali le impressioni catturate sulla carta dai tratti acquerellati di Igort.
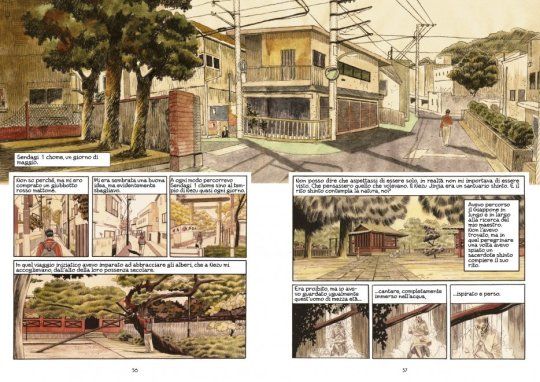
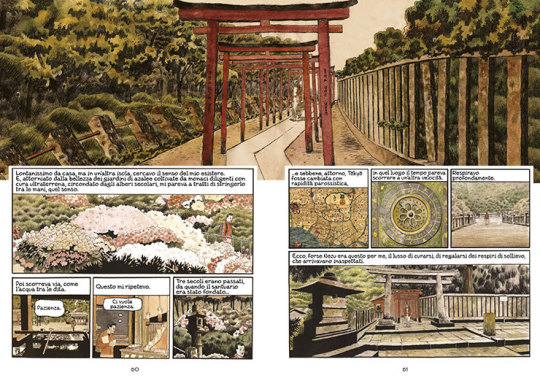
Il santuario di Nezu è situato nel quartiere di Bunkyō, una zona popolare di Tokyo dove effettivamente il tempo sembra davvero scorrere a un ritmo più lento, e che forse proprio per questo pare essere fermo ad un’altra epoca, un’epoca che non ho vissuto ma che riesce comunque a risvegliare una placida e non meglio identificata sensazione di nostalgia. Non saprei come spiegarmi, ma diciamo che se avessi una nonna in Giappone, di sicuro abiterebbe nel quartiere di Bunkyō, in una delle sue casette di legno un po’ diroccate e ricoperte di edera, e tutte le domeniche si recherebbe in bicicletta attraverso gli angusti vicoli in una delle fiorerie con i pansé esposti sul marciapiede per comprare delle violacciocche.
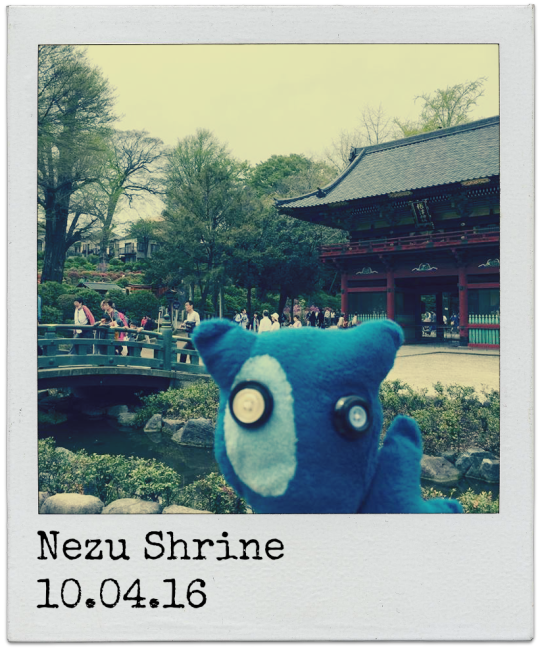
Il santuario principale del complesso di Nezu è stato edificato sulla base del Tōshōgu di Nikkō (che ricordi.1) e poco distante c’è anche una parte dedicata a Inari, con gli inconfondibii tunnel di torii (che ricordi.2), per cui appunto, non poteva che risvegliare memorie piacevoli anche durante una visita distratta.

[Sulle tracce di Igort]
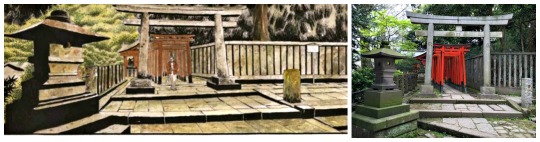
Visita che tra l’altro è concisa con lo Tsutsuji-matsuri (つつじ祭り, Festival delle azalee, ah ecco come si chiamavano in italiano quei dannati fiori) di Bunkyō, durante il quale si svolge tra l’altro una processione di omikoshi, palanchini sacri scintoisti portati in spalla da omaccioni rigorosamente in fundoshi, il perizoma tradizionale, con gran sfoggio e dispiego di chiappette.

Non si vedono perché tagliate nella foto, ma giuro che sotto c’erano diverse chiappette.
Se a Nezu si festeggivano le azalee, va da sé che tuttavia il fiore primaverile per eccellenza in Giappone è il sakura (桜, fiore di ciliegio), tanto che perfino su Line, il Whatsapp giapponese, per un certo periodo sullo sfondo delle conversazioni apparivano a caso petali danzanti e molte delle mail che mi arrivavano a lavoro iniziavano con “I hope you are enjoying the cherry blossom season”. Pare che quest’anno in particolare ci sia stata una vera e propria invasione di cinesi sbarcati in Giappone proprio per la stagione dei ciliegi in fiore (o almeno questo ho colto dalle notizie osservate distrattamente sugli schermi della metro nelle assonnate mattine di pendolariato), ma cinesi o no è ben vero che tutta sta cosa dei sakura intasa parchi e giardini di gente più o meno incline a sciogliere il proprio animo poetico contemplando le chiome fiorite dei ciliegi perché più o meno intenta a farci il barbecue e a ubriacarcisi sotto. Per me niente pic-nic quest’anno, ma è stato ugualmente piacevole ammirarli passeggiando in diversi punti di Tokyo, come lo Hie-jinja durante una pausa pranzo a lavoro, il parco di Ueno che rigurgitava di visitatori al punto che la coda iniziava dai tornelli della vicina stazione, e il lungofiume di Nakameguro, particolarmente suggestivo di sera e con un calice di Martini (Martini? the hell?) in un tripudio di rosa. Non ho fatto nemmeno una foto, ma piazziamo un trittico dell’illustratore tokyoita Kiuchi Tatsurō che va bene uguale.

「来て見れば夕の桜実となりぬ」与謝蕪村
Tornando a vederli i fiori di ciliegio, la sera, son divenuti frutti. [Yosa Buson]

「江戸衆に見枯らされたる桜哉」小林一茶
Fiori di ciliegio A farli sfiorire gli occhi della gente di Edo. [Kobayashi Issa]

E a proposito di tripudio di colori, giusto perché essere un italiano in Giappone alla Camera di Commercio Svizzera non mi stava sufficientemente sballinando il concetto di identità nazionale, quest’anno ho deciso di accogliere la primavera pure secondo le usanze indiane partecipando con Anna, Eva e T. (gradita new-entry kyotoita d’istanza a Tokyo pure lui) allo Holi Festival svoltosi al Red Brick Warehouse di Yokohama, a.k.a. Aka Renga, cioè aka Renga, nel senso, vabbè Francesco Renga, prenditi cura di lei.
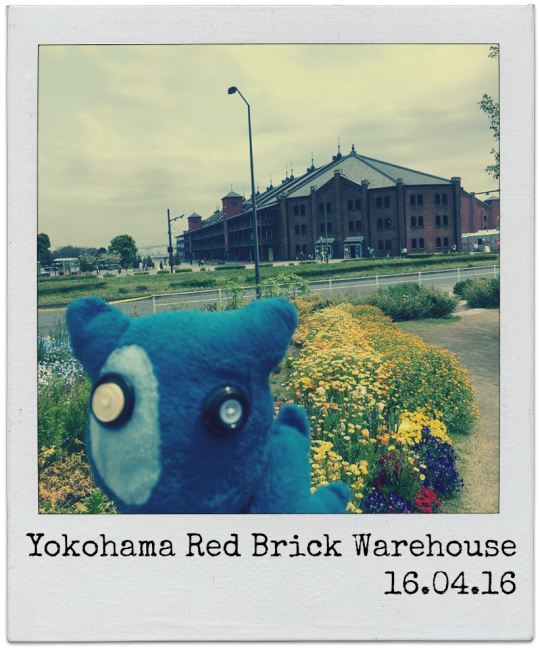
Per chi come me non ne aveva idea lo Holi è una festività induista con la quale si saluta l’avvento della primavera smarmellandosi di colori in polvere con i quali ci si impiastriccia vicendevolmente in un grande afflato d’amore collettivo. Per la serie: “ehi scusa ma è il mio ruolo che mi impone di spalmarti del colore addosso, non ti sto palpeggiando gli addominali intenzionalmente, ma fai palestra? si sente tantissimo” lol

Now painting rainbows on my ugly face 🌈
Beh è stato proprio una figata, primo perché ci aspettavamo che i giapponesi fossero troppo timidini per smerdazzare degli estranei senza almeno scusarsi prima, durante e dopo, e invece si facevano avanti urlando “happy horiiiiiiii”, li mortacci loro; e poi perché girare per Yokohama ricoperti di colore fingendo che sia tutto normale con la gente che però ti sta palesemente giudicando e a volte addirittura ti ferma per chiederti se può farti una foto ancora mi mancava devo ammettere. Tra l’altro, siccome in giapponese ‘bello’ e ‘pulito’ si dicono allo stesso modo (奇麗 kirei), è stata una rarissima occasione, la prima e l’ultima credo, di sentirmi dire che la mia faccia era kirei - loro volevano dire che non ero sufficientemente insozzato di colore, ma le ambiguità linguistiche ogni tanto fanno sognare lol

「君は今カラフルになって色付きの世界を駆けて行く」 “Ora diverrai multicolore e correrai in un mondo colorato”
Chiuderei con un fun fact che forse non vi interessava: fino al giorno successivo, ogni volta che mi soffiavo il naso quel che ne usciva era violaceo. Sapevatelo.

Ewww.
2 notes
·
View notes