#L'epoca delle passioni tristi
Text
“ Alcuni anni fa Marc, un bambino di dieci anni, è venuto in ospedale per un colloquio. Come accade spesso in questi casi, il bambino preoccupava molto le persone che lo circondavano. La famiglia si era decisa a chiedere un colloquio in seguito a un’esperienza negativa in una colonia di vacanze dove un certo comportamento, che fino a quel momento era passato più o meno inosservato, era “esploso”. Un lunedì mattina accolgo quindi questo bambino con i suoi genitori, visibilmente agitati (come la maggioranza dei genitori che accompagnano il figlio in un servizio di psichiatria, la loro angoscia è raddoppiata dalla paura implicita di essere giudicati: “Siamo dei bravi genitori? O saremo considerati delle persone che non hanno saputo educare i loro figli al punto che adesso, per il loro bene, la società dovrà occuparsi di loro?”). Mi raccontano che tutto è cominciato nella colonia di vacanze in cui Marc rifiutava di lavarsi nudo di fronte agli altri bambini. Poi Marc stesso mi spiega che, anche a casa, si fa la doccia vestito con una specie di camicione e che si insapona attraverso il sottile tessuto. Mi spiega poi che gli istruttori della colonia erano molto turbati per quello che raccontava. Marc aveva infatti spiegato, riprende la madre, di essere l’imperatore di un pianeta chiamato Orbuania e che, come imperatore di questo pianeta, veniva ogni giorno sulla terra in osservazione. Ma ogni notte lasciava il suo corpo e tornava nel suo pianeta dove riprendeva la sua normale vita di imperatore. A quel punto chiedo ai genitori se Marc avesse già parlato loro di tutto questo e rispondono che sì, naturalmente gliene aveva parlato. Marc aveva inoltre scritto una serie di quaderni in cui descriveva la vita di Orbuania, che aveva fatto leggere ai suoi insegnanti, i quali trovavano, come del resto i genitori, che sebbene il bambino fosse un po’ ossessionato dalla sua storia, rivelasse in fondo solo di possedere un’immaginazione un po’ troppo fervida. È necessario precisare che Marc aveva rivelato, nei vari test a cui era stato sottoposto in ospedale, un’intelligenza superiore alla media. E agli psicologi che gli avevano sottoposto i test aveva dichiarato di voler parlare del suo impero con qualcuno, ma che non voleva essere trattato “psicologicamente”. Gli ho chiesto perché. Dall’alto dei suoi dieci anni, mi ha risposto che gli psicologi sono persone che non capiscono nulla delle cose, che interpretano tutto e che lui invece desiderava parlare, ma in modo più complesso e profondo, con un adulto che non lo catalogasse. Non credevo alle mie orecchie: quel bambino mi stava dicendo che non voleva essere trattato come un sintomo. Mi diceva molto chiaramente che desiderava parlare, ma che quella conversazione non doveva cadere in un riduzionismo tecnico. Gli dissi immediatamente che io ero uno psicologo, ma che ero anche un filosofo, che la sua storia mi interessava molto e che desideravo parlare con lui anche se non capivo bene perché volesse parlare con qualcuno.
Penso che all’inizio il desiderio di comunicare la sua visione delle cose nascesse da due ragioni ben distinte: da una parte, le persone reagivano male quando lui parlava del suo impero; e dall’altra, siccome in questa storia non tutto gli era completamente chiaro, l’opinione di qualcuno che non lo giudicasse gli era preziosa. Tale fu il nostro primo patto, che restò intatto per oltre dieci anni di lavoro comune e di amicizia reciproca. “Signor imperatore”, è così che ho cominciato molto presto a chiamarlo. Quell’appellativo è diventato il suo nome, o meglio il suo soprannome, che accettava con un certo piacere. E non ero il solo a chiamarlo così: le segretarie, vedendolo arrivare per la sua ora di discussione (non è mai stata una seduta), lo salutavano, senza alcun tono di scherno, dicendogli: “Buongiorno signor imperatore! Un po’ alla volta, Marc mi descriveva il suo pianeta. Parlavamo anche della difficoltà di vivere sulla Terra, una difficoltà che sotto molti aspetti ci accomunava — con lo svantaggio per me che io, contrariamente a lui, non sono imperatore neanche per qualche ora al giorno. Fin dai primi incontri ho chiesto a Marc cosa pensasse della realtà di Orbuania. Sviluppò a questo proposito una teoria che non è mai cambiata nel corso degli anni, anche se con il tempo si è affinata. Orbuania e le sue costellazioni, i pianeti che dipendevano dal suo impero e i suoi nemici esistevano davvero, ma non poteva dimostrarlo. Mi proponeva quindi di adottare, a proposito dell’esistenza del suo impero, la “scommessa di Pascal” riguardo all’esistenza di Dio. Si può immaginare il mio stupore (e non sarebbe stato l’ultimo!) quando udii una tale proposta uscire dalla bocca di un bambino di quell’età! La realtà di Orbuania non dipendeva da una credenza personale, ma dal grado di esistenza determinato dalla necessità che un tale oggetto esistesse... Qualche anno dopo, quando Marc cominciava ad avere il profilo del matematico che è oggi, ha partecipato come uditore ad alcune riunioni, da me coordinate, con due ricercatori (un matematico e un fisico), in vista della stesura di un libro di logica matematica. Tra i soggetti che affrontavamo c’era il problema ontologico dello statuto di esistenza dell’oggetto della scienza. L’imperatore offriva il suo parere sui teoremi fondamentali di Gödel e di Cohen, tra gli altri. E appena poteva ci dava notizie di Orbuania, cosa che incuriosiva al massimo, come si può immaginare, gli scienziati miei complici, assolutamente incapaci di definire ciò che “esiste” o meno, e perfino di saper dire più o meno cosa questa parola significhi. Un giorno ho vissuto un episodio piuttosto comico con l’imperatore. Era un pomeriggio d’estate e faceva molto caldo al Centro; quando Marc arrivò gli proposi di andare a bere qualcosa al bar, come facevamo abbastanza spesso. Al bar quando il cameriere viene a prendere l’ordinazione, chiedo a Marc: “E lei, cosa desidera, signor imperatore?”. Marc risponde e, quando il cameriere si allontana, mi dice in tono protettivo: “Vede, Benasayag, a me non dà nessun fastidio, ma se continua a chiamarmi ‘signor imperatore’ in pubblico, finiranno per pensare che lei è un po’ matto” — e accompagna l’affermazione con un gesto esplicito, puntando l’indice sulla tempia e facendolo ruotare su se stesso. Poco per volta imparavo a capire quando potevo chiamarlo signor imperatore. E lui da parte sua imparava, probabilmente insegnandolo a me, che non tutti sono in grado di capire le interessanti informazioni sul suo pianeta, per la semplice ragione che poche persone sono in grado di comprendere d’acchito i Pensieri di Pascal. Questa storia non deve farci dimenticare ciò che non è ancora stato detto, cioè che Marc non è mai stato medicalizzato, che non è mai stato ospedalizzato in un reparto di psichiatria, né etichettato e non è nemmeno mai rientrato in un programma di integrazione... Solo quando è entrato all’École normale supérieure, dopo aver fatto Matematica superiore e Matematica speciale, gli ho suggerito di dedicarsi alla ricerca anziché all’insegnamento e lui, condividendo il mio parere, ha seguito il mio consiglio. A un certo punto di questa storia con Marc, gli ho proposto di realizzare un breve filmato in cui lui avrebbe descritto il suo impero e spiegato i delicati meccanismi di quel mondo in cui i due sessi non si distinguevano per alcun segno esteriore, essendo entrambi identicamente “piatti”, in cui il partito maggioritario era misogino, in cui le donne (che lui era il solo a poter identificare) erano geneticamente inferiori agli uomini e in cui i membri di un partito anarchico venivano sovvenzionati come clown ufficiali dell’impero. Contrariamente a quanto si potrebbe credere, i racconti di Orbuania non assomigliavano affatto a un romanzo di fantascienza. L’imperatore mi informò piuttosto dettagliatamente, nel corso degli anni, sulla circolazione delle auto, sulle tasse, sull’educazione eccetera. E mi teneva informato sulle interminabili guerre e conflitti che il suo impero intratteneva con le colonie, perché il signor imperatore non era propriamente di sinistra... Marc era molto interessato a realizzare un documentario audiovisivo, a patto che fosse rispettata una condizione preliminare, ovvero che il film non fosse utilizzato come “materiale psichiatrico”. Il documentario poteva essere mostrato a filosofi, ad antropologi o ad altri intellettuali, ma in nessun caso a dei tecnici che non vi avrebbero riconosciuto altro che sintomi, cioè che non vi avrebbero visto, per usare le parole di Marc, “niente”. “
Miguel Benasayag, Gérard Schmit, L'epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, 2004 [Libro elettronico]
[ Edizione originale: Les Passions tristes. Souffrance psychique et crise sociale, La Découverte, 2003 ]
#letture#leggere#citazioni#saggistica#scritti saggistici#libri#Miguel Benasayag#Gérard Schmit#psiche#psicologia#saggi#L'epoca delle passioni tristi#bambini#famiglia#genitori#vita#relazioni sociali#intelligenza#educazione#invenzione#adulti#immaginazione#salute mentale#comunicare#mente#filosofi#amicizia#filosofia#Kurt Gödel#Blaise Pascal
21 notes
·
View notes
Text
Recensione di "L'epoca delle passioni tristi" di Miguel Benasayag e Gerard Schmit
Viviamo nell’epoca delle passioni tristi, abbiamo bisogno d’aiuto e il supporto psicologico è diventato un’emergenza
“In una società in cui i legami sono vissuti come costrizioni o come contratti, l’essere autonomi è percepito come una qualità sociale altamente desiderabile.”
Il saggio di Miguel Benasayag e Gerard Schmit scava nella profondità di un inquietante interrogativo: perché c’è così…
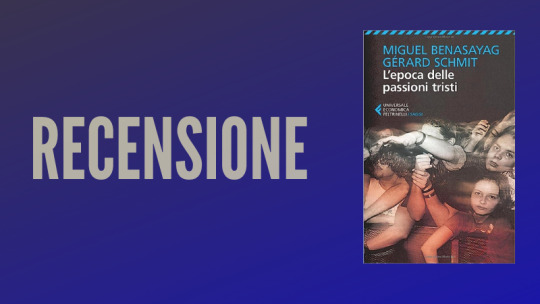
View On WordPress
#l&039;epoca delle passioni tristi saggio#recensione l&039;epoca delle passioni tristi#saggi feltrinelli psicologia#saggi psicologia società moderna
0 notes
Text
Ho sempre pensato di star vivendo in un'epoca incolore.
Tutto è perdutamente dissipato. Il cinema sta morendo, assieme alla bellezza dell'arte e della musica.
I giovani hanno smesso di fare rivoluzione per una pigrizia che ci sta annichilendo.
Viviamo l'epoca delle passioni tristi e non riusciamo a controllare queste emozioni, e il covid, di certo, non ci sta aiutando.
Viviamo oramai chiusi in casa senza alcuna prospettiva e con un futuro morto innanzi a noi.
Andiamo avanti per inerzia, ma senza combattere.
La scuola non aiuta. Impariamo materie delle quali riusciamo a malapena a capire a pieno, e non riusciamo ad entrare nella vera sostanza.
Viviamo di censure, un corpo nudo ci prova disgusto, senza capire che esso è la più alta forma d'arte.
Usiamo il preservativo per non restare incinte, ma nessuno insegna l'importanza delle malattie veneree.
Votiamo, ma nessuno ci insegna come diventare cittadini.
La scuola annichilisce ma non favorisce la personalità e la libertà di pensiero, cosa più bella non c'è, per quanto mi riguarda.
Ho sempre amato, la bellezza e il particolare delle piccole cose, ma il covid sta solo favorendo la persuasione dei cattivi pensieri.
Ho paura del presente e del futuro.
I fantasmi del passato ormai me li porto a presso da un pezzo, non fanno più male, è un male abitudinario e fin troppo dentro me che non ferisce più.
#societa#covid#cattivi pensieri#notte#scuola#tristezza#passioni tristi#epoca#attualità#arte#musica#cinema#adolescenti#adolescenza#passato#presente#futuro#paura
10 notes
·
View notes
Text
“Una tristezza diffusa caratterizza la nostra società contemporanea, percorsa da un sentimento permanente di insicurezza e di precarietà. Meglio star bene e gratificarsi oggi se il domani è senza prospettiva. Nessuna forma di solidarietà viene percepita positivamente perché, in questa visione utilitaristica del mondo, l'umanità appare costituita da una serie di individui isolati che intrattengono tra loro innanzitutto delle relazioni contrattuali e competitive, facendo passare in secondo piano le affinità elettive e le solidarietà di ogni tipo. Se l'estirpazione radicale dell' insicurezza appartiene ancora all'utopia modernista dell'onnipotenza umana, c'è ancora una strada da seguire, e precisamente quella della costruzione dei legami affettivi e di solidarietà, capaci di spingere le persone fuori dall'isolamento nel quale la società tende a rinchiuderle, in nome degli ideali individualistici”.
Miguel Benasayag - L'epoca delle passioni tristi
33 notes
·
View notes
Quote
"In questa società per un adolescente trionfare è grave almeno quanto fallire e comporta un prezzo da pagare, l'angoscia di essere inclusi un giorno fra quelli che non ce la fanno"
{L'epoca delle passioni tristi - Miguel Benasayag, Gèrard Schmit}
1 note
·
View note
Quote
Cosa succede quando la crisi non è più l'eccezione alla regola, ma essa stessa regola nella nostra società?
M. Benasayang, G. Schmit, L'epoca delle passioni tristi (2003), pag.13
#benasayang#schmit#l'epoca delle passioni tristi#galimberti#nichilismo#l'ospite inquietante#nietzsche
0 notes
Quote
Nello spazio familiare, le trasgressioni e i conseguenti richiami all’ordine sono normali nel corso dell’educazione, e costituiscono una sorta di gioco tra desiderio e principio di realtà. Ma trasportate nei quartieri, le trasgressioni perdono la loro dimensione simbolica e ludica e diventano semplicemente dei reati, punibili dalla società. In questo senso, la scena dove si svolgono i riti di passaggio non è quella giusta: i giovani che non hanno altra scelta che quella di “fare il loro Edipo con la polizia” consumano tutte le loro energie in trasgressioni inefficaci, con la tendenza a prolungare per un tempo indefinito la loro “crisi adolescenziale” (cosa che, per inciso, vale anche per quelli, senza dubbio più numerosi, che non scendono in strada ma nemmeno trovano nel contesto familiare il principio di autorità con cui confrontarsi).
Di fatto, vediamo moltissimi giovani che cercano i limiti e giocano al gioco della trasgressione non più con la famiglia o con la cerchia degli intimi, ma con la polizia. Sfortunatamente, quest’ultima non ha la vocazione di supplire alle carenze delle famiglie, e troppo spesso constatiamo con dispiacere che i poliziotti rispondono a questo tipo di provocazioni in modo simmetrico, innescando un gioco infinito di interazioni sul tema aggressori-aggrediti. Questo circolo vizioso incita i politici a fare dell’insicurezza l’asse centrale delle loro proposte politiche, rischiando di trascinare la nostra società verso una deriva disciplinare.
Miguel Benasayag, Gérard Schmit, L'epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, 2004 [Libro elettronico]
[ Edizione originale: Les Passions tristes. Souffrance psychique et crise sociale, La Découverte, 2003 ]
#Miguel Benasayag#Gérard Schmit#L'epoca delle passioni tristi#educazione#autorità#giovani#società#relazioni#politica#famiglia#relazioni famigliari#sociologia#crescere#adolescenza#populismo#populisti#violenza di stato#violenza istituzionale#psicologia#citazioni#leggere#saggi#letture#libri#disagio#disagio giovanile#Benasayag#Schmit#caso Chucchi#omicidio Chucchi
9 notes
·
View notes
Quote
Paradossalmente, alla crisi del principio di autorità non corrisponde affatto una messa in discussione dell’autoritarismo. Anzi, proprio questa crisi apre la strada a varie forme di autoritarismo. Una società in cui i meccanismi di autorità sono indeboliti, lungi dall’inaugurare un’epoca di libertà, entra in un periodo di arbitrarietà e di confusione. Questa società, infatti, oscilla costantemente tra due tentazioni: quella della coercizione e quella della seduzione di tipo commerciale. Così alcuni insegnanti cercano a volte di ottenere l’attenzione dei loro allievi mediante astuzie e tecniche di seduzione, perché la sola idea di dire “Mi devi ascoltare e rispettare semplicemente perché io sono responsabile di questa relazione” sembra ormai inammissibile. In nome della presunta libertà individuale, l’allievo o il giovane assumono il ruolo di clienti che accettano o rifiutano ciò che “l’adulto-venditore” propone loro. E quando questa strategia fallisce, non rimane altra via d’uscita che quella di ricorrere alla coercizione e alla forza bruta. In realtà queste due tentazioni non sono altro che due varianti dell’autoritarismo provocato inevitabilmente dalla relazione di simmetria tra giovani e adulti. Non deve sorprendere che in tali condizioni si sviluppi la violenza, perché una relazione di questo tipo può fondarsi unicamente su un rapporto di forza (anche se si tratta di forza di seduzione o di convinzione). L’autoritarismo infatti non si fonda sul principio del rispetto di una persona che agisce “in nome della legge” (legge che, alla fine, ci unisce perché tutti le dobbiamo ubbidienza, e ci protegge). Con l’autoritarismo colui che rappresenta l’autorità si impone all’altro grazie alla sua forza, che è l’unica garanzia e l’unico fondamento della relazione. Il principio di autorità si differenzia dall’autoritarismo in quanto rappresenta una sorta di fondamento comune ai due termini della relazione, in virtù del quale è chiaro che uno rappresenta l’autorità e l’altro ubbidisce; ma allo stesso tempo è convenuto che entrambi ubbidiscono a quel principio comune che, per così dire, predetermina dall’esterno la relazione. Il principio di autorità è quindi fondato sull’esistenza di un bene condiviso, di un medesimo obiettivo per tutti: io ti ubbidisco perché tu rappresenti per me l’invito a dirigersi verso questo obiettivo comune, perché so che questa ubbidienza ti ha permesso di diventare l’adulto che sei oggi, come io lo sarò domani, in una società dal futuro garantito. Oggi però il futuro non offre nessuna garanzia. E quando un giovane chiede “Perché devo ubbidirti?” molti adulti sono incapaci di rispondere chiaramente: “Perché io sono tuo padre... Perché io sono il tuo professore . Se il giovane non è sedotto o dominato, non vede nessun motivo di ubbidire a questo suo simile che pretende di meritare il rispetto. In nome di cosa, in nome di quale principio? È proprio questa la domanda cruciale in cui si cristallizza il problema dell’autorità: “In nome di cosa?”. In nome di quale principio comune due partner, in una data situazione, accetteranno un rapporto gerarchico o di autorità, senza che questo degeneri trasformandosi in autoritarismo? Quando parliamo di crisi ci riferiamo proprio alla crisi di questa relazione.
Miguel Benasayag, Gérard Schmit, L'epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, 2004 [Libro elettronico]
[ Edizione originale: Les Passions tristes. Souffrance psychique et crise sociale, La Découverte, 2003 ]
#Miguel Benasayag#Gérard Schmit#L'epoca delle passioni tristi#autorità#principio d'autorità#autoritarismo#scuola#politica#relazioni#società#sociologia#crescere#adolescenza#populismo#populismi#populisti#antipolitica#saggistica#saggi#letture#leggere#citazioni#psicologia#libri#fiducia#futuro#rispetto#rispetto reciproco
21 notes
·
View notes
Quote
Quando qualcuno esce in strada sulla sedia a rotelle, incrocia gli sguardi ambigui e imbarazzati dei passanti: evitano di guardarlo o lo guardano con un “rispetto” esagerato. In effetti, lo sguardo è pieno di imbarazzo perché l’altro, che si muove stando seduto, esibisce qualcosa che ci sembra essere la sua essenza fondamentale, la sua etichetta-natura, quella che tutti nascondono, quella che, come tutti sappiamo, separa nettamente gli spazi definiti dallo sguardo privato e da quello pubblico; sarebbe come guardare l’altro in una sorta di nudità forzata. Ecco perché si sospetta in questo sguardo un elemento di oscenità. Questa dinamica dello sguardo è talmente codificata in ogni cultura che entra a far parte dell’educazione dei bambini. Si assiste spesso alla scena di un bambino che guarda un nano, un disabile o qualcuno che porta le stigmate della differenza; lo fissa, e l’adulto gli insegna il limite dello sguardo: “Non bisogna guardare in quel modo”. L’altro è lì davanti, il bambino può vederlo, ma, come gli è stato insegnato per le parti intime del suo corpo, deve imparare a non guardare ciò che non deve essere visto, o fare finta di non vedere ciò che l’altro è costretto suo malgrado a mostrare. È il “miracolo” dell’etichetta: produce l’impressione che l’essenza dell’altro sia visibile. A quel punto, l’altro non è più una molteplicità contraddittoria che esiste in un gioco di luci e di ombre, di velato e svelato, ma diventa immediatamente visibile e riconoscibile. Si è convinti, grazie all’etichetta, di sapere tutto sull’altro, chi è, cosa desidera e come è strutturata la sua vita, perché l’etichetta non si limita a classificare, ma stabilisce un senso, una sorta di ordine nella vita di chi la porta. Dobbiamo allora chiederci: cosa sappiamo realmente dell’altro quando conosciamo la sua etichetta? Il problema sta proprio nel fatto che il sapere (savoir) si confonde con il ciò che è dato da vedere (çà a voir).
Miguel Benasayag, Gérard Schmit, L'epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, 2004 [Libro elettronico]
[ Edizione originale: Les Passions tristes. Souffrance psychique et crise sociale, La Découverte, 2003 ]
#Miguel Benasayag#Gérard Schmit#L'epoca delle passioni tristi#disabilità#relazioni#società#psicologia#citazioni#leggere#letture#saggistica#saggi#rispetto reciproco#rispetto#futuro#libri#fiducia#disagio
18 notes
·
View notes
Quote
Alcuni anni fa Marc, un bambino di dieci anni, è venuto in ospedale per un colloquio. Come accade spesso in questi casi, il bambino preoccupava molto le persone che lo circondavano. La famiglia si era decisa a chiedere un colloquio in seguito a un’esperienza negativa in una colonia di vacanze dove un certo comportamento, che fino a quel momento era passato più o meno inosservato, era “esploso”. Un lunedì mattina accolgo quindi questo bambino con i suoi genitori, visibilmente agitati (come la maggioranza dei genitori che accompagnano il figlio in un servizio di psichiatria, la loro angoscia è raddoppiata dalla paura implicita di essere giudicati: “Siamo dei bravi genitori? O saremo considerati delle persone che non hanno saputo educare i loro figli al punto che adesso, per il loro bene, la società dovrà occuparsi di loro?”). Mi raccontano che tutto è cominciato nella colonia di vacanze in cui Marc rifiutava di lavarsi nudo di fronte agli altri bambini. Poi Marc stesso mi spiega che, anche a casa, si fa la doccia vestito con una specie di camicione e che si insapona attraverso il sottile tessuto. Mi spiega poi che gli istruttori della colonia erano molto turbati per quello che raccontava. Marc aveva infatti spiegato, riprende la madre, di essere l’imperatore di un pianeta chiamato Orbuania e che, come imperatore di questo pianeta, veniva ogni giorno sulla terra in osservazione. Ma ogni notte lasciava il suo corpo e tornava nel suo pianeta dove riprendeva la sua normale vita di imperatore. A quel punto chiedo ai genitori se Marc avesse già parlato loro di tutto questo e rispondono che sì, naturalmente gliene aveva parlato. Marc aveva inoltre scritto una serie di quaderni in cui descriveva la vita di Orbuania, che aveva fatto leggere ai suoi insegnanti, i quali trovavano, come del resto i genitori, che sebbene il bambino fosse un po’ ossessionato dalla sua storia, rivelasse in fondo solo di possedere un’immaginazione un po’ troppo fervida.
E’ necessario precisare che Marc aveva rivelato, nei vari test a cui era stato sottoposto in ospedale, un’intelligenza superiore alla media. E agli psicologi che gli avevano sottoposto i test aveva dichiarato di voler parlare del suo impero con qualcuno, ma che non voleva essere trattato “psicologicamente”. Gli ho chiesto perché. Dall’alto dei suoi dieci anni, mi ha risposto che gli psicologi sono persone che non capiscono nulla delle cose, che interpretano tutto e che lui invece desiderava parlare, ma in modo più complesso e profondo, con un adulto che non lo catalogasse. Non credevo alle mie orecchie: quel bambino mi stava dicendo che non voleva essere trattato come un sintomo. Mi diceva molto chiaramente che desiderava parlare, ma che quella conversazione non doveva cadere in un riduzionismo tecnico. Gli dissi immediatamente che io ero uno psicologo, ma che ero anche un filosofo, che la sua storia mi interessava molto e che desideravo parlare con lui anche se non capivo bene perché volesse parlare con qualcuno. Penso che all’inizio il desiderio di comunicare la sua visione delle cose nascesse da due ragioni ben distinte: da una parte, le persone reagivano male quando lui parlava del suo impero; e dall’altra, siccome in questa storia non tutto gli era completamente chiaro, l’opinione di qualcuno che non lo giudicasse gli era preziosa. Tale fu il nostro primo patto, che restò intatto per oltre dieci anni di lavoro comune e di amicizia reciproca. “Signor imperatore”, è così che ho cominciato molto presto a chiamarlo. Quell’appellativo è diventato il suo nome, o meglio il suo soprannome, che accettava con un certo piacere. E non ero il solo a chiamarlo così: le segretarie, vedendolo arrivare per la sua ora di discussione (non è mai stata una seduta), lo salutavano, senza alcun tono di scherno, dicendogli: “Buongiorno signor imperatore!
Un po’ alla volta, Marc mi descriveva il suo pianeta. Parlavamo anche della difficoltà di vivere sulla Terra, una difficoltà che sotto molti aspetti ci accomunava — con lo svantaggio per me che io, contrariamente a lui, non sono imperatore neanche per qualche ora al giorno. Fin dai primi incontri ho chiesto a Marc cosa pensasse della realtà di Orbuania. Sviluppò a questo proposito una teoria che non è mai cambiata nel corso degli anni, anche se con il tempo si è affinata. Orbuania e le sue costellazioni, i pianeti che dipendevano dal suo impero e i suoi nemici esistevano davvero, ma non poteva dimostrarlo. Mi proponeva quindi di adottare, a proposito dell’esistenza del suo impero, la “scommessa di Pascal” riguardo all’esistenza di Dio. Si può immaginare il mio stupore (e non sarebbe stato l’ultimo!) quando udii una tale proposta uscire dalla bocca di un bambino di quell’età! La realtà di Orbuania non dipendeva da una credenza personale, ma dal grado di esistenza determinato dalla necessità che un tale oggetto esistesse...
Qualche anno dopo, quando Marc cominciava ad avere il profilo del matematico che è oggi, ha partecipato come uditore ad alcune riunioni, da me coordinate, con due ricercatori (un matematico e un fisico), in vista della stesura di un libro ‘di logica matematica. Tra i soggetti che affrontavamo c’era il problema ontologico dello statuto di esistenza dell’oggetto della scienza. L’imperatore offriva il suo parere sui teoremi fondamentali di Gòdel e di Cohen, tra gli altri. E appena poteva ci dava notizie di Orbuania, cosa che incuriosiva al massimo, come si può immaginare, gli scienziati miei complici, assolutamente incapaci di definire ciò che “esiste” o meno, e perfino di saper dire più o meno cosa questa parola significhi. Un giorno ho vissuto un episodio piuttosto comico con l’imperatore. Era un pomeriggio d’estate e faceva molto caldo al Centro; quando Marc arrivò gli proposi di andare a bere qualcosa al bar, come facevamo abbastanza spesso. Al bar quando il cameriere viene a prendere l’ordinazione, chiedo a Marc: “E lei, cosa desidera, signor imperatore?”. Marc risponde e, quando il cameriere si allontana, mi dice in tono protettivo: “Vede, Benasayag, a me non dà nessun fastidio, ma se continua a chiamarmi ‘signor imperatore’ in pubblico, finiranno per pensare che lei è un po’ matto” — e accompagna l’affermazione con un gesto esplicito, puntando l’indice sulla tempia e facendolo ruotare su se stesso. Poco per volta imparavo a capire quando potevo chiamarlo signor imperatore. E lui da parte sua imparava, probabilmente insegnandolo a me, che non tutti sono in grado di capire le interessanti informazioni sul suo pianeta, per la semplice ragione che poche persone sono in grado di comprendere d’acchito i Pensieri di Pascal. Questa storia non deve farci dimenticare ciò che non è ancora stato detto, cioè che Marc non è mai stato medicalizzato, che non è mai stato ospedalizzato in un reparto di psichiatria, né etichettato e non è nemmeno mai rientrato in un programma di integrazione... Solo quando è entrato all’École normale supérieure, dopo aver fatto Matematica superiore e Matematica speciale, gli ho suggerito di dedicarsi alla ricerca anziché all’insegnamento e lui, condividendo il mio parere, ha seguito il mio consiglio. A un certo punto di questa storia con Marc, gli ho proposto di realizzare un breve filmato in cui lui avrebbe descritto il suo impero e spiegato i delicati meccanismi di quel mondo in cui i due sessi non si distinguevano per alcun segno esteriore, essendo entrambi identicamente “piatti”, in cui il partito maggioritario era misogino, in cui le donne (che lui era il solo a poter identificare) erano geneticamente inferiori agli uomini e in cui i membri di un partito anarchico venivano sovvenzionati come clown ufficiali dell’impero. Contrariamente a quanto si potrebbe credere, i racconti di Orbuania non assomigliavano affatto a un romanzo di fantascienza. L’imperatore mi informò piuttosto dettagliatamente, nel corso degli anni, sulla circolazione delle auto, sulle tasse, sull’educazione eccetera. E mi teneva informato sulle interminabili guerre e conflitti che il suo impero intratteneva con le colonie, perché il signor imperatore non era propriamente di sinistra... Marc era molto interessato a realizzare un documentario audiovisivo, a patto che fosse rispettata una condizione preliminare, ovvero che il film non fosse utilizzato come “materiale psichiatrico”. Il documentario poteva essere mostrato a filosofi, ad antropologi o ad altri intellettuali, ma in nessun caso a dei tecnici che non vi avrebbero riconosciuto altro che sintomi, cioè che non vi avrebbero visto, per usare le parole di Marc, “niente”.
Miguel Benasayag, Gérard Schmit, L'epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, 2004 [Libro elettronico]
[ Edizione originale: Les Passions tristes. Souffrance psychique et crise sociale, La Découverte, 2003 ]
#Miguel Benasayag#Gérard Schmit#L'epoca delle passioni tristi#disabilità#Benasayag#società#psicologia#citazioni#leggere#letture#saggistica#saggi#salute#disagio#disagio mentale#disagio psicologico#salute mentale
13 notes
·
View notes
Quote
Di colpo si è creata una tacita gerarchia dei mestieri. Vedendo un giardiniere, ad esempio, non si può più pensare semplicemente: “Quest’uomo ha scelto questo mestiere perché gli piace”. Per i giovani rappresenta una scelta che rimanda molto concretamente a un “orientamento”, ovvero a un fallimento in un determinato momento del percorso scolastico. Lo stesso vale per il muratore o il falegname: non conta che amino o meno il loro lavoro, la loro scelta professionale resta comunque, agli occhi della società, frutto di un insuccesso.
Nella logica di questa selezione “naturale”, un infermiere è uno che “non era in grado di fare il medico”, perché ha perso la gara per arrivare in cima. In questa logica, degna di un allevamento industriale, gli inni alla “differenza” e alla “diversità”, rimarranno dichiarazioni vane e illusorie, alle quali, evidentemente, non crederà nessuno finché non verrà garantito il rispetto della diversità dei percorsi individuali. Questa realtà della selezione, o piuttosto dei “binari morti”, è quella in cui vive e pensa il giovane di oggi. È questo lo schema di riferimento del ragazzo che, a un certo punto, aggredisce la sua insegnante. L’insegnante, dal canto suo, ha ben interiorizzato questa dimensione, ma cerca allo stesso tempo di aiutarlo in un mondo in cui lei stessa non sempre si trova a suo agio. Gli schemi di riferimento del giovane e del professore corrispondono a due visioni della realtà che si sviluppano parallelamente, ciascuna per conto proprio, e che nel momento in cui si incontrano non possono che dar luogo a una catena di fraintendimenti reciproci e quindi inevitabilmente scontrarsi.
Miguel Benasayag, Gérard Schmit, L'epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, 2004 [Libro elettronico]
[ Edizione originale: Les Passions tristes. Souffrance psychique et crise sociale, La Découverte, 2003 ]
#Miguel Benasayag#Benasayag#Gérard Schmit#L'epoca delle passioni tristi#saggistica#letture#leggere#citazioni#società#psicologia#saggi#relazioni#relazioni sociali#rispetto reciproco#futuro#rispetto#scuola#educazione#mestieri#vita#arrivismo#carrierismo#discriminazione#lavoro#mondo del lavoro
5 notes
·
View notes
Quote
Tutto aveva avuto inizio a mezzogiorno, quando tutta la famiglia riunita (padre, madre, fratello e sorella e lo stesso Pierre) pranzava guardando come al solito il telegiornale. Proprio nel momento in cui Pierre sta tagliando la sua bistecca, il giornalista comincia a parlare della mucca pazza. Tutti i “non-malati” continuano a mangiare tranquillamente, perché non sono pazzi, loro... Pierre, invece, smette di mangiare, getta il piatto per terra e comincia a gridare.
In seguito, Pierre mi ha spiegato che gli era capitato quello che gli succede sempre quando cerca di comunicare una cosa veramente importante e urgente: non riesce a spiegarsi e si innervosisce. E quando Pierre si innervosisce... perde davvero la pazienza. Il seguito della storia lo conoscevo già: i famigliari hanno chiamato il pronto soccorso, pensando sicuramente quanto è difficile vivere con un malato mentale, anche se non rimpiangono affatto la decisione di tenerlo con loro — non intendono ospedalizzare Pierre né separarsi da lui, «ma comunque è dura…» Si tratta di fatti “normali”, banali. Ci accorgiamo però che l’unica persona ad aver preso coscienza della notizia sulla mucca pazza e ad averne capìto tutta la portata, è Pierre. È l’unico che non abbia dissociato quello che ascoltava (l’informazione) da quello che viveva. Normale o malato? In fin dei conti per poter continuare a mangiare la bistecca guardando il telegiornale, per vivere tranquillamente, bisogna che tutti i giorni, se non più volte al giorno, le persone “normali” siano capaci di negare la realtà, di pensare che i rischi collegati al fatto di mangiare, di respirare e di esporsi ai raggi del sole riguardino solo gli altri. Si costruiscono in tal modo un’armatura, uno scudo immaginario dietro al quale si credono al sicuro.
Miguel Benasayag, Gérard Schmit, L'epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, 2004 [Libro elettronico]
[ Edizione originale: Les Passions tristes. Souffrance psychique et crise sociale, La Découverte, 2003 ]
#Miguel Benasayag#Gérard Schmit#L'epoca delle passioni tristi#disabilità#Benasayag#saggistica#letture#leggere#citazioni#psicologia#società#saggi#disagio#mucca pazza#propaganda#assuefazione#follia#salute#salute mentale
1 note
·
View note