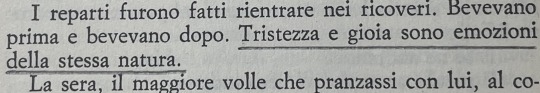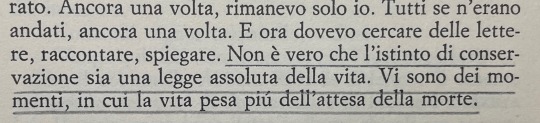#emilio lussu
Text
“ Sono anni molto violenti a Firenze. La città è percorsa da bande di fascisti terribili, duri e fanatici, riuniti in squadracce dai nomi paurosi. Una su tutti, ‘La Disperata’, al cui soccorso arriva ogni tanto ‘La Disperatissima’, composta da squadristi di Perugia che si muovono anche fuori regione spingendosi a fare incursioni fin nelle Marche. Gentaccia pronta a usare bastone e olio di ricino senza alcuno scrupolo, teppisti, criminali come Amerigo Dumini, il capo degli squadristi che un paio di mesi dopo sequestrano e uccidono Matteotti (e che, ricorda Lussu ne La marcia su Roma, era solito presentarsi dicendo «Amerigo Dumini, nove omicidi»).
Il professor Salvadori, per non mettere in pericolo la famiglia, obbedisce alla convocazione senza fare storie e va a piazza Mentana. Entra nel covo alle diciotto del primo aprile [1924] e ne esce a tarda sera, coperto di sangue e barcollante. Max, all’epoca sedicenne, che gli è andato appresso perché aveva delle lettere da impostare alla stazione e l’ha aspettato fuori, ha sentito tre brutti ceffi che ciondolano per la piazzetta dire alcune frasi inquietanti.
«Occorre finirlo».
«Già, ma chi l’ha comandato?»
«L’ordine viene da Roma».
In quel momento Willy esce dal palazzo circondato da una dozzina di fascisti esagitati che brandiscono bastoni. Il padre, ammutolito, è coperto di sangue, e quando Max gli si fa incontro per sostenerlo e aiutarlo riceve la sua razione di botte: i picchiatori non hanno finito, la squadraccia li segue fin sul ponte Santa Trinita, vogliono buttare padre e figlio al fiume. I due si salvano solo grazie a una pattuglia di carabinieri che passa di lì per caso, e quando infine arrivano a casa a mezzanotte, malconci e umiliati, sebbene Cynthia mantenga calma e lucidità e Willy cerchi di minimizzare, lo shock è forte per tutti loro. Scrive Joyce in Portrait:
“Tornarono tardi, e la scena è ancora nei miei occhi. Noi due donne (mia madre e io, mia sorella era in Svizzera), affacciate alla ringhiera del secondo piano, sulla scala a spirale da cui si vedeva l’atrio dell’entrata; e loro due che dall’atrio salivano i primi gradini, il viso rivolto in alto, verso di noi.
Il viso di mio padre era irriconoscibile; sembrava allargato e appiattito, e in mezzo al sangue che gocciolava ancora sotto i capelli, si vedevano i tagli asimmetrici fatti con la punta dei pugnali: tre sulla fronte, due sulle guance, uno sul mento. Mio fratello aveva il viso tutto gonfio e un occhio che pareva una melanzana. «Non è niente, non è niente», diceva mio padre, cercando di sorridere con le labbra tumefatte. Capii in quel momento quanto ci volesse bene.”
In quella sera drammatica che costituisce uno spartiacque nella storia della loro famiglia, Joyce fa tesoro dell’esempio dato dai genitori e dal fratello. Il padre che coraggiosamente cerca di sminuire la portata della violenza e il fratello che lo sostiene forniscono alla Joyce dodicenne «solidità, in quanto alle scelte da fare. Servì a pormi di fronte a ciò che è barbarie e a ciò che invece è civiltà». “
Silvia Ballestra, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu, Laterza (collana I Robinson / Letture), 2022¹; pp. 13-14.
#Joyce Lussu#La Sibilla#letture#leggere#biografie#saggi#Joyce Salvadori Lussu#Silvia Ballestra#Emilio Lussu#anni '20#intellettuali italiani del XX secolo#antifascismo#Firenze#libri#omicidio Matteotti#Perugia#squadrismo#Amerigo Dumini#Marcia su Roma e dintorni#famiglia#Toscana#Storia del '900#primo dopoguerra#politica italiana#Sardegna#Armungia#Partito Sardo d'Azione#Giustizia e Libertà#azionismo#Gerrei
14 notes
·
View notes
Text
Polemiche del 1938 di Emilio Lussu con i comunisti nella Parigi dell'esilio
L’11 e 12 maggio 1938, un convegno a Parigi vara una “Carta ideologica” di GL [Giustizia e Libertà] che ribadisce la formula di «movimento d’azione antifascista e socialista». Il ceto di riferimento, a dispetto delle indicazioni stizzite degli alleati, è il proletariato, industriale e agricolo; l’orizzonte: «un collettivismo di tipo federalista che realizzi la socializzazione dei mezzi di…
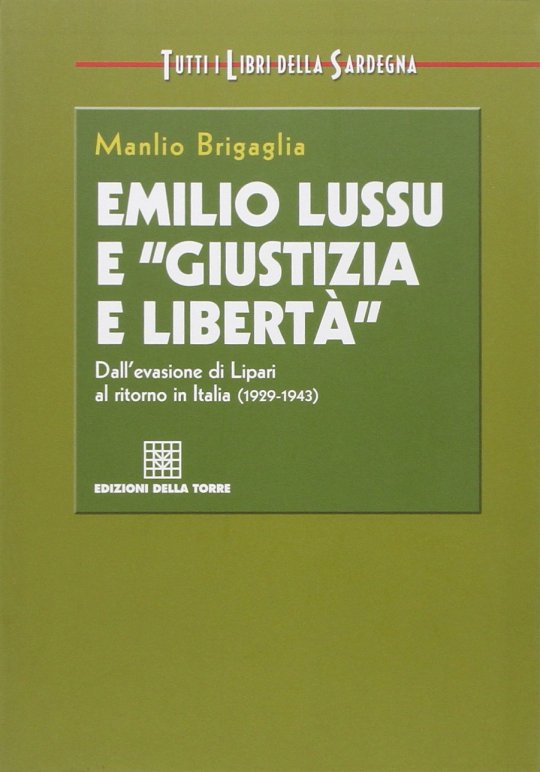
View On WordPress
#1938#antifascisti#comunisti#Emilio Lussu#giustizia#GL#libertà#Matteo Castellucci#operaio#Parigi#PCdI#plemihe#stato
0 notes
Text
Polemiche del 1938 di Emilio Lussu con i comunisti nella Parigi dell'esilio
L’11 e 12 maggio 1938, un convegno a Parigi vara una “Carta ideologica” di GL [Giustizia e Libertà] che ribadisce la formula di «movimento d’azione antifascista e socialista». Il ceto di riferimento, a dispetto delle indicazioni stizzite degli alleati, è il proletariato, industriale e agricolo; l’orizzonte: «un collettivismo di tipo federalista che realizzi la socializzazione dei mezzi di…

View On WordPress
#1938#antifascisti#comunisti#Emilio Lussu#giustizia#GL#libertà#Matteo Castellucci#operaio#Parigi#PCdI#plemihe#stato
1 note
·
View note
Video
youtube
Uomini Contro.....
TONINO GUERRA
Uomini contro è un film del 1970 diretto da Francesco Rosi, liberamente ispirato al romanzo di Emilio Lussu Un anno sull'Altipiano. Ambientato nella prima guerra mondiale,
oggetto dei comizi del generale De Lorenzo, abbondantemente riprodotti attraverso la televisione italiana
Ambientato nell'Altopiano di Asiago durante la prima guerra mondiale, intorno al 1916, il film è incentrato in particolare sul Monte Fior che, inizialmente in mano italiana, viene abbandonato e lasciato in mano all'esercito austriaco, che lo rende un'inespugnabile fortezza.
Tonino Guerra, Raffaele La Capria, Francesco Rosi
Produttore Francesco Rosi, Luciano Perugia
Casa di produzione Prima Cinematografica, Dubrava Film
Fotografia Pasqualino De Santis
Montaggio Ruggero Mastroianni
Effetti speciali Zdravko Smojver
Musiche Piero Piccioni
Scenografia Andrea Crisanti
Costumi Franco Carretti, Gabriella Pescucci
Trucco Massimo De Rossi
Interpreti e personaggi
Gian Maria Volonté: tenente Ottolenghi
Pier Paolo Capponi: tenente Santini
Alain Cuny: generale Leone
Franco Graziosi: maggiore Ruggero Malchiodi
Mark Frechette: tenente Sassu
Nino Vingelli: soldato presunto autoferito
Mario Feliciani: colonnello medico
Daria Nicolodi: crocerossina
Giampiero Albertini: capitano Abbati
Bruno Pischiutta: soldato Baionetta
Alberto Mastino: soldato Marrasi
Tonino Pavan: tenente Pavan
Brunetto Del Vita: colonnello
2 notes
·
View notes
Text
Mussolini sotto assedio
La proclamazione dello stato d'assedio gettò nello sconforto i quadrunviri. Anche qui ci sono testimonianze contrastanti. E' certo che Balbo fu l'unico a votarsi decisamente alla battaglia. De Vecchi, appena giunto a Milano da Roma, dove aveva brigato per trovare una soluzione, veniva deriso dai camerati, che sferzava a sua volta dicendo che combattevano una battaglia ormai perduta. Mussolini aveva dormito a casa, ma quando, all'alba del 28 ottobre, andò al giornale, si trovò nel mezzo di una Milano blindata. La centralissima zona di san Marco, dove aveva sede "Il Popolo d'Italia", era circondata da reparti di polizia e carabinieri con le mitragliatrici puntate. Fin dalla notte la sede del giornale era protetta da 70 squadristi, guidati da Enzo Galbiati, armati di fucili sottratti a un comando militare. Nonostante un'alta barricata formata da gigantesche bobine di carta da stampa e da cavalli di frisia, ogni resistenza sarebbe stata impossibile. Cesare Rossi si scontrò con un maggiore delle guardie regie e ottenne la mediazione di un commissario di pubblica sicurezza che conosceva da tempo per evitare lo scontro armato. Mentre la tensione era al culmine, comparve Mussolini con in pugno un fucile. Ordinò ai suoi di non muoversi, tenendo pronte le armi, scavalcò le barricate e disse alle guardie regie: "Sparate sulle decorazioni, se avete coraggio". Un bel pezzo di teatro, perché il Duce, decorato in guerra, quella mattina non era certo uscito di casa con il medagliere. Questo ritratto così apologetico non trova riscontro nemmeno nelle pagine della Sarfatti, che pure non si trattiene: "La sua figura, la sua parola bastò a dissipare l'ombra...Il giovane squadrista fanatico, che lo seguiva, con occhi di cane adorante, vedendolo scoperto di tutta la persona sopra la barricata, nervosamente puntò il moschetto dietro a lui, in direzione dell'avversario, e la palla sfiorò la testa del Duce, sibilandogli tra i capelli accanto all'orecchio, mentre, da veterano pratico, udito il colpo, si era scostato di scatto. "Ma chi è quell'idiota... "Se non interveniva ridendo a difenderlo, per poco linciavano quel ragazzo, tutto stordito e balbettante alla vista di quanto stava per commettere".
Mussolini continuò ad avanzare. Ecco il racconto rapito di Piero Parini, un cronista del "Popolo d'Italia" che pubblicò i ricordi di quel giorno nel decimo anniversario della marcia: "i fascisti dall'alto delle terrazze e delle case vicine, dove erano appostati, noi della redazione al posto assegnato a ciascuno, concentrammo su quella figura isolata che pareva sospesa nel vuoto gli sguardi degli occhi e dell'anima, come raggi concentrati nel fuoco di una lente. Mussolini era alla mercé di una fucilata della polizia". Adesso riavvolgiamo il nastro e vediamo la versione di Emilio Lussu, scritta nell'esilio francese. Lussu, con garbo malizioso, sostiene che Mussolini nelle ore fatali rimase a Milano, evitando di scendere sia a Perugia che a Roma, perché così sarebbe stato vicino alla frontiera svizzera, nel caso in cui le cose si fossero messe male. Racconta che, quando i fascisti occuparono a Milano il posto di guardia di una caserma degli alpini, si trovarono di fronte un colonnello e un battaglione schierato in armi. "Viva l'esercito!" gridarono. "Molte grazie", rispose il colonnello "ma se non sgomberate entro cinque minuti ordino il fuoco". "Viva l'esercito!" gridarono ancora, presentando le armi. E, al nuovo ordine del colonnello risposero: "No, preferiamo morire". "I vostri desideri saranno appagati". Quando vide che il battaglione innestava le baionette, il capo dei fascisti telefonò a Mussolini che, scrive Lussu, fu protagonista di un animato colloquio con l'ufficiale, conclusosi con gli squilli di tromba che annunciavano l'attacco degli alpini e l'ordine di ripiegamento impartito dal Duce. Lussu, all'epoca dei fatti deputato del Partito sardo l'azione, ricorda che poco dopo fu proclamato lo stato d'assedio e Mussolini, uscendo di nuovo dal suo fortilizio del "Popolo d'Italia, si presentò in prefettura "remissivo come il cittadino obbediente alla legge" e si sentì notificare l'ordine di arresto. Ma i fascisti non fecero in tempo a gridare al tradimento che alle 12.40 di quel 28 ottobre, l'agenzia ufficiale Stefani comunicò la revoca dello stato d'assedio.
La verità sta, come sempre, nel mezzo. Mussolini, si è già visto, era un uomo coraggioso, ma prudente. Un politico accorto che sapeva, al tempo stesso, motivare le masse e tessere accordi nel tetrobottega. Non è credibile né la bravata dello "sparatemi sulle medaglie", né l'immagine denigratoria dell'omino che va in prefettura con il cappello in mano. Anche perché il prefetto Lusignoli era uomo di mondo e si lasciava aperte non una, ma cento porte.
La forza armata fascista era assai più modesta di quanto dichiarato dai suoi capi e militarmente inferiore a quella dello Stato, ma la percezione pubblica era diversa. Lo stesso "Corriere della Sera" del 28 ottobre dava notizia dell'occupazione della questura di Piacenza, della stazione e dell'ufficio postale a Firenze, degli scontri a fuoco a Cremona, della mobilitazione dei Sempre Pronti a Pisa, Lucca e Livorno. E la cosa più impressionante è che, appena si sparse la notizia della revoca dello stato d'assedio, in molte città i fascisti occuparono luoghi strategici senza incontrare resistenza, quasi ci fosse stato un passaggio dei poteri da un'autorità costituzionale a un'altra.
B.V. Perché l'Italia diventò fascista e perché il fascismo non può tornare.
2 notes
·
View notes
Text
Lipari, autore ignoto, luglio 1929
Nella foto da sinistra a destra, Francesco Fausto Nitti, Carlo Rosselli, Emilio Lussu sul motoscafo Dream V in fuga dal confino.
Intorno alle 21.30 del 27 luglio 1929 un motoscafo si avvicinò alla costa di Lipari. Confusa per un mezzo di sorveglianza, la barca venne ignorata. A bordo c'erano il capitano Italo Oxilia, Paul Vonin ai motori e di vedetta Gioacchino Dolci, ex confinato proprio a Lipari. Nitti, Rosselli e Lussu riuscirono a eludere la sorveglianza e a nuoto raggiunsero il motoscafo riuscendo a fuggire fino in Tunisia.
"Una settimana dopo la fuga, a Parigi, Gaetano Salvemini accoglie i tre evasi dal confino: sono gli stessi uomini che, pochi giorni dopo, fondarono “Giustizia e Libertà”." (Dal sito ANPI).
La notizia dell'incredibile fuga fu data solo dopo più di un mese.
“Nella notte dal 27 al 28 luglio sono evasi da Lipari i confinati ex deputato Emilio Lussu, prof. Carlo Rosselli e Francesco Fausto Nitti”.
Dal “Popolo d’Italia” dell’8 settembre 1929.
#lipari #lipariisland #confino #eolie #eolieislands #isoleeolie #aeolianislands #isoleminori #isoleitaliane #mare #isole #island #sea #isola #tirreno #mediterraneo #photography #blackandwhite #bn #vintagephoto #vintagephotography #oldphoto #foundphoto #lostmemories #antiquephoto #oldphotos #oldphotograph #isoleminorifoto #eoliemgz
Fonte primaria: https://laletteraturaenoi.it/2020/01/03/fuga-da-lipari-lincredibile-evasione-di-lussu-nitti-e-rosselli-quel-sabato-27-luglio-1929-2/
Fonte secondaria: https://www.giornaledilipari.it/prima_pagina/eolie-storia-27-luglio-1929-la-grande-evasione/
instagram
0 notes
Text
Anteprime Festival Lussu, Piero Spila giovedì a Cagliari
Cagliari. È dedicato a un film cult per eccellenza, “Johnny Guitar” di Nicolas Ray, il nuovo saggio di Piero Spila, che sarà presentato in prima nazionale giovedì 28 marzo alle 17.30 nel Polo Bibliotecario Falzarego 35 a Cagliari, tra le anteprime del Festival Premio Emilio Lussu.
L’autore dialogherà con il direttore artistico del festival, Alessandro Macis, per illustrare le caratteristiche e il…

View On WordPress
0 notes
Text
Giorno della Memoria a Verona: cerimonia commemorativa all’ex campo di smistamento di Montorio

Giorno della Memoria a Verona: cerimonia commemorativa all’ex campo di smistamento di Montorio.
«Praticare la Memoria aiuta a mantenere in buona salute la democrazia». In queste parole di Liliana Segre è racchiuso tutto il significato del celebrare ogni anno il Giorno della Memoria. Per instaurare in ognuno di noi, dai bambini alle bambine e fino agli adulti una coscienza attiva. Per non dimenticare, e perché i terribili fatti accaduti 80 anni fa non si ripetano mai più.
E oggi all'ex Campo di smistamento di Montorio, ha preso il via l'ampio programma di iniziative legate alla commemorazione del Giorno della Memoria che ricorre il 27 gennaio. Il sito è attualmente gestito dalle associazioni Figli della Shoah e Montorioveronese.it, che hanno pulito e riordinato il luogo della Memoria e che, grazie ad un Patto di sussidiarietà siglato con il Comune, promuovono visite gratuite per far conoscere la tragica storia del luogo.
Il sito, 80 anni fa venne utilizzato come Campo di smistamento Provinciale e come luogo di detenzione di prigionieri politici e per i parenti dei renitenti alla leva. Grazie agli studi e alle ricerche fatte, risultano essere passati 57 ebrei di Roma, che facevano parte di un gruppo da 65, catturati ad inizio febbraio 1944, trasferiti a Verona in località Ponte Cittadella per poi arrivare a Montorio.
Tra loro c'erano nove minorenni, la più piccola Renata, che compì un anno proprio al Campo, e il più grande Bruno Settimio, di 17 anni. Di questi 57 solo 11 si sono salvati, tra cui due minorenni, Ester Calò detta Persichella e Graziella Coen che ha fatto il viaggio di ritorno da Auschwitz con Liliana Segre.
Tra le storie riguardanti i detenuti politici vanno sottolineati Matilde Lenotti, che è stata presidente onorario dell'Anpi di Verona, e Concetta Fiorio, moglie di Emilio Moretto e il padre di Lorenzo Fava. Moretto e Fava fecero parte del Gruppo di Azione Patriottica GAP che organizzò l'assalto al carcere degli Scalzi il 17 luglio 1944.
Durante la cerimonia gli studenti e le studentesse della 3A e 3C della scuola secondaria di Primo grado Luigi Simeoni di Montorio hanno emozionato i presenti recitando individualmente i versi delle poesie "C'è un paio di scarpette rosse" di Joyce Lussu e "Se questo è un uomo" di Primo Levi.
In seguito è stata fatta ascoltare una testimonianza di Leone Fiorentino, nato a Roma nel 1923, una delle tante vittime delle leggi razziali del 1938. Venne arrestato prima dai fascisti e poi inviato nel campo di raccolta di Verona da dove partì a soli 18 anni per Auschwitz. Al seguente link il video della testimonianza.
La cerimonia si è conclusa con i ragazzi e le ragazze della scuola Simeoni che hanno simbolicamente piantato un ulivo, simbolo della pace, al quale hanno appeso nove disegni di colombe a rappresentare i bambini che sono transitati dalla casa di smistamento.
Alla commemorazione sono intervenuti la consigliera comunale Jessica Cugini, la presidente della Circoscrizione 8^ Claudia Annechini, il Consigliere nazionale e responsabile della sezione di Verona Figli della Shoah Roberto Israel, il presidente dell'associazione montorioveronese.it Roberto Rubele, il rabbino di Verona Tominar Corinaldi.
Venerdì 26 gennaio, con partenza con il bus navetta ATV da piazza Bra - vicino al tendone allestito dall'Associazione 'Figli della Shoah, gli studenti delle scuole veronesi, potranno visitare l'ex Campo, dalle ore 11 alle 12.
Iniziativa curata dall'associazione 'Figli della Shoah' insieme al Comune e ATV.
Nei giorni di sabato 27 e domenica 28 gennaio, in due fasce orarie, alle ore 9.30 ed alle ore 11, si svolgono le visite guidate. Per partecipare è necessaria la prenotazione al seguente link....
#notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda
Read the full article
0 notes
Text
"Che ne sarebbe della civiltà del mondo, se l'ingiusta violenza si potesse sempre imporre senza resistenza?"
Emilio Lussu
0 notes
Text
“ Carismatico, coraggioso, indomito, Lussu è un figlio della Sardegna più profonda. Nato ad Armungia nel 1890, laureato in Giurisprudenza a Cagliari, amatissimo comandante della brigata Sassari (nella prima guerra mondiale ha ricevuto ben quattro medaglie dopo quattro anni di trincea per azioni sull’altipiano del Carso e della Bainsizza), ex deputato del Partito sardo d’azione, ha pagato cara, fin lì, la sua militanza, ma ha anche ottenuto una gran bella vittoria su un regime che sembra inattaccabile.
Capelli e occhi neri, slanciato, elegante, occhiali dalla montatura di metallo, baffi e pizzetto, sguardo ironico e tagliente, in quel periodo si fa chiamare ‘Mister Mill’ e vive in clandestinità. Agli occhi dei giovani dell’epoca, lo dice Joyce stessa, è un personaggio leggendario, per le gesta in Sardegna e per la sua avventurosa fuga da Lipari.
I fatti della Sardegna sono questi: la sera del primo novembre 1926, centinaia di fascisti hanno assediato la casa dell’avvocato Lussu. Non è un’azione isolata, è solo una delle rappresaglie che bande di fascisti organizzano in tutta Italia – devastando case, sedi di giornali, picchiando e assaltando – non appena si è diffusa la notizia dell’attentato fallito a Mussolini, avvenuto il giorno prima a Bologna per mano del sedicenne Anteo Zamboni. Lussu, che è un antifascista, ha partecipato alla secessione dell’Aventino dopo l’assassinio di Matteotti, è antimonarchico, ha lavorato a un progetto federalista-rivoluzionario per unire azionisti, repubblicani e socialisti, è nel mirino dei fascisti della sua città: l’ordine è di saccheggiarne la casa e linciarlo sul posto. L’organizzazione dell’assalto, nella sede del fascio, è durata tutta la giornata per cui c’è stato tempo e modo, per Lussu, di ricevere informazioni da voci amiche e preparare una reazione. Gli amici gli consigliano di scappare ma lui decide di restare in casa, situata nella piazza più centrale di Cagliari, lasciandola ben illuminata, «per dare un esempio di incitamento alla resistenza».
Scende in strada per vedere che succede, sente gli squilli di tromba che chiamano a raccolta i fascisti mentre la piazza si fa deserta. Risale, manda via la domestica. La città continua a serrarsi, i negozi abbassano le saracinesche, i cinema si svuotano. Al ristorante vicino casa dove va a pranzare, il cameriere – che è stato un suo soldato durante la guerra e ora è diventato fascista ma nutre ancora grande rispetto del capitano – lo scongiura di partire subito. La sentenza contro Lussu è stata emessa e lo sa tutta Cagliari. Persino gli inquilini del suo palazzo, tra cui un magistrato di Corte d’appello, si chiudono e tacciono terrorizzati.
«Incominciai a preparare la difesa. Un fucile da caccia, due pistole da guerra, munizioni sufficienti. Due mazze ferrate dell’esercito austriaco, trofei di guerra, pendevano al muro». Due giovani amici e compagni si presentano per aiutarlo ma lui li congeda senza discutere. Spegne la luce e si avvicina alla finestra. Assiste alla devastazione della sede della tipografia del giornale «Il Corriere» all’angolo, poi a quella dello studio dell’avvocato Angius.
Quindi risuona il grido «Abbasso Lussu! A morte!».
È sorpreso di riconoscere tra gli assalitori persone che conosce bene, di cui è stato amico o compagno di scuola.
La colonna si divide in tre parti e l’attacco arriva da tre punti: una squadra sfonda il portone e sale dalle scale, una cerca di entrare da un cortile sul retro, l’ultima si arrampica dai balconi. «Confesso che, nella mia vita, mi sono trovato in circostanze migliori. I clamori della piazza erano demoniaci. La massa incitava gli assalitori dalle finestre con tonalità di uragano».
Lussu lancia un primo avviso, grida «Sono armato!» da dietro le persiane.
Poi, mira e spara al primo che arriva sul balcone. Un giovane fascista, Battista Porrà, colpito a morte piomba giù, sul selciato della piazza. Gli altri scompaiono in un lampo.
Nonostante lo svolgimento dei fatti dimostri la legittima difesa (e infatti verrà assolto) e nonostante l’immunità parlamentare, Lussu viene portato in carcere. Ci vorrà un anno prima di arrivare a sentenza ma l’ordine di scarcerazione immediata è seguito da un ordine di domicilio coatto. Lussu è condannato alla pena di cinque anni di confino per misure di ordine pubblico e definito «avversario incorreggibile del regime». “
Silvia Ballestra, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu, Laterza (collana I Robinson / Letture), 2022¹; pp. 31-33.
#Joyce Lussu#La Sibilla#letture#leggere#biografie#Cagliari#Joyce Salvadori Lussu#Silvia Ballestra#Storia del '900#Lipari#intellettuali italiani del XX secolo#antifascismo#lotta partigiana#prima guerra mondiale#Emilio Lussu#Armungia#Sardegna#Partito sardo d’azione#Bainsizza#Benito Mussolini#antifascisti#Anteo Zamboni#federalismo#squadrismo#Aventino#anni '20#Giacomo Matteotti#Giustizia e Libertà#Resistenza#Carso
23 notes
·
View notes
Text
Ventimila firme in 2 giorni per salvare la casa di Joyce Lussu
Nel giro di 48 ore, ha superato le
20mila firme la petizione lanciata dalla giornalista sarda
Federica Ginesu su Change.org per salvare dalla vendita la casa
a San Tommaso di Fermo di Joyce Lussu, “partigiana, medaglia
d’argento al valor militare, scrittrice, attivista antifascista,
storica, giornalista, traduttrice, poetessa, compagna dello
statista Emilio Lussu, una donna che ha attraversato…
View On WordPress
0 notes
Text
0 notes
Text
Joyce Lussu
https://www.unadonnalgiorno.it/la-straordinaria-vita-di-joyce-lussu-partigiana-scrittrice-attivista-femminista/

Partigiana, capitana delle brigate Giustizia e Libertà e medaglia d’argento al valor militare, femminista, poeta, scrittrice, traduttrice, ecologista, divulgatrice, attivista. Questo è stata Joyce Lussu, importante protagonista della storia del ventesimo secolo.
Nacque a Firenze col nome di Gioconda Salvadori Paleotti, l’8 maggio 1912, ma in casa era chiamata Joyce. Lussu è stato, invece, il cognome del marito.
Sua madre era Giacinta Galletti de Cadilhac figlia e nipote di garibaldini, il padre, Guglielmo Salvadori, docente universitario e primo traduttore del filosofo Herbert Spencer. Malmenato e minacciato dalle camicie nere, dopo aver pubblicato articoli contro Mussolini, fu costretto all’esilio con la famiglia in Svizzera, nel 1924.
Joyce Lussu ha passato l’adolescenza all’estero, in collegi e ambienti cosmopoliti, maturando un’educazione non formale, ispirata agli interessi della famiglia per la cultura, l’impegno politico e la propensione alla curiosità, al dialogo, ai rapporti sociali. Vivevano in una casa “abitata più dai libri che dai mobili”.
Laureata in Lettere alla Sorbonne di Parigi e in Filologia a Lisbona, a Ginevra, nel 1933, per la prima volta, conobbe Emilio Lussu, eroe della Prima Guerra Mondiale, famoso per l’audace fuga dal confino a Lipari insieme a Carlo Rosselli, il padre della poeta Amelia Rosselli. Si innamorarono immediatamente ma lui non voleva impegnarsi e condurla nella sua vita errabonda.
Nel 1934 sposò Aldo Belluigi, un giovane ricco possidente fascista di Tolentino, insieme si recarono in Kenya, per raggiungere suo fratello Max che aveva aperto un’impresa agricola di cui divennero soci. Il matrimonio durò un paio di anni e, nel 1936, lei si trasferì in Tanganica, mentre lui, dopo aver perduto tutto il suo patrimonio, fece ritorno in Italia. Tra il 1934 e il 1938 Joyce Lussu ha viaggiato e soggiornato in diverse zone dell’Africa, conoscendo da vicino la realtà del colonialismo, tema da allora affrontato in diverse sue opere.
Tornata dall’Africa e entrata a far parte attiva nel movimento Giustizia e Libertà fece in modo di ritrovare Emilio Lussu, instancabile organizzatore della resistenza degli esiliati. L’amore sopito rinacque e si sposarono con una cerimonia civile che definirono ‘socialista’ in Francia, dove si era concentrato lo sforzo antifascista italiano. Da allora condivisero la vita in clandestinità, la battaglia politica prima e durante la Resistenza, la nascita di un figlio e il resto della esistenza dell’uomo, morto nel 1975.
Nel 1939 ha scritto Liriche, un libro di poesie curato da Benedetto Croce, affascinato dalla sua storia.
Nel 1940, con l’occupazione di Parigi, la coppia trovò riparo a Marsiglia da dove organizzavano partenze clandestine verso gli Stati Uniti. Emilio si occupava della logistica mentre Joyce falsificava documenti.
Attraversarono a piedi i Pirenei fino a raggiungere Lisbona dove entrarono in contatto con i gruppi di resistenza statunitensi e con la società Mazziniana. In Inghilterra ha imparato a usare le armi e le tattiche di guerriglia.
Tornata in Italia entrò nella lotta partigiana col nome di battaglia Simonetta. Ha raccontato questo periodo in Fronti e Frontiere, del 1946.
A liberazione avvenuta, ha vissuto da protagonista i primi passi della Repubblica Italiana e il percorso del Partito D’Azione, fino al suo scioglimento.
Ha militato per qualche tempo nel PSI e, nel 1948, fatto parte della direzione nazionale del partito. Preferì, però, tornare a occuparsi di attività culturali e politiche autonome, insofferente a vincoli e condizionamenti d’apparato.
Ha vissuto per un periodo in Sardegna dove ha organizzato la partecipazione politica delle donne e, nel 1953, contribuito alla fondazione dell’Unione Donne Italiane, da cui presto si è allontanata.
Dal 1958 al 1960, ha continuato a battersi nel segno del rinnovamento dei valori libertari dell’antifascismo, spostando il suo orizzonte di riferimento nella direzione delle lotte contro l’imperialismo.
Sono seguiti anni di viaggi con organizzazioni internazionali della pace, con movimenti di liberazione anti colonialistici.
Tra il 1958 e il 1960 si è impegnata nella traduzione di molti altri poeti resistenti. Ha tradotto poeti albanesi, curdi, eschimesi, l’angolano Agostinho Nieto, il Diario dal carcere di Ho Chi Mihn, gli afroamericani del black power. Tradurre per lei significava far viaggiare le parole e continuare a far circolare i valori della Resistenza.
La sua traduzione delle poesie del turco Nazim Hikmet è, ancora oggi, tra le più lette in Italia.
Il suo impegno nella traduzione è stato un atto politico. Dava voce a chi raccontava l’oppressione di un popolo e approfittando del lavoro culturale, ha aiutato a evadere prigionieri politici, ha marciato con i guerriglieri e organizzato la fuga della moglie di Hikmet con il figlio. Grazie al poeta turco è entrata a conoscenza della questione curda e si è recata in Kurdistan dove ha incontrato la resistenza dei peshmerga e il popolo “costretto a vivere da straniero nel suo territorio” (come lo ha definito nell’autobiografia Portrait).
Dalla metà degli anni Sessanta ha sposato la causa del popolo curdo che l’ha condotta nel mondo e, soprattutto, nelle scuole.
Dall’esperienza terzomondista (con Mario Albano aveva fondato, nel 1966, l’ARMAL, Associazione per i rapporti con i movimenti africani di liberazione) derivò, a partire dagli anni settanta, il suo impegno per la riscoperta e la valorizzazione della “altra storia”, quella delle tradizioni locali messe in crisi dalla industrializzazione.
Nel ’68, ha sostenuto le proteste studentesche, si è avvicinata all’ecologismo e preso parte alla lotta femminista degli Anni 70.
Convinta che fosse necessario scrivere una storia delle donne, troppo escluse dalla storia, ha scritto L’uomo che voleva nascere donna. Diario femminista a proposito della guerra in cui racconta il ruolo delle donne nel conflitto e nel suo esito.
Si è interessata alla storia locale, alla questione agraria, alle tradizioni popolari, al sapere femminile, in maniera diretta con la cultura materiale, come aveva fatto in Sardegna tra le donne della Barbagia.
Nel 1976 è stato pubblicato il libro Padre, padrone, padreterno col sottotitolo Breve storia di schiave e matrone, villane e castellane, streghe e mercantesse, proletarie e padrone.
Ha dedicato una parte fondamentale della sua straordinaria carica vitale al rapporto con i giovani e le giovani, nell’ipotesi di un futuro di pace, da costruire con impegno sistematico e conoscenze adeguate del passato, degli errori, delle violenze e delle ingiustizie che non dovevano ripetersi.
Conservando sempre una diffidenza nei confronti delle istituzioni, ha riposto massima fiducia e apertura verso le nuove generazioni.
Ha occupato una parte notevole del suo tempo in scuole di ogni ordine e grado, animando incontri che incrociavano percorsi di storia, poesia, autobiografia, progettualità sociale.
È morta a Roma il 4 novembre 1998.
Sono ancora poche, troppo poche, le persone che conoscono Joyce Lussu, donna rivoluzionaria, sempre in lotta col potere costituito. Indipendente, allergica ai dogmi e agli stereotipi ideologici, dallo spirito indomito, grande anticipatrice di importanti temi politici e sociali.
1 note
·
View note