#letteratura siciliana del '900
Text
“ Due cosche di mafia sono in faida da lungo tempo. Una media di due morti al mese. E ogni volta, tutto il paese sa da quale parte è venuta la lupara e a chi toccherà la lupara di risposta. E lo sanno anche i carabinieri.
Quasi un giuoco, e con le regole di un giuoco. I giovani mafiosi che vogliono salire, i vecchi che difendono le loro posizioni. Un gregario cade da una parte, un gregario cade dall'altra. I capi stanno sicuri: aspettano di venire a patti. Se mai, uno dei due, il capo dei vecchi o il capo dei giovani, cadrà dopo il patto, dopo la pacificazione: nel succhio dell'amicizia.
Ma ecco che ad un punto la faida si accelera, sale per i rami della gerarchia. Di solito, l'accelerazione ed ascesa della faida manifesta, da parte di chi la promuove, una volontà di pace: ed è il momento in cui, dai paesi vicini, si muovono i patriarchi a intervistare le due parti, a riunirle, a convincere i giovani che non possono aver tutto e i vecchi che tutto non possono tenere. L'armistizio, il trattato. E poi, ad unificazione avvenuta, e col tacito e totale assenso degli unificati, l'eliminazione di uno dei due capi: emigrazione o giubilazione o morte. Ma stavolta non è così.
I patriarchi arrivano, i delegati delle due cosche si incontrano: ma intanto, contro ogni consuetudine e aspettativa, il ritmo delle esecuzioni continua, più concitato, anzi, e implacabile. Le due parti si accusano, di fronte ai patriarchi, reciprocamente di slealtà. Il paese non capisce più niente, di quel che sta succedendo. E anche i carabinieri. Per fortuna i patriarchi sono di mente fredda, di sereno giudizio. Riuniscono ancora una volta le due delegazioni, fanno un elenco delle vittime degli ultimi sei mesi e «questo l'abbiamo ammazzato noi», «questo noi», «questo noi no» e «noi nemmeno, arrivano alla sconcertante conclusione che i due terzi sono stati fatti fuori da mano estranea all'una e all'altra cosca. C’è dunque una terza cosca segreta, invisibile, dedita allo sterminio di entrambe le cosche quasi ufficialmente esistenti? O c’è un vendicatore isolato, un lupo solitario, un pazzo che si dedica allo sport di ammazzare mafiosi dell'una e dell’altra parte? Lo smarrimento è grande. Anche tra i carabinieri i quali, pur raccogliendo i caduti con una certa soddisfazione (inchiodati lupara quei delinquenti che mai avrebbero potuto inchiodare con prove), a quel punto, con tutto il da fare coi disertori, aspettavano e desideravano che la faida cittadina si spegnesse.
I patriarchi, impostato il problema nei giusti termini, ne fecero consegna alle due cosche perché se la sbrigassero a risolverlo: e se la svignarono, poiché ormai nessuna delle due parti, né tutte e due assieme, erano in grado di garantire la loro immunità. I mafiosi del paese si diedero indagare; ma la paura, il sentirsi oggetto di una imperscrutabile vendetta o di un micidiale capriccio, il trovarsi improvvisamente nella condizione in cui le persone oneste si erano sempre trovate di fronte a loro, li confondeva e intorpidiva. Non trovarono di meglio che sollecitare i loro uomini politici a sollecitare i carabinieri a un’indagine seria, rigorosa, efficiente pur nutrendo il dubbio che appunto i carabinieri, non riuscendo ad estirparli con la legge, si fossero dati a quella caccia più tenebrosa e sicura. Se il governo, ad evitare la sovrappopolazione, ogni tanto faceva spargere il colera, perché non pensare che i carabinieri si dedicassero ad una segreta eliminazione dei mafiosi?
Il tiro a bersaglio dell'ignoto, o degli ignoti, continuava. Cade anche il capo della vecchia cosca. Nel paese è un senso di liberazione e insieme di sgomento. I carabinieri non sanno dove battere la testa. I mafiosi sono atterriti. Ma subito dopo il solenne funerale del capo, cui fingendo compianto il paese intero aveva partecipato, i mafiosi perdono quell'aria di smarrimento, di paura. Si capisce che ormai sanno da chi vengono i colpi e che i giorni di costui sono contati. Un capo è un capo anche nella morte: non si sa come, il vecchio morendo era riuscito a trasmettere un segno, un indizio, e i suoi amici sono arrivati a scoprire l'identità dell'assassino. Si tratta di una persona insospettabile: un professionista serio, stimato; di carattere un po' cupo, di vita solitaria; ma nessuno nel paese, al di fuori dei mafiosi che ormai sapevano, l'avrebbe mai creduto capace di quella caccia lunga, spietata e precisa che fino a quel momento aveva consegnato alle necroscopie tante di quelle persone che i carabinieri non riuscivano a tenere in arresto per più di qualche ora. E i mafiosi si erano anche ricordati della ragione per cui, dopo tanti anni, l'odio di quell'uomo contro di loro era esploso freddamente, con lucido calcolo e sicura esecuzione. C'entrava, manco a dirlo, la donna. “
---------
Leonardo Sciascia, Western di cose nostre, racconto contenuto in:
Id., Il mare colore del vino, Einaudi (collana Nuovi Coralli, n° 82), 1980⁵; pp. 132-35.
NOTA: La terza raccolta di scritti brevi dell'autore siciliano comparve dapprima nel 1966 col titolo Racconti siciliani, pubblicata in appena 150 copie impreziosite da una acquaforte di Emilio Greco, edite dall’ Istituto statale d'arte per la decorazione e la illustrazione del libro di Urbino. Nel 1973 Einaudi ripropose l’opera ampliata e commentata da una nota dello stesso Sciascia che la considerò quasi un sommario della propria attività letteraria.
#Leonardo Sciascia#Il mare colore del vino#citazioni letterarie#letteratura italiana del XX secolo#faida mafiosa#mafia#Sicilia#Western di cose nostre#cosa nostra#lotta alla mafia#leggere#letteratura siciliana del '900#anni '60#letture#vendetta#libri#criminalità organizzata#onorata società#narrativa#carabinieri#raccolte di racconti#amore#Storia d'Italia del '900#malavita#intellettuali italiani del XX secolo#omicidi#vita di paese#Italia#Mezzogiorno#Sud
1 note
·
View note
Text
Recensione di “L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza

“Non c'è ragione di sperdere le forze nel timore inconsulto."*
Seguite questo consiglio letterario e non lasciatevi abbattere dal pungente odore di Apocalisse che si respira di questi tempi. Confidate nel fatto che la scienza possa presto trovare il modo di rimettere in sesto il mondo e resistete. Nel frattempo, per tenere su il morale e nutrire l'anima, non c'è cosa migliore che dedicarsi a una sana lettura. Ci prendiamo la briga di darvi un consiglio sul prossimo libro da scegliere.
"L'arte della gioia" di Goliarda Sapienza è un romanzo memorabile. Intendiamo dire che al lettore rimarrà certamente il ricordo di tante pagine intense e appassionate. Non sarà mai una lettura "accantonata" nel dimenticatoio perché è raro imbattersi in un'opera che abbina una trama coinvolgente a uno stile sublime. Particolare la scelta di usare a volte la narrazione in terza persona e a volte quella in prima, nonché di effettuare dei salti temporali anche nello stesso paragrafo, riuscendo perfettamente ad accelerare la narrazione senza confondere il lettore.
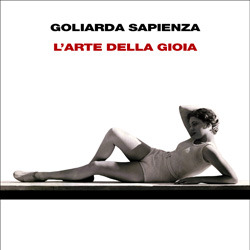
Il nostro ricordo, infatti, non si concentrerà solo sulla vita ribelle della protagonista, ma soprattutto sul modo in cui Goliarda Sapienza ha saputo narrare le sue vicende, usando un lessico fascinoso e ricercato, che in alcune occasioni raggiunge il lirismo. In tal modo, anche gli eventi più tragici e dolorosi, vengono comunicati con delicatezza e leggiadria. Una narrazione "soave", che culla il lettore durante il lungo viaggio tra le vicende di una donna anticonformista, anticlericale, anarchica e ambiziosa. Provocatoriamente, il nome che l'autrice ha dato alla protagonista è Modesta, sebbene ella non lo è mai, in nessuna occasione della sua esistenza, e lotta contro tutto e contro tutti per affermarsi e per vivere intensamente e liberamente in un contesto (la prima metà del '900, in Sicilia) che la vorrebbe relegata all'umile obbedienza. Modesta è una alter ego dell'autrice, sebbene Goliarda Sapienza abbia sempre dichiarato: "lei è migliore di me, sotto tutti gli aspetti". Il suo personaggio si evolve rapidamente dalla timidezza adolescenziale alla determinazione dell'età adulta, durante la quale non presenterà mai incertezze o tentennamenti su quelli che sono i propri valori. Modesta finisce due volte in prigione: la prima volta, da giovinetta, in un convento. Grazie alla propria determinazione e alla sua innata riserva di cinismo, riesce a "evadere" dopo aver sabotato il balconcino dal quale era solita affacciarsi la sua carceriera-madre superiora, provocandone la morte. La sua seconda prigionia avverrà molti anni dopo, in epoca fascista, per aver finanziato un gruppo di amici marxisti. In questa occasione sarà meno forte e, solo l'aiuto della propria compagna di cella, le eviterà un tracollo psicofisico. In mezzo a queste due tragiche esperienze ci sono la sua ascesa sociale (otterrà il titolo nobiliare di "principessa" sposando un disabile di sangue blu), la maternità (anche adottiva), la sua formazione (studierà privatamente per tanti anni e giungerà a frequentare l'università, tra gli sguardi sorpresi di tutti i colleghi, non abituati a presenze femminili in ambito accademico), la sua lotta politica (abbraccerá il marxismo e non scenderà mai a compromessi con le versioni più edulcorate di esso), la sua vita sentimentale (inizialmente drammatica, successivamente passionale e adulterina). Se si volesse trovare un difetto a quello che rimane un bel romanzo, potremmo criticare il fatto che nella seconda parte della storia di Modesta non si raggiunge mai un climax e non si chiude il cerchio narrativo, mediante un evento cruciale. Il personaggio rimane piuttosto statico dalla maturità alla vecchiaia e non completa il suo processo di sviluppo.
Tra gli altri personaggi notiamo una carrellata di caratteri e temperamenti diversi, fra i quali spiccano Carmine, il seduttore, Carlo, l'idealista, Beatrice, l'innocente malinconica, Joyce, l'enigmatica femme fatale e Eriprando, il figlio collerico di Modesta.
Qualcuno ha voluto interpretare "L'arte della gioia" come uno scimmiottamento de "Il gattopardo". L’incorruttibilità del principe di Salina sarebbe così replicata dalla vita di Modesta, una moderna mujer vertical, che non scende a compromessi con la società corrotta e corruttibile. I punti di contatto ci sono, inutile negarlo. Così come sarebbe pretenzioso asserire che la Sapienza abbia raggiunto le vette di Tomasi Di Lampedusa. Se quest'ultimo ha scritto un capolavoro indimenticabile e una pietra miliare della letteratura siciliana, l'autrice catanese è riuscita semplicemente a costruire un romanzo piacevole e a dare voce a una coscienza femminile mai assoggettata. Non ci sembra cosa da poco.
Si nota subito che questo non è un libro scritto per il semplice scopo di intrattenere: ci sono temi importanti, incastonati nella trama, ed emergono passo dopo passo, inducendo il lettore a riflettere e a confrontarsi con essi. C'è storia, c'è politica, ci sono sociologia e psicologia. E poi c'è un elemento che forse ha scoraggiato gli editori, durante gli anni '70, dal pubblicarlo: la sessualità. Sensuale ed erotica, fino a raggiungere picchi di perversione, la Modesta di Goliarda Sapienza, scandalizza e vive intensamente.
I suoi sono amori tormentati, segreti, potenti. Sono amori disinibiti che abbracciano eterosessualità, saffismo e incesto. Ma l'erotismo non degrada mai in pornografia e la volgarità è scongiurata dalla prosa languida di Goliarda Sapienza.

L'edizione di Einaudi, inoltre, è corredata da un'ampia e interessante nota biografica sull'autrice (la cui esistenza merita sicuramente un approfondimento) e da un'analisi del romanzo che ne rivela i retroscena e le traversie per raggiungere la pubblicazione, purtroppo postuma.
Leggetelo e non ne sarete delusi.
"La parola cuore ripetuta dalla sua voce perde il significato ambiguo che me l'ha fatta odiare. E vedo il mio cuore, occhio e centro, orologio e valvola del mio spazio carnale. Nel buio con le palme ascolto il suo pulsare violento che dal seno alle tempie sudate grida di gioia e non si vuole quietare."*
* da “L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza.
Read the full article
0 notes
Text
Sabato 31 marzo ha preso il via Spritz con gli autori, una simpatica iniziativa ideata e promossa da Isabella Borghese presso la libreria Sinestetica, che sarà replicata sabato 14 aprile con Massimo Torre e Luca Ricci, rispettivamente autori di La dora dei miei sogni (Giulio Perrone Editore) e Gli autunnali (La nave di Teseo).
Sorseggiando uno spritz, Isabella Borghese ha presentato Romana Petri e Nadia Terranova e ha chiacchierato con loro cercando di scoprire dettagli e particolari sulle loro modalità di scrittura e sui loro luoghi di ispirazione. Poi la parola è passata a Giulia Peci, del gruppo Leggo Letteratura Contemporanea, che ha presentato Il mio cane del Klondike, appena pubblicato da Neri Pozza. Nadia Terranova, di cui uscirà a ottobre il nuovo romanzo sempre per Einaudi, è stata, invece, raccontata da Simona Mangiapelo dell’Associazione Culturale Caffè Corretto che ha commentato Gli anni al contrario.
È stata una mattinata frizzante e coinvolgente dove si è parlato di libri e di scrittura, dove si è riso e sorriso in un’atmosfera rilassata, con Isabella Borghese che ha dettato i tempi e ha rotto gli indugi chiedendo a Romana e Nadia di raccontare il loro esordio letterario.
“Come ho cominciato?” Nadia Terranova ci pensa un attimo e poi inizia a raccontare: “Sono arrivata a Roma 15 anni fa per frequentare un corso di editoria dopo essermi laureata in filosofia. Volevo scrivere ma sapevo di dovermi fare le ossa e sentivo che mi avrebbe aiutato di più studiare editoria che non scrittura creativa. La mia palestra è stata scrivere le bandelle, le quarte di copertina, perché ho capito che il magma di un libro doveva essere narrabile e seducente. Mi sembrava come quando da piccola scrivevo le lettere a mio padre, che non viveva più con me essendosi separato da mia madre, e dovevo scegliere i fatti salienti della settimana per renderli divertenti e commoventi. Dopo aver imparato tantissimo, sono andata via, ho preso un dottorato, ho fatto altri lavori e mi sono presa un paio d’anni sabbatici per scrivere e pubblicare Gli anni al contrario. Essendo un esordiente, Einaudi mi ha parcheggiata per 5 anni e io, in attesa che venisse pubblicato, ho scritto dei libri per ragazzi perché dovevo sfogare la mia voce narrativa che ormai premeva per esprimersi. Ora scrivo indistintamente per adulti e per ragazzi, dipende dal destinatario che mi viene in mente quando immagino una storia”.
Gli inizi di Romana Petri sono invece molto diversi: “Avevo 22 anni e non sapevo a chi far leggere i miei scritti fino a quando mia madre mi consigliò di proporli al mio scrittore preferito e cosi feci. Contattai Giorgio Manganelli, dopo aver trovato il suo numero sull’elenco telefonico e dopo tre settimane mi chiamò: Signora Pezzetta (ancora non avevo un nome d’arte, chiarisce) lei ha scritto un gran bel libro e vorrei incontrarla. Mi prese un collasso a sentire che Manganelli in persona, il mio idolo letterario, si complimentava con me. Mi armai di coraggio e andai a casa sua. Lui era seduto su una specie di trono mentre io ero in basso, ma non mi sono scoraggiata e dopo aver superato a pieni voti un vero e proprio interrogatorio sulla letteratura inglese, mi disse che avrebbe proposto il libro alla Rizzoli. Poi passarono forse due anni di silenzi, fino a quando finalmente squillò il telefono, inizialmente non capii cosa diceva il tizio dall’altra parte del telefono, poi lentamente realizzai che quello che parlava era un agente letterario e mi stava proponendo un contratto. È iniziata cosi. Poi purtroppo Manganelli scrisse una recensione meravigliosa che segnò il mio destino. Fece il mio nome insieme a quello di Michele Mari definendoci le due promesse della letteratura italiana e mi ha fregato… perché mi sono sposata proprio con Mari”.
Isabella Borghese incalza e chiede a Nadia e a Romana se quando scrivono hanno delle abitudini particolari, magari come Balzac che non poteva fare a meno di bere 50 tazze di caffè al giorno o Schiller che doveva avere un cesto di mele marce sotto la scrivania o come Hugo che scriveva nudo con i vestiti chiusi a chiave nell’armadio per non avere la tentazione di uscire. Ridendo, Romana Petri ci assicura che lei scrive assolutamente vestita perché ha sempre freddo e anche con 40 gradi deve avere lo stomaco coperto. Ma svela di avere un’abitudine particolare: “Quando finisco di scrivere un libro segno il giorno, il mese, l’anno, l’ora e i minuti della prima stesura. Se il numero che esce non mi piace resto inquieta perché ho una certa ossessione per i numeri. Per il resto, giuro, di essere una persona molto normale. Mi dedico alla scrittura creativa quando non lavoro e io lavoro come una pazza, perché questo non è uno sport da signorine”.
Nadia ribatte e confessa di vivere da anni su una poltrona viola e spera di concludere i suoi libri in posti suggestivi. “Sono con la stessa persona da 15 anni e la relazione non finisce perché lui mi fa scrivere e non mi disturba mai. La mia casa è molto piccola, ho provato a scrivere a letto, alla scrivania, mentre cucino, ma solo quando mi sono costruita il mio angolo con la poltrona viola, ho capito di aver trovato il mio posto. La mia scrivania è il computer sulle ginocchia; il mio studio è la libreria che mi fa angolo e mi circonda. Quando non sono a casa, scrivo in albergo e in treno. Ho finito la prima stesura del prossimo romanzo, che uscirà a ottobre per Einaudi, in treno, mio malgrado, perché speravo di finirlo sulla mia poltrona o davanti al Partenone dove sono stata per il mio compleanno, ma purtroppo non è andata cosi: l’ho finito sulle rotaie, entrando in stazione”.
Romana racconta invece di come ha perso il suo studio a casa, piccolo e umido ma pur sempre suo. Il fattaccio è accaduto quel giorno in cui “mio figlio è tornato a casa con due piccioni senza piume, in fin di vita, che non solo sono sopravvissuti, ma hanno preso possesso dello studio. Cosí mi sono trasferita in camera da letto, anzi proprio nel letto, circondata da cuscini. Ora i piccioni sono volati via ma non so se tornerò nel mio studio, forse quando casa sarà ripulita, ma non ne sono sicura. Mi trovo bene a letto tra i cuscini, mi auto-coccolo e ho la mia routine di scrittura: la mattina mi alzo, bevo il caffè, faccio colazione e poi mi rimetto a letto e inizio a scrivere. Vivo con pezzi di carta ovunque, dove fermo le idee che mi vengono e spesso scrivo al buio durante la notte, mentre cerco di dormire, e poi la mattina decifro con molta fatica quello che ho scritto con una scrittura da medium. Quando scrivo un romanzo ho invece un metodo collaudato: scrivo, lo rileggo e poi lo abbandono per almeno un anno. Quando lo riprendo, deve essere ormai lontano da me, tanto da averlo quasi dimenticato, cosí da non ricordarmi alcuni passi e poter iniziare a fare l’editing, indispensabile ma per niente piacevole”.
Nadia scrive anche in biblioteca, dove va “quando sento che al libro manca aria, lo porto a fare una passeggiata come fosse il mio cagnolino. Quando vado a Messina mi porto il computer ma non scrivo neanche una riga. Poi torno a Roma e inizio a scrivere romanzi che sono sempre ambientati a Messina. È come se tornassi a casa per saccheggiare i ricordi, e una volta a Roma apro il bottino e inizio a scrivere”.
Ma scrivere per voi è un mestiere, chiede Isabella Borghese?
Con la consueta e affascinante impulsività Romana non fa finire la domanda che subito risponde: “Un mestiere c’è quando sei pagata a fine mese. Sarebbe molto bello poter vivere di scrittura e in parte ci vivo perché scrivo anche articoli, faccio delle traduzioni, insegno letteratura, ma sarebbe un’altra cosa potersi dedicare esclusivamente alla lettura e alla scrittura. Oggi siamo inondati di libri, ma pochi sono quelli validi. Siamo di fronte a un ossimoro pazzesco: tutti vogliono scrivere, ma nessuno vuole leggere e quindi inevitabilmente i risultati sono mediocri. Bisognerebbe frequentare più corsi di lettura che di scrittura. Come si può prescindere da alcune letture, come Don Chisciotte, Oblomov, come puoi scrivere se non ami leggere? Ecco perché spesso si leggono cose banali che con la letteratura non hanno nulla in comune. La letteratura è altro dalla vita reale, deve essere qualcosa che quando la leggi vai da un’altra parte, perché se rimani qui è inutile quel libro”.
Nadia Terranova interviene con la sua dolcezza siciliana, perché tra le altre cose tiene anche corsi di scrittura e si dice d’accordo con Romana: “anche io vivo di scrittura ma non esclusivamente di romanzi. Mi occupo anche di cose collaterali come le collaborazioni con i giornali e i corsi di scrittura a proposito dei quali, come giustamente dice Romana, spingo molto sull’importanza del leggere che non prescinde dallo scrivere. Bombardo gli aspiranti scrittori di consigli di lettura, assegno compiti e dissemino libri, perché è impossibile scrivere se non si ha un orizzonte in cui anche solo idealmente collocarsi. Quando scrivo sento l’obbligo di sapere che sto compiendo un gesto che prima di me ha compiuto Dostojevski, Steinbeck… io devo pormi l’obiettivo di essere alla loro altezza, poi non ci riuscirò, scriverò magari dei libri mediocri, ma l’importante è tenere alta l’asticella. Non posso scrivere la prima cosa che mi viene in mente, quella non è letteratura, gli scivoloni non sono ammessi, come le frasi scontate e banali…Lo scrittore deve fermarsi e pensare che magari c’è un altro modo di dire una cosa senza essere scontati e che è proprio quell’altro modo di dirla che rende un testo letterario, senza arrivare al virtuosismo. Per esempio la poesia italiana del ‘900 è per lo più scritta con parole di uso comune ma poste in un contesto altro che quando le leggi capisci di non aver pensato a quel verbo o a quella parola in quei termini. Non deve essere la ricerca dell’originalità a tutti i costi, ma neanche la fiera della banalità”.
E la Petri rincara il concetto: “Tabucchi per esempio aveva il dono del togliere, del non detto, usava parole semplici che creavano la magia, che procuravano quello strappo nelle viscere che fa la grande narrativa.
E quindi come scegliete i libri contemporanei da leggere, considerando che ogni giorno gli scaffali delle librerie si riempiono di testi?
Nadia confessa di aver escogitato un trucco: “cerco di non farmi influenzare dalle conoscenze, perché spesso ai festival si incontrano gli scrittori e non sono sempre incontri piacevoli. Allora cerco di scindere perché molti mi sono antipatici e quindi finirei per non leggerli preferendo solo libri di persone gentili e carine, ma spesso le due cose non coincidono. Se si scrive per rivelare un segreto nascosto, per raccontare una parte di noi intima, allora quella voce non coincide sempre con quella persona e smontando questo pregiudizio ho avuto delle belle sorprese, ho letto libri molto belli scritti da persone che nella vita non frequenterei mai. Inoltre mi sforzo di trattare i contemporanei come classici e viceversa, con un classico mi piace capire cosa ci sta dando ancora oggi e faccio lo stesso con un contemporaneo.
Romana Petri invece non ci rivela alcun criterio di scelta ma come un simpatico ciclone passa direttamente e senza indugi a consigliare L’estate del ’78 di Roberto Alajmo e David Machado (autore tra l’altro di Indice medio di felicità) di cui sta leggendo, in portoghese, il suo ultimo romanzo Sottopelle, sperando di riuscire a farlo pubblicare in Italia.
A questo punto Isabella Borghese si vede costretta a interrompere la chiacchierata per motivi di tempo, ma il dispiacere viene subito compensato dall’intervento di Giulia Peci del gruppo Leggo Letteratura Contemporanea.
“Sono felice di aver letto Il mio cane del Klondike di Romana Petri. Non mi sono voluta far influenzare dalla rete e condizionare dalle recensioni e ho deciso di non leggere niente che ne parlasse . Quindi quando ho aperto il libro non avevo idea di cosa avrei trovato. Ammetto che mi ha emozionata tantissimo, l’ho sentito molto vicino, perché è un libro carico di emozioni. La storia racconta il salvataggio di un cane e di un riconoscimento tra un cane e una donna: lei lo incontra per caso davanti alla scuola dove insegna, lui è in fin di vita e lei decide di salvarlo. In un momento storico in cui soccorrere viene considerato un crimine, questo elemento rende questo libro estremamente attuale, perché il cane del romanzo è in un certo senso un immigrato con problemi d’integrazione. È lui il vero protagonista, è l’unico non a caso che ha un nome, Osac, e un cognome e ha una voce tutta sua. Osac è l’anagramma di caos e di caso e questo dice tanto sul personaggio. Tra Osac e la donna nasce un fortissimo rapporto d’amore, esclusivo, totalizzante e travolgente, forse anche esagerato, e l’evolversi di questa storia permette alla salvatrice di fare una serie di riflessioni sui sentimenti, sulla vita e su quello che accadrà. È un libro sull’abbandono, ma anche sulla maternità e su come questa cambia il rapporto tra i due.
“I cani sanno amare, lo sanno fare in modo coraggioso, buono e disinteressato ed è per questo che non si trasformeranno mai, come è successo a Pinocchio, in esseri umani veri.”(Il mo cane del Klondike, ed. Neri Pozza)
È anche un libro di ricordi, e di affetti che perdurano nel tempo, a dispetto della perdita di una persona che rimane talmente presente nel nostro cuore da essere a tutti gli effetti viva.
Talvolta ci si innamora degli uomini sbagliati, tutti ci avvisano che ci farà del male, che sarebbe meglio lasciarlo perdere ma spesso noi donne abbiamo la sindrome da crocerossina e ci immoliamo. È quello che accade alla protagonista umana del libro, capisce subito che sarà un cane difficile, inizialmente vuole salvarlo per poi darlo a qualcun altro, anche il veterinario la mette in guardia, ma sarà travolta da un amore travolgente per un cane travolgente che le sconvolgerà la vita e per il quale sarà pronta a rinunciare anche alle relazioni sociali. È un cane difficile da gestire, un bipolare, un malato psichico.
“Allora ci guardavamo, e insieme recitavamo la miracolosa frase: io sono le mie paure, e dunque non posso avere paura di me. Continuo a usarla ancora, e ogni volta mi ricordo di lui, deluso temperamento d’assalto che nascondeva pero delle paure antiche, contro le quali gli tocco combattere per la vita intera. Cose sue profonde, dell’anima, ferite che, per quanto mi abbia raccontato nel suo lapidario linguaggio in cui le y venivano usate al posto di tutte e cinque le vocali, rimasero per mucosa mai sapute per intero. intuite, certo, a volte addirittura sentite mie, per quanto mi turbavano tutti suoi tormenti”.
Questo libro è un potente concentrato di emozioni e sentimenti diversi: dalla paura dell’abbandono a ciò che prova una donna scoprendo per la prima volta sulla propria pelle la maternità, per arrivare a tutti quegli affetti profondi che spesso ci legano a dei nostri cari scomparsi da anni, siano costoro esseri umani o “disumani”. C’è un’immagine a tal proposito che ho molto amato, ed è quella di “rimestare con un cucchiaio nel proprio cuore per far spazio a tutti i propri affetti … dividendoli e moltiplicandoli”. Inoltre ha una prosa coinvolgente, attenta alle parole e alle lingue in generale, persino a quella del cane, cui alla fine è dedicato addirittura un omaggio .. particolare. Mi ha molto colpito la riflessione che fai sul linguaggio, che è diverso per ognuno di noi, anzi per ogni creatura vivente e che bisogna solo saperlo interpretare per imparare a relazionarsi, usandone uno che sia comprensibile a entrambi. È cosi Romana?
Si, ho inventato un linguaggio gutturale per dare voce a Osac, perché a lui non manca la parola, bisogna solo aver voglia di capirla e non a caso Osac arriva dopo il ciclone (Le serenate del ciclone, Neri Pozza), perché sono stati due i cicloni della mia vita. Ho scritto questo romanzo perché Osac è fascino puro. Quando ci portiamo a casa un animale ci portiamo dentro la natura, basta pensare a un gatto che salta senza fare rumore sulla spalliera e sta con una zampa ciondoloni, lo guardi e vedi la savana. Osac mi è entrato dentro casa e mi ha portato mezzo Klondike e in questo romanzo, che è un esplicito omaggio a Il richiamo della foresta (di Jack London – ndr) io mi sono identificata con Osac, non con la donna che lo salva. Alcuni hanno criticato la fine, ma io credo che i libri che consolano siano spesso da buttare, mentre i libri che danno inquietudine sono da conservare. È un libro che parla di inquietudine, ma c’è anche tanto amore e alla fine tutto si ricompone. Come nella vita, che se ci fermiamo alla baionetta che abbiamo davanti agli occhi, non comprendiamo la battaglia, per parafrasare Stendhal.
È ora il turno di Simona Mangiapelo (autrice del romanzo Di nessuno, Alter Ego edizioni) dell’Associazione culturale caffè corretto che introduce Gli anni al contrario al pubblico in sala per poi porre alla scrittrice alcune domande sul testo.
Questo libro arriva al cuore, chiarisce subito Simona Mangiapelo, anche se in alcuni punti fa male, e la scelta narrativa è puntuale, sai trovare la parola giusta per imprimerti nel cuore e nel ricordi di chi ti legge e proprio per questo ho avuto difficoltà a scegliere solo pochi brani per oggi. I protagonisti sono due ragazzi, Aurora e Giovanni, così determinati a prendere le distanze dai loro genitori al punto da non capire cosa davvero vogliono per loro stessi. S’incontrano e s’innamorano. Nel giorno del ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro e di quello di Peppino Impastato nasce la figlia di Aurora e Giovanni. Si avvicinano lentamente e grazie alla struttura delle pagine lentamente e inesorabilmente si allontanano. Giovanni è tormentato, si sente parte dell’importante movimento storico che vive, ha un’ansia cieca di rivoluzione che si rivela distruttiva e lo porta fino a far uso di eroina. In questo romanzo c’e la lotta armata degli anni settanta, la piaga dell’eroina e il dramma di due persone che vivono insieme, ma che possono essere lontane e profondamente sole.
“Nessuno dei due aveva il coraggio di ammettere la solitudine. La casa, per quanto in miniatura, certi giorni sembrava fin troppo grande e vuota. Si specializzarono in silenzi opportuni, divennero complici e conniventi. Una sera si sedette accanto al marito con una siringa in mano: Non abbiamo mai fatto niente insieme…” (Gli anni al contrario, Einaudi)
Simona Mangiapelo chiede a Nadia Terranova da quale desiderio narrativo è nata questa storia?
“È sempre difficile parlare di questo libro senza parlare del finale, non lo farò neanche oggi, ma è nell’ultima pagina che è depositata la mia necessità di scrivere questa storia. Non è un romanzo autobiografico o biografico, anche se i due protagonisti raccontano i miei genitori e io sono Mara che, per una distorsione narrativa, nasce il 9 maggio. Dopo aver compiuto un lungo percorso personale, per accettare la storia tormentata di Giovanni che si interrompe nel 1989, quando io ero una bambina, ho sentito il bisogno di raccontare la storia di quest’uomo, per liberarla dal tabù di silenzio assoluto che vigeva a casa mia. Mi interessava portare in salvo il destino di Giovanni e capire cosa aveva portato nella mia vita e con chi si confondeva, con quante storie comuni in quel decennio cosi particolare. Mi sono documentata su quegli anni, ma non avevo intenzione di scrivere un romanzo storico, e non volevo dare una parola decisiva. Volevo solo raccontare la storia di una persona che era uno tra tanti, uno come tanti, uno di quelli che, se fosse sopravvissuto, a distanza di anni avrebbe detto, con forte senso di appartenenza, quella è la mia generazione. Un desiderio di appartenenza che noi non abbiamo, ma che per lui rappresentava quell’immaginario che aveva condizionato profondamente le sue scelte private. Se fosse vissuto a Roma avrebbe fatto politica, ma invece viveva a Messina e quello che accadeva in Italia lo viveva in modo sconvolgente per la sua vita privata. Era un’epoca in cui la messa in gioco era personale, fisica direi, anche se Aurora e Giovanni non fanno nulla di eroico. Questa è la cifra dell’anti-eroismo di Giovanni, il contrario di quello che accade ne La Meglio gioventù (film di Marco Tullio Giordana – ndr) dove i protagonisti sono persone comuni, ma sempre in prima linea. I protagonisti de Gli anni al contrario agiscono invece per sottrazione, per quello che non riescono a fare, ma a cui sentono di appartenere. Nelle domande che mi sono fatta scrivendo, mi sono chiesta quando far iniziare la storia di Giovanni. Con la tossicodipendenza, con la malattia, con la decisione di fare politica? Ho deciso di far cominciare la storia con il concepimento di Giovanni, perché tutto nasceva da quel momento. Nato dieci anni dopo gli altri fratelli, ha fin da subito un marchio addosso di differenza e di costante ritardo, per cui Giovanni sa di essere nato per sbaglio, di essere l’ultimo e proprio per questo ha l’esigenza di afferrare qualcosa, ma di non riuscirci.
Cara Aurora… non abbiamo mai usato lo stesso dizionario, parole uguali, significati diversi. Dicevamo famiglia, io pensavo a costruire e tu a circoscrivere. Dicevamo politica, io ero entusiasta e tu diffidente. Io combattevo, tu ti rifugiavi. Se non ci fosse stata Mara ci saremmo persi subito…(Gli anni al contrario, Einaudi)
Una volta hai detto: I grandi non sono che bambini sopravvissuti, e ho pensato a Mara che sembra dirci che malgrado un passato ingombrante e tormentato, nonostante due genitori senza gli strumenti per crescerla, Mara sopravvive malgrado tutto ciò. È questo il messaggio che volevi dare?
“Sì, mi accorgo che sono ossessionata dai sopravvissuti e dal sopravvivere. Infatti il prossimo romanzo è dedicato proprio a loro, perché credo che ognuno di noi lo sia, non c’è nessuno che possa ritenersi immune da questa definizione. Nello scrivere il nuovo libro avevo la tentazione di dedicarlo a qualcuno che non c’è più ma poi ho realizzato che quello che facciamo è sempre dedicato a qualcuno che non è più con noi. La letteratura serve anche a tenere in piedi i fantasmi, a chiamarli vicino, a farli vivere intorno alla poltrona viola, ma poi la storia è letta da chi vive e da chi cerca continuamente un senso per esserci. Io ho vissuto la prima parte della mia vita segnata dal non avere più un padre, dall’averlo visto andare via molto presto, quando è morto era più giovane di me adesso e quindi ogni anno della mia vita, ancora di più dopo aver compiuto 37 anni, è un anno da sopravvissuta. Nella prima parte della vita viviamo in una dimensione mitica, soprattutto noi che siamo cresciuti senza Internet e il mio collegamento con il mondo erano i libri, Diventavo di volta in volta Il richiamo della foresta, Delitto e castigo e tutto quello che leggevo. Ero felice di questa immersione in altri mondi. Non a caso il mio scrittore preferito è Bruno Schulz perché racconta un’infanzia mitica ma non mitizzata e neanche non idealizzata perché l’infanzia è anche un luogo terribile, dove tutto succede in modo atroce, anche perché tutto quello che ci succede, accade per la prima volta: la perdita, la morte di qualcuno, l’abbandono, la paura dell’abbandono, l’amore, il perdersi. Per un bambino è molto importante la prima volta in cui si perde, è quasi una tappa di passaggio della crescita, sia per il figlio che per la madre. Quindi si, credo proprio che tutta la letteratura sia di chi sopravvive, tanto che alla fine di ogni libro potrebbe esserci la frase “sono sopravvissuto per raccontarlo”.
E noi siamo sopravvissuti per leggerlo sottolinea Giulia Peci, un attimo prima che questa splendida iniziativa termini.
Il prossimo appuntamento è per il 14 aprile alle 10 presso la libreria Sintetica con Isabella Borghese, Massimo Torre e Luca Ricci. A presto
Spritz con gli autori: Romana Petri e Nadia Terranova si raccontano e ci raccontano Sabato 31 marzo ha preso il via Spritz con gli autori, una simpatica iniziativa ideata e promossa da Isabella Borghese presso la libreria Sinestetica, che sarà replicata sabato 14 aprile con Massimo Torre e Luca Ricci, rispettivamente autori di La dora dei miei sogni (Giulio Perrone Editore) e Gli autunnali (La nave di Teseo).
0 notes
Text
" Dopo un’assenza quasi totale di cinquanta anni il senatore conservava un ricordo singolarmente preciso di alcuni fatti minimi. «Il mare: il mare di Sicilia è il più colorito, il più aromatico di quanti ne abbia visti; sarà la sola cosa che non riuscirete a guastare, fuori delle città, s’intende. Nelle trattorie a mare si servono ancora i ‘rizzi’ spinosi spaccati a metà?» Lo rassicurai aggiungendo però che pochi li mangiano adesso, per timore del tifo. «Eppure sono la più bella cosa che avete laggiù, quelle cartilagini sanguigne, quei simulacri di organi femminili, profumati di sale e di alghe. Che tifo e tifo! Saranno pericolosi come tutti i doni del mare che dà la morte insieme all'immortalità. A Siracusa li ho perentoriamente richiesti a Orsi. Che sapore, che aspetto divino! Il più bel ricordo dei miei ultimi cinquanta anni!»
Ero confuso ed affascinato; un uomo simile che si abbandonasse a metafore quasi oscene, che esibiva una golosità infantile per le, dopo tutto mediocri, delizie dei ricci di mare!
Parlammo ancora a lungo e lui, quando se ne andò, tenne a pagarmi l’espresso, non senza manifestare la sua singolare rozzezza («Si sa, questi ragazzi di buona famiglia non hanno mai un soldo in tasca»), e ci separammo amici se non si vogliono considerare i cinquanta anni che dividevano le nostre età e le migliaia di anni luce che separavano le nostre culture. "
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, La sirena. Prima pubblicazione nel volume Racconti, Prefazione di Giorgio Bassani, Collana Biblioteca di Letteratura: I Contemporanei n.26, Milano, Feltrinelli, 1961.
#La sirena#Lighea#letture#leggere#classicità#classicismo#Giuseppe Tomasi di Lampedusa#antichità#grecità#estetismo#letteratura italiana del XX secolo#citazioni letterarie#narrativa italiana del '900#mitologia#scrittori siciliani#letteratura siciliana#racconti lunghi#amori estivi#racconti fantastici#Giorgio Bassani#sirene#Torino#Sicilia#Siracusa#golosità#ricci di mare#tifo#tradizioni#scritti minori#Mare Ionio
4 notes
·
View notes
Text
“ Gettando manate di cavoli nella pentola che bolliva Filomena silenziosamente piangeva, piangeva la sua croce di avere un marito che non credeva né a Dio né ai Santi.
- Piangi sulla tua ignoranza, che è più nera della morte.
- I miracoli - insorse Filomena - ci sono i miracoli: i miracoli non li può negare nessuno…
- Questo è il bello della storia: che ci sono i miracoli… Io mi ricordo quando tua madre vide in sogno santa Filomena, e aveva tre numeri in mano: e la vecchia li giuocò e vinse il terno. Santa Filomena che porta i numeri del lotto, già la cosa era da ridere… Ma c'è di peggio: c'è che un prete, che aveva visioni di santa Filomena, per queste visioni è diventato quasi Santo; un prete francese, non ricordo come si chiamasse…
- Lo vedi che santa Filomena c'è?
- Caspita, che testa! Santa Filomena non c'è, bestia che sei: ed è il Papa stesso che te lo dice… E che interesse può avere il Papa, in questo caso, a dirti una cosa per un'altra: per far nascere cagnara?… Santa Filomena non esiste: e basta… Ed il bello è che pur non essendo mai esistita quel prete francese e tua madre, e tanti altri preti, e tante altre donne l'hanno vista così come io vedo te.
- C'è - disse Filomena, ferma come una roccia.
- Non c'è, non c'è mai stata - disse Michele - e la caleranno giù dall'altare: e al posto di santa Filomena metteranno un'altra Santa e tu continuerai a portare i ceri in chiesa, a far dire messe, a votare secondo il consiglio dell'arciprete… E tua madre vincerà qualche altro terno, coi numeri che le darà la nuova Santa… Finché non verranno a dirvi che un tizio aveva sbagliato ancora a leggere una lapide…
Uscì dalla cucina e sedette a tavola, aspettando che Filomena gli portasse i cavoli e l'uovo bollito. Tirò dalla tasca il giornale come ogni sera; lo aprì. Se ne era dimenticato: invece di fare quella discussione inutile, ché discutere con una donna è come lavare la testa all'asino, avrebbe potuto leggersi in pace «L'Unità». Il suo occhio corse per i titoli: Registrata dagli osservatorii di tutto il mondo Esplosa nella Nuova Zemlija la «superbomba» sovietica Disarmo generale! «Quando ci vuole ci vuole: ora lo sanno che la nostra bomba è più forte della loro.» Al XXII Congresso del PCUS Decisa la rimozione di Stalin dal mausoleo.
- Gli occhiali - gridò - portami gli occhiali - che per lo scritto piccolo ne aveva bisogno. Filomena portò subito gli occhiali.
Michele si immerse nella lettura. Il piatto dei cavoli gli fumava davanti. Continua a p. 9 col. 3. Squassò freneticamente il giornale in cerca della pagina nove, della terza colonna. Eccola: «se accaduto per colpa di Stalin… che sia riconosciuto come irrazionale conservare la tomba di Stalin nel mausoleo… La risoluzione è messa ai voti. I delegati alzano il mandato rosso. La proposta di rimozione della salma di Stalin è approvata alla unanimità.»
Violentemente la mano di Michele Tricò lanciò il giornale verso il soffitto; i fogli planarono parte sul pavimento, parte sulla macchina da cucire.
- Che c'è? - domandò Filomena.
Michele affondò la forchetta nel piatto dei cavoli. La moglie lo guardava, preoccupata che si riprendesse la questione della Santa.
- Niente - disse Michele - niente. “
---------
Leonardo Sciascia, La rimozione, racconto contenuto in:
Id., Il mare colore del vino, Einaudi (collana Nuovi Coralli, n° 82), 1980⁵; pp. 86-87.
NOTA: La terza raccolta di scritti brevi dell'autore siciliano comparve dapprima nel 1966 col titolo Racconti siciliani, pubblicata in appena 150 copie impreziosite da una acquaforte di Emilio Greco, edite dall’ Istituto statale d'arte per la decorazione e la illustrazione del libro di Urbino. Nel 1973 Einaudi ripropose l’opera ampliata e commentata da una nota dello stesso Sciascia che la considerò quasi un sommario della propria attività letteraria.
#Leonardo Sciascia#Il mare colore del vino#citazioni letterarie#letteratura italiana del XX secolo#illusioni#superstizione#fede#culto della personalità#verità#fanatismo#religioni#religione#letteratura siciliana del '900#comunismo#L'Unità#anni '60#raccolte di racconti#letture#leggere#narrativa#creduloneria#Prima Repubblica#Sicilia#Chiesa Cattolica#P.C.I.#santità#intellettuali italiani del '900#razionalismo#razionalità#ragione
5 notes
·
View notes
Text
“ -Bene… Lasciamo stare, dunque, questi mezzi da terroristi: noi non siamo anarchici, siamo persone d'ordine… E i conti che abbiamo da regolare, da oggi in poi li regoleremo all'antica.
-I ragazzi però ci avevano preso gusto…
-Certo che l'effetto era grande, non lo posso negare… Ma non ci si può mettere su questa strada… O credi che dobbiamo metterci a lavorare per avere anche noi la bomba atomica?… Discrezione, ci vuole; saggezza, studio, tatto… Il nostro problema, per ora, è quello della commissione d'inchiesta: affrontiamolo con tranquillità di mente… Dunque: il Pitré dice che la parola mafia, quale che sia la sua origine, anche se registrata per la prima volta nel 1868… Da quale dizionario è stata registrata per la prima volta?
-Dal Traina.
-Bravo… Anche se registrata per la prima volta nel 1868 esisteva prima della venuta di Garibaldi… E che esistesse anche la cosa, cioè l'associazione, è provato dal fatto (aggiungo io) che i mafiosi della Vicaria, quei mafiosi che erano chiusi in prigione, fecero nel 1860 un proclama, rivolto agli amici che erano liberi, in cui raccomandavano che si comportassero bene, che non commettessero furti, rapine e omicidi che i Borboni potessero di fronte al mondo, per propaganda come oggi si dice, attribuire alla rivoluzione garibaldina…
-Questa non la sapevo.
-Ci sono tante cose che non sai, e che è bene sapere… La cultura, mio caro, è una gran bella cosa… “
Leonardo Sciascia, Filologia, racconto contenuto in:
Id., Il mare colore del vino, Einaudi (collana Nuovi Coralli, n° 82), 1980⁵; pp. 95-96.
NOTA: La terza raccolta di scritti brevi dell'autore siciliano comparve dapprima nel 1966 col titolo Racconti siciliani, pubblicata in appena 150 copie impreziosite da una acquaforte di Emilio Greco, edite dall’ “Istituto statale d'arte per la decorazione e la illustrazione del libro” di Urbino. Nel 1973 Einaudi ripropose l’opera ampliata e commentata da una nota dello stesso Sciascia, il quale la considerò quasi un sommario della propria attività letteraria.
#Leonardo Sciascia#Il mare colore del vino#citazioni letterarie#letteratura italiana del XX secolo#letteratura italiana del '900#letteratura siciliana del XX secolo#letteratura siciliana del '900#raccolte di racconti#libri#letture#Sicilia#omicidi mafiosi#narrativa italiana del XX secolo#mafia#criminalità organizzata#organizzazioni criminali#stragismo#violenza#Storia d'Italia#narrativa italiana del '900#Racconti siciliani#Urbino#Einaudi#filologia
8 notes
·
View notes
Text
“ Arrivò il procuratore, e subito dopo il medico. Il procuratore ebbi l’impressione di averlo già incontrato: ma non mi riuscì di ricordare quando e dove. Era come quando si incontra uno che abbiamo conosciuto grasso, ed è magro; o magro, ed è grasso. Ma il procuratore non era magro né grasso. Quando il suo occhio cadde su di me, dopo quella che nel loro gergo si dice ricognizione del cadavere, notai che nella sua mente stava avvenendo quel che avveniva nella mia: dalla fissità dello sguardo, dal movimento della mano sul mento. E quando, ad un certo punto, sentì dal cuoco il mio nome, guardandomi come chi è arrivato per primo alla soluzione di un problema su cui l’altro annaspa, mi disse «Ti ricordi? Prima B, anno 1941... O 42?».
«41 ... Sì, ecco, mi ricordo: Schembri».
«Scalambri» precisò.
«Già, Scalambri…».
«Dopo più di trent’anni... E credo ti avrei riconosciuto subito, in un altro posto: ma qui!».
«Sei meravigliato di trovarmi qui. E anch’io, per la verità, di trovarmici…».
Mi prese familiarmente a braccetto. «Raccontami, raccontami…».
Cominciai a sentirmi in disagio. Ho sempre evitato, accuratamente, l’incontro sia coi vecchi compagni di scuola sia con le donne amate nella giovinezza. L’incontro, dico, a distanza di anni. E ora, al disagio di averne incontrato uno dopo più di trent’anni, si aggiungeva quello del luogo in cui mi trovavo, della circostanza, della funzione che il mio vecchio compagno vi assumeva, della familiarità con cui mi trattava. L’essere stati per alcuni mesi nella stessa aula, non significava poi tanto, in ordine alle affinità, agli affetti. Due soli compagni avevano avuto importanza nei miei anni di scuola: uno che avevo poi visto sempre, un altro che non ho più incontrato. Eravamo, tutti e tre, a basso livello di rendimento scolastico; ma leggevamo tanti libri che non avevano niente a che fare con la scuola, andavamo ogni sera al cinema, ci confidavamo amori e disamori... Scalambri, per quanto ricordavo, era invece dei bravi; e dei bravi che non passavano, da copiare, la versione dal greco o dall’italiano in latino (e quest’ultimo era il compito che più odiavamo, come la più insensata delle vessazioni).
Non avevo niente da raccontargli. “
Leonardo Sciascia, Todo modo [Libro elettronico]
[1ª edizione originale: Einaudi, 1974]
#Leonardo Sciascia#Todo modo#libri#letture#leggere#citazioni letterarie#letteratura italiana degli anni '70#narrativa italiana degli anni '70#scuola#ricordi#compagni di classe#memorie#letteratura italiana del XX secolo#letteratura italiana del '900#letteratura siciliana del XX secolo#letteratura siciliana del '900#letteratura siciliana#XX secolo#Sicilia#tempo#ricordi scolastici
27 notes
·
View notes
Text
“ Stavano, con le loro valige di cartone e i loro fagotti su un tratto di spiaggia pietrosa, riparata da colline, tra Gela e Licata: vi erano arrivati all'imbrunire, ed erano partiti all'alba dai loro paesi; paesi interni, lontani dal mare, aggrumati nell'arida plaga del feudo. Qualcuno di loro, era la prima volta che vedeva il mare: e sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella deserta spiaggia della Sicilia, di notte, ad un'altra deserta spiaggia dell'America, pure di notte. Perché i patti erano questi: "Io di notte vi imbarco" aveva detto l'uomo: una specie di commesso viaggiatore per la parlantina, ma serio e onesto nel volto "e di notte vi sbarco: sulla spiaggia del Nugioirsi, vi sbarco; a due passi da Nuovaiorche… E chi ha parenti in America, può scrivergli che aspettino alla stazione di Trenton, dodici giorni dopo l'imbarco… Fatevi il conto da voi… Certo, il giorno preciso non posso assicurarvelo: mettiamo che c'è mare grosso, mettiamo che la guardia costiera stia a vigilare… Un giorno più o un giorno meno, non vi fa niente: l'importante è sbarcare in America".
L'importante era davvero sbarcare in America: come e quando non aveva poi importanza. Se ai loro parenti arrivavano le lettere, con quegli indirizzi confusi e sgorbi che riuscivano a tracciare sulle buste, sarebbero arrivati anche loro, «chi ha lingua passa il mare», giustamente diceva il proverbio. E avrebbero passato il mare, quel grande mare oscuro, e sarebbero approdati agli stori e alle farme dell'America, all'affetto dei loro fratelli zii nipoti cugini, alle calde ricche abbondanti case, alle automobili grandi come case.
Duecentocinquantamila lire: metà alla partenza, metà all'arrivo. Le tenevano, a modo di scapolari, tra la pelle e la camicia. Avevano venduto tutto quello che avevano da vendere, per racimolarle: la casa terragna il mulo l'asino le provviste dell'annata il canterano le coltri. I più furbi avevano fatto ricorso agli usurai, con la segreta intenzione di fregarli; una volta almeno, dopo anni che ne subivano angaria: e ne avevano soddisfazione, al pensiero della faccia che avrebbero fatta nell'apprendere la notizia. «Vieni a cercarmi in America, sanguisuga: magari ti ridò i tuoi soldi, ma senza interesse, se ti riesce di trovarmi.» Il sogno dell'America traboccava di dollari: non più, il denaro, custodito nel logoro portafogli o nascosto tra la camicia e la pelle, ma cacciato con noncuranza nelle tasche dei pantaloni, tirato fuori a manciate: come avevano visto fare ai loro parenti, che erano partiti morti di fame, magri e cotti dal sole; e dopo venti o trent'anni tornavano, ma per una breve vacanza, con la faccia piena e rosea che faceva bel contrasto coi capelli candidi. “
Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio, racconto contenuto in:
Id., Il mare colore del vino, Einaudi (collana Nuovi Coralli, n° 82), 1980⁵; pp. 19-20.
Nota: La terza raccolta di scritti brevi dello scrittore siciliano comparve dapprima nel 1966 col titolo Racconti siciliani, pubblicata in appena 150 copie, impreziosite da una acquaforte di Emilio Greco, dall’ “Istituto statale d'arte per la decorazione e la illustrazione del libro” di Urbino. Nel 1973 Einaudi ripropose l’opera ampliata e commentata da una nota dell’autore, il quale la considerò quasi un sommario della propria attività letteraria.
#Leonardo Sciascia#Il lungo viaggio#Il mare colore del vino#letteratura italiana del XX secolo#letteratura italiana del '900#letteratura siciliana del XX secolo#letteratura siciliana del '900#citazioni letterarie#libri#letture#raccolte di racconti#Sicilia#Gela#Licata#leggere#emigrazione#emigrati#America#storia dell'emigrazione italiana#narrativa italiana del XX secolo#Urbino
5 notes
·
View notes
Text
“ «Io spero, cara sorella, che la votazione non porti al governo i comunisti, né quelli che come i comunisti sono nemici della religione e dell'ordine. I governanti nostri hanno fiducia in De Gasperi e nel partito della democrazia cristiana, senza di De Gasperi l'Italia perderebbe tutto l'aiuto dell'America, perché noi paghiamo tasse forti e sappiamo che il nostro denaro viene impiegato bene, e sempre diamo soldi per l'Italia, in chiesa e nelle associazioni: ma se i comunisti vincessero, i soldi del popolo americano non verrebbero più in Italia, né pacchi potremmo mandare; in America c'è un grande spirito di religione, i soldi degli americani non debbono finire nelle mani dei senza Dio. De Gasperi è un uomo religioso, io ho visto fotografie sue mentre in ginocchio ascolta messa, e il suo partito difende la religione e vuole l'amicizia con l'America...»
«Senti» disse mia madre «anche mia sorella lo dice.»
«E io forse dico che non è vero?» disse mio padre. «Ma se voto per i liberali la stessa cosa è.»
«No che non è la stessa cosa» disse mia madre «l'America solo a De Gasperi ha fiducia.»
«Questo De Gasperi io ce l'ho sullo stomaco» disse mio zio «ma è certo che se i voti non si concentrano su un partito grosso si fa il giuoco che i comunisti vogliono; a me pesa dover dare il voto a De Gasperi, ma che mi metto a disperdere il voto?; tanto, partito d'ordine è.»
«Cara sorella, mi addolora sentire che tuo marito il voto vuole darlo ai liberali, perché io ho domandato a padre La Spina, che è figlio del nostro paesano Michele La Spina che tu certo ricordi, ed è un prete di molta dottrina e mi ha detto che questi liberali sono lontani dalla grazia del Signore, e in certi momenti si mettono d'accordo coi comunisti. Non manca a te fargli vedere i pericoli di un voto dato male, per l'avvenire di vostro figlio e per la salvezza dell'anima...»
«E scrivi che lo do a De Gasperi» disse mio padre «tua sorella è capace di scrivere anche al papa per la salvezza della mia anima.»
«Davvero devi darglielo» disse mio zio «almeno per rispetto a tua cognata che ti ha riempito la casa di roba, e poi il pericolo c'è, non lo vedi quanto sono forti i comunisti?, ieri sera c'è stato un comizio che faceva spavento duemila persone c'erano.»
«...e ringrazio il Signore che ha illuminato in tempo tuo marito, così faccia luce nella coscienza di tutti gli italiani. Qui c'è grande aspettativa, tutti quelli che erano pronti per venire in questo periodo hanno rimandato la partenza, anche quelli che avevano già fatto il biglietto. Appena arriveranno dall'Italia buone notizie anche noi ci imbarcheremo, e già abbiamo i bauli pronti.»
«I bauli» disse mio zio «chi sa quante cose portano.»
Il giorno prima della votazione giunse un telegramma di mia zia, ancora raccomandava di votare il partito di De Gasperi, mio padre fece dubbiose considerazioni sulla serenità mentale di mia zia, poi uscendo seppe che telegrammi simili ne erano arrivati in paese un paio di centinaia, mio zio si fregava le mani. «Che pensata!» diceva «Certo che ad avere soldi vengono belle idee; questi telegrammi arrivando in casa di gente che un telegramma lo riceve quando ci son cose di morte, vedrai che effetto farà: proprio come si trattasse di un caso di morte. E certuni debbono pensarci davvero, se i parenti d'America non mandano più niente è come quando ad un mulo si toglie l'orzo, a mangiare paglia restano.» “
Tratto da La zia d’America in:
Leonardo Sciascia, Gli zii di Sicilia, Einaudi (collana I coralli, n° 106),1962²; pp. 43-45.
#Leonardo Sciascia#Gli zii di Sicilia#Sicilia#Einaudi#letteratura italiana degli anni '60#letteratura degli anni '60#anni '60#letteratura del '900#letteratura italiana#letteratura#anticomunismo#Storia del xx secolo#libri#XX secolo#emigrazione italiana#letture#letteratura siciliana#leggere#emigrazione#emigrazione italiana in America#letteratura italiana del XX secolo#citazioni#narrativa#narrativa italiana#citazioni letterarie#elezioni#politica italiana#Alcide De Gasperi
17 notes
·
View notes
Text
“ L'Etna è un monte solitario, non aduggiato da alcun vicino, libero, in atto di ricevere superbamente l'omaggio del sole che, sorgendo dal mare, subito e fino ai piedi, lo veste di luce.
Zafferana gli è situata sul fianco orientale, in un punto alto seicento metri, dal quale si domina uno spettacolo di vigneti, paesini, città con porti, bastimenti, il mare sconfinato, verso il nord i monti che reggono Taormina, a nord di essi i monti della Calabria, a sud il golfo di Augusta e i monti di Siracusa, dall'alto dei quali, in estate, si affaccia color fuoco il vento dell'Africa.
Già dalla piazzetta, che ha la forma e la ringhiera di un balcone librato nello spazio, lo spettacolo che si offre a chi guarda è vastissimo, ma basta muovere pochi passi sul sentiero che, uscendo dal paese, sale verso i pometi di Cassone, perché la scena s'ingrandisca smisuratamente, accogliendo in sé qualcosa che a mano a mano diventa più grave e severo come il volto stesso del Tempo e del Divino. “
Vitaliano Brancati, Il vecchio con gli stivali, Mondadori (introduzione di Geno Pampaloni, collana Oscar, n° 365), 1971; p. 256.
[ 1ª edizionene: L'Acquario, Roma, 1945 ]
#Il vecchio con gli stivali#Vitaliano Brancati#letteratura#libri#racconti#letteratura siciliana#citazioni#letteratura italiana#letteratura italiana del '900#narrativa italiana del '900#letteratura italiana del XX secolo#narrativa del '900#narrativa#narrativa italiana#leggere#narrativa italiana del XX secolo#citazioni letterarie#letture#mezzogiorno#Etna#Sicilia#Catania#Italia#Italia meridionale#Mezzogiorno d'Italia#letteratura del XX secolo#XX secolo#paesaggi#Bel Paese
6 notes
·
View notes
Quote
Sa la luna cosa le succede quando, battendo a una finestra del Sud, allunga i suoi raggi nella stanza: prima trova una donna seduta quieta quieta con le mani aperte sulle ginocchia, poi trova un cavallo di cartone, la sedia di un bambino, un tavolo, un letto, due poltrone; e se distende ancora di più il suo filo di luce, trova un secondo letto, una scrivania, una libreria, un vecchio che dorme col mento sul petto, le labbra aperte e la pipa fra gli ultimi denti; può ancora trovare una cartina geografica, un grosso orologio a pendolo, fotografie di parenti e di amici, un lavabo, un fucile, una chitarra, e finalmente, se nel tiretto del canterano è arrivato un po' di soldi, tale da aggiungere una nuova comodità, ma non da rimuovere i vecchi incomodi, ecco a una parete l'apparecchio del telefono e, sulla scrivania, un mobile radio.
La porta della stanza è chiusa, e il raggio della luna non può che arrampicarvisi fino a raggiungere il pomo della maniglia e farlo brillare; se potesse, per un filo o per un buco, passare di là dalla porta, vedrebbe una seconda stanza non meno rigurgitante della prima, e forse gli toccherebbe d'illuminare una folla di vestiti tetri come impiccati, e scarpe ingozzate di giornali, con la punta a destra a sinistra in alto in giù avanti indietro; ritirati dal terrazzo, per paura della rugiada, ci sono qui anche vasi di cactus, "teste di vecchio" che, da qualunque parte si guardino, pare abbiano il naso e gli occhi dalla parte opposta.
Una sera, all'età di tre anni, mi sono addormentato nel mio predellino, accanto a una di quelle teste di vecchio; e dopo un minuto, ecco che dal vaso è uscita anche una pipa, un paio di occhiali, un bastone; tutto un vecchio si è estratto a fatica dalla poca terra della coccia e, raddrizzatosi il meglio che potesse, se n'è andato per il balcone, trascinando i piedi e facendomi cenno di tacere; quando mi sono svegliato, il vaso era in effetti vuoto, e la testa di vecchio aveva lasciato al suo posto un piccolo verme bianco.
Vitaliano Brancati, Il vecchio con gli stivali, Mondadori (introduzione di Geno Pampaloni, collana Oscar n° 365), 1971 (1ª ed.ne L'Acquario, Roma, 1945); pp. 46-47.
#Il vecchio con gli stivali#Vitaliano Brancati#Brancati#letteratura#racconti#letteratura siciliana#letteratura italiana del '900#narrativa italiana del '900#letteratura italiana#letteratura italiana del XX secolo#narrativa del '900#libri#narrativa#narrativa italiana#narrativa italiana del XX secolo#leggere#sogni#citazioni letterarie#letture#citazioni#nostalgia#passato#mezzogiorno#Mezzogiorno d'Italia#Italia#Italia meridionale#Sicilia#Catania#XX secolo#letteratura del XX secolo
25 notes
·
View notes
Text
“ «Oh, tu, Riccardo!... Caro Riccardo, come va? Siedi pure!»
Riccardo sedette.
«Cosa c'è di nuovo?», fece il commendatore, tornando a battere il foglio con la punta della penna.
«Nulla di nuovo, sciaguratamente!», rispose Riccardo «Sono sempre senza lavoro!»
«Coraggio!», fece l'altro. «Non è poi un grosso guaio!»
«E invece lo è!»
«Lo è?»
Riccardo spiegò lo strano suono di tamburo funebre che davano i suoi giorni così vuoti di occupazione.
«La maggiore offesa che si possa fare a un uomo - si affannava a ripetere stringendo e torcendo le falde del cappello - è quella di dirgli: "Non c'è lavoro per te!". E come ci si convince subito di essere inutili! Diventiamo fastidiosi e ingombranti! Ci pare sempre di disturbare il lavoro degli altri. E in verità, con quella tua persona che non sa cosa fare, capiti sempre dagli altri, anche dagli amici e dai parenti, mentre essi lavorano! Diventi uno scheletro in cerca di una sepoltura! Cammini in un certo modo, t'appiccichi alle mura delle strade con le spalle e il piede sinistro! Ti sembra che anche il tuo passo abbia un rumore particolare e ributtante! Si dice poi: "Guardate gli uccelli che non si curano del cibo: e il Padre celeste li nutre!". Io ho provato talvolta a non curarmi del cibo, ma il Padre celeste non mi ha nutrito. Uscendo la mattina, vedevo nelle vie rionali montagne di frutta, di carni e di pesci, ma la sera tutto era sparito, e verso di me non era rotolato nemmeno il nocciolo di una ciliegia. A mezzogiorno poi, tutti andavano a chiudersi entro le case, e abbassavano le tendine, come per far qualcosa di nascosto a me. E io mi tiravo dietro le gambe, con quel rumore di passo disonorevole, mentre tutti gli uomini indistintamente facevano la medesima cosa dalla quale io solo ero escluso. Ora io non so sopportare tutto questo! Ridatemi, con un po' di lavoro, l'onore della vita! Lei, commendatore, se è vero che mi vuol bene, con un piccolo sì....»
«Un sì?»
Ma a questo punto, il commendatore somigliò tanto alle figure viste da Riccardo nel sogno, e tale era già in Riccardo la ripugnanza per questa vana mendicità, che il giovanotto s'alzò lentamente e, col cappello stretto fra le mani, ripercorse la sala, aprì una porta, fece un inchino e scomparve.
Uscito Riccardo, il commendatore accese il lampadario del soffitto e, messa nella stanza una luce sfolgorante, buttò sul tavolo la penna, e si stirò con le braccia e le gambe, beatamente. “
Vitaliano Brancati, In cerca di un sì, racconto del 1935 raccolto in:
Id., Il vecchio con gli stivali, Mondadori (introduzione di Geno Pampaloni, collana Oscar n° 365), 1971 (1ª ed.ne L'Acquario, Roma, 1945); pp. 26-27.
#Il vecchio con gli stivali#Vitaliano Brancati#letteratura#libri#racconti#letteratura siciliana#letteratura italiana del '900#narrativa italiana del '900#letteratura italiana#letteratura italiana del XX secolo#narrativa italiana#narrativa#narrativa del '900#leggere#narrativa italiana del XX secolo#citazioni#letture#citazioni letterarie#mezzogiorno#Italia meridionale#Italia#Mezzogiorno d'Italia#Sicilia#Catania#XX secolo#letteratura del XX secolo#disoccupazione#disoccupati#lavoro#dignità
3 notes
·
View notes
Quote
«E pensare che mia nonna usciva con lo scialle!» disse Giovanni, avvolgendosi le gambe e i fianchi, e ridendo sempre più debolmente a misura che il sonno cresceva.
Dentro quello scialle, l’aria si riscaldò subito, ma Giovanni, dormendo, cominciò a sognare i lunghi pomeriggi d’inverno, a Catania, quando i soffi entrano dalle imposte e ti toccano nei più disparati punti, come birichini dal dito freddo; e tu alzi il bavero o abbassi lo scialle, o calchi il berretto, secondo che il freddo ti colpisca il collo, le spalle o i fianchi; e stropicciando forte le mani, dici: «Uhuuu, come quest’anno, il freddo, mai…» La notte di Natale, tutti gli ospiti, nella sala da pranzo, sono imbacuccati e intabarrati. «Non togliete il cappello, prego! Tenete il pastrano!» dice la signora agli ospiti sulla porta. Il padrone di casa ha dipinto con le proprie mani il presepe, e la vecchia sorella lo ha riempito di tutti gli oggetti della sua fede e dei suoi ricordi: arance e mandarini sbarrano le stradette di Betlemme, una fortezza romana minaccia di crollare sotto il peso di un grappolo d’uva D’altra parte, quanti Bambini Gesù! Tutti quelli dei presepi degli anni passati, di cera, di pietra colorata, di zucchero! Nella grotta ne nasce uno ch’è un amore; ma davanti alla grotta ce n’è un Altro, veramente grandissimo, con l’aureola di stagnola, ai piedi del quale la vacca e l’asinello paiono due mosche. E a destra, e a sinistra, sul mare, presso la cisterna, nel castello di Pilato, dieci altri minutissimi Bambini ricevono sui piedi quasi invisibili i baci porti da grosse mani. La zampogna, grande e viva come una mammella di vacca, si gonfia nel corridoio; e tutta la casa trema a quel lamento di pecore… Il cielo, fuori, è limpido, ma il freddo cresce di ora in ora. Gli ospiti trottano per le stanze, mettendosi le mani dentro le ascelle, abbozzando passi di ballo, o addirittura, chi ha lo scialle, caracollando come un cavallo con la gualdrappa. Alcuni, parenti del padrone di casa o amici più intimi, si ficcano in cucina, per mettere le mani e il viso nel vapore delle marmitte e dentro il forno luminoso di pasticci.
«Che tutto sia caldo, caldissimo!» dicono alcune voci. Finalmente, eccoli seduti intorno alla tavola accidentata, perché la lunghissima tovaglia copre tavolini rotondi e tavoli quadrati non tutti della medesima altezza. Con un ultimo brivido di freddo, gli ospiti mettono fuori la punta delle dita per impugnare il cucchiaio. Una zuppiera gigantesca vien collocata, con un ramaiolo dentro, nel mezzo della tavola; e i visi scompaiono in una nuvola di vapore entro cui tutti annusano e si dimenano cercando caldo e odori saporosi. Una dopo l’altra, le cucchiaiate fumanti entrano nelle bocche. «Ahi, ahi!» fanno alcuni, tenendo aperte le labbra e non osando masticare il boccone rovente. Poi inghiottono, con gli occhi fuori delle orbite. «È fuoco!» dicono.
«È magnifico. Magnifico!»
A poco a poco, tutti i visi si arrossano. «Asciugati il naso!» dicono le voci basse delle donne ai mariti. Il caldo cresce, il vino bolle nello stomaco.
Giovanni si svegliò: «Oh, la bestia che sono!… Che stupido sonno ho fatto!… Oh, la bestia che sono!»
La moglie, che dormiva, sorridendo, entro una sciarpa, si svegliò anche lei. «Ho sognato la Sicilia!» disse.
Vitaliano Brancati, Don Giovanni in Sicilia, Bompiani (collana I Grandi Tascabili, n° 277; introduzione di Leonardo Sciascia, a cura di Domenica Perrone), 1993; pp. 139-41.
[1ª ed. originale: Milano, Rizzoli, 1941]
#Vitaliano Brancati#Brancati#Don Giovanni in Sicilia#Leonardo Sciascia#libri#Sciascia#Sicilia#letteratura siciliana#letteratura italiana del '900#letteratura#letteratura italiana#letteratura italiana del XX secolo#narrativa italiana del '900#narrativa del '900#narrativa#narrativa italiana del XX secolo#narrativa italiana#leggere#letture#citazioni#citazioni letterarie#natale#sogni#ricordi#nostalgia#passato#presepe#tradizioni
19 notes
·
View notes
Quote
Il paese era pieno di ragazzi con bluse a spicchi e magliette con topolino; vestiti di inequivocabile taglio americano portavano i grandi, camicie con tasche, cravatte con crisantemi girandole trombe e donne nude; le donne portavano vestiti stampati al modo delle cravatte. «L'America ci veste» diceva mia madre. Veramente tutto il paese era vestito di roba americana, tutto il paese viveva con i soccorsi dei parenti d'America, non c'era famiglia nel paese che non contasse su un parente in America. In un angolo della piazza era persino fiorita la bancarella di un cambiavalute, per un dollaro arrivava a pagare novecento lire, mio padre non cambiava aspettando che andasse più su. Ovunque c'era commercio di roba americana, cibi in scatola e saponette, scarpe vestiti sigarette; Il commercio più forte era quello del medicinali, un flacone di penicillina lo facevano pagare a peso d'oro, bisognava vendere un tumulo di terra per avere un flacone di penicillina, nei casi proprio disperati il medico apriva le braccia e diceva «che volete che vi dica? se riuscite a trovare la penicillina vi posso dare tutta la speranza che volete» e tutti sapevano dove trovarla la penicillina, e a che prezzo, c'erano persone nel paese che invece di farsi mandare sigarette e scatole di carne si facevano mandare medicine dai parenti d'America, e facevano soldi a mucchi Mio padre diceva "scrivi a tua sorella che mandi un pacco di penicillina" e mia madre saggiamente rispondeva «tu la regaleresti a chi ne ha bisogno, e per guadagno finisce che ti buschi la galera».
Tratto da La zia d’America in:
Leonardo Sciascia, Gli zii di Sicilia, Einaudi (collana I coralli, n° 106),1962²; pp. 41-42.
#Leonardo Sciascia#Sciascia#Gli zii di Sicilia#Sicilia#La zia d'America#letteratura#letteratura italiana#letteratura del '900#letteratura degli anni '60#letteratura italiana del XX secolo#letteratura italiana degli anni '60#anni '60#storia del XX secolo#XX secolo#letteratura siciliana#emigrazione italiana#emigrazione italiana in America#citazioni#citazioni letterarie#leggere#libri#letture#narrativa#narrativa italiana#narrativa italiana degli anni '60#penicillina#malattia#malattie#mercato nero#speculazione
7 notes
·
View notes
Quote
Gli sbirri gli facevano carosello intorno senza sapere dove precisamente metter le mani. Ad un certo punto il fiscale ordinò “I libri, buttate giù i libri: o credete che io debba star qui per un mese intero?”
Di Blasi sedette quasi al centro della stanza, di fronte agli scaffali di noce scuro da cui gli sbirri, a bracciate, tiravano fuori i libri. E li posavano sul pavimento, vicino a lui.
«I libri, i tuoi libri» si disse Di Blasi: ad irridere se stesso, a ferirsi. «Vecchia carta, vecchia pergamena: e tu ne facevi una passione, una mania… Per questa gente hanno meno valore che per i sorci, i sorci almeno li mangiano: e anche per te, ora; non ti servono più, ammesso che ti siano mai serviti; che ti siano mai serviti se non per ridurti a questa condizione. E avresti dovuto lasciarli in ogni caso: ora o tra vent’anni, a un parente, a un amico, a un servo… Sì, forse potevi lasciarli al giovane Ortolani: li ama come te, forse più di te… No, non più di te: li ama in un modo diverso, da erudito; per lui non ci sarà il pericolo di finire come tu stai per finire… Non può più farlo, ora: questi libri appartengono al re contro cui cospiravi; come dire che appartengono agli sbirri. Guàrdateli bene, per l’ultima volta… Ecco gli "Opuscoli" in cui hai scritto dell’uguaglianza degli uomini; ecco il "De Solis" che ti ha fatto sognare l’America; ecco l’ "Enciclopedia": uno due tre…» contò i volumi man mano che gli sbirri venivano ad ammucchiarli «ecco l’Ariosto: "Oh gran contrasto in giovenil pensiero, Desir di laude et impeto d’amore!..." Ma non questi versi, non questi… Ed ecco Diderot, cinque volumi, Londra 1773.» Allungò il piede verso la pila più vicina, a farla crollare. Il Damiani che non lo perdeva di vista pur continuando a leggere le lettere che tirava fuori dai cassetti si allarmò, insorse di diffidenza; e ordinò agli sbirri di sfogliare pagina per pagina i libri che Di Blasi aveva fatto cadere.
«Imbecille» pensò Di Blasi «e non capisci che sto cominciando a morire?»
Leonardo Sciascia, Il consiglio d'Egitto, Adelphi (collana «Gli Adelphi» n° 358), 2009; pp. 130-31.
[1ª pubblicazione: Einaudi, Torino, 1963]
#Il consiglio d'Egitto#Leonardo Sciascia#Sciascia#letteratura del '900#libri#letteratura#letteratura italiana#letteratura italiana del XX secolo#letture#letteratura degli anni '60#anni '60#citazioni letterarie#citazioni#leggere#sicilia#letteratura siciliana#letteratura europea del XX secolo#XX secolo#narrativa#narrativa italiana#letteratura europea del '900#libertà#storia#letteratura del XX secolo#letteratura italiana del '900#illuminismo#romanzi#romanzi storici#Palermo#libertà di pensiero
17 notes
·
View notes
Quote
Vennero i parenti di un certo Cardella, ebbero i dollari del congiunto e doni da mia zia: poi mia zia spiegò che Giò Cardella era a Nuova York un uomo potente; raccontò che una volta a lei si presentarono due tipi, chiesero venti dollari "e ogni venerdì vogliamo venti dollari" dissero, e a lei venne l'idea di parlarne a Cardella, e il venerdì successivo Cardella venne allo storo [=store], si mise in disparte e aspettò che quei due si facessero vivi; al momento buono venne fuori e disse ai due "ragazzi, e che vi viene in testa?, questo storo è come se fosse mio, qui nessuno deve venire a fare lo smarto [=smart]" e i due salutarono con rispetto e se ne andarono.
"Certo!" disse il marito di mia zia "quei due proprio Cardella li aveva mandati."
Mia zia saltò come l'avesse punta una vespa. "Sciaràp [=shut up]!" disse "tu ogni volta che parli fai danno, anche a pensarle certe cose non si dicono; e poi, certo è che tutti gli altri che hanno storo pagano: e noi mai abbiamo pagato."
"Ma che è un mafioso questo Cardella?" domandò mio zio che certe cose le capiva a volo.
"Ma che mafioso" disse mia zia fulminando con una occhiata il marito "un galantuomo è; ricco, elegante; protegge i paesani..."
"Già" disse il marito "come ha protetto La Mantia." Mia zia soffocava di collera. Il marito disse "qui in famiglia siamo" e ci raccontò che un tale La Mantia, mezzo ubriaco, aveva insultato Cardella, amici si misero subito in mezzo e la sera stessa li pacificarono, si fecero tante scecchenze [=shake hands], bevvero insieme; ma l'indomani La Mantia giaceva su un marciapiedi con una palla in testa.
"E tu parla" disse mia zia "così te la guadagni anche tu una palla in testa."
Leonardo Sciascia, Gli zii di Sicilia, Einaudi, 1962 [1ª ed.ne 1960]; pp.51-52
#Gli zii di Sicilia#Einaudi#1962#1960#Sicilia#Mafia#New York#mafia americana#letteratura#letteratura italiana#citazioni#citazioni letterarie#letteratura del '900#letteratura italiana del '900#letteratura italiana del XX secolo#letteratura italiana del XIX secolo#letteratura siciliana#omertà#Leonardo Sciascia#Sciascia#mafiosità#letteratura siciliana del XX secolo#letteratura siciliana del '900
16 notes
·
View notes